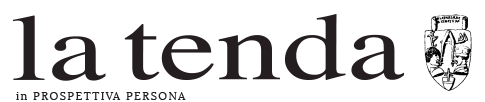Parte II.
In relazione all’affermazione del valore della solitudine dell’artista ovviamente potrebbe essere interessante esplorare sia pure per cenni lineari gli effetti anche espressivi sull’attività e sul prodotto letterario con particolare attenzione a quello italiano. Non sarà possibile per ragioni di spazio farlo qui ma ciascuno di noi intanto potrebbe riflettere sulla similarità e sulle differenze con la situazione attuale in modo da viverla più consapevolmente. Riflettendo su quello che riguarda l’aspetto più specificamente espressivo, o addirittura tecnico della comunicazione letteraria, la rottura dei vincoli tradizionali appare non soltanto nello spostamento della narrativa europea dall’osservazione del mondo esteriore a quello interiore con Proust, Musil, Kafka ma, in maniera forse più rivoluzionaria, nella concezione stessa dell’espressione artistica, nelle poetiche. Si parte dalla rottura del rapporto convenzionale tra oggetto e parola che avevano già operato i simbolisti di fine ‘800, mettendo in moto l’infinita libertà dell’analogia rispetto agli schemi razionalmente fissati dalla retorica tradizionale. Per questa via, passando attraverso la dichiarata eversione della sintassi tradizionale ad opera dei futuristi, arriviamo al flusso di coscienza dell’Ulisse di Joyce dove natura, psicologia e cultura si fondono con l’apparente immediatezza dei moti interiori in livelli elaboratissimi di raffinata cultura. E’ chiaro che veniva già emergendo un’alternativa costruttiva: qualcosa che rompeva frontiere consolidate introducendo il fatto artistico in una dinamica sempre più veloce e che affondava sempre più nel profondo, sempre più aperta a una logica che non era più quella classica delle successioni causa-temporali, ma aveva la libertà dei cerchi, delle spirali infinite che si dilatavano nell’irrazionale di un universo dell’immaginario, sempre più ampio sulla scia dell’irrazionalismo filosofico e dell’acquisizione dell’inconscio, da Bergson a Freud. 2