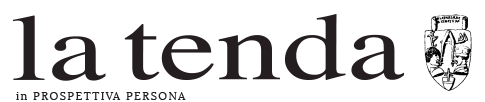L’Italia è considerata la culla del melodramma e in tutto il mondo si eseguono le opere dei compositori italiani. Esistono numerose forme di rappresentazione in musica precedenti, come i drammi liturgici, le feste popolari, i balletti e i drammi pastorali, festeggiamenti in forma teatrale diffusi nelle corti, che nel Rinascimento cominciano a trovare una sintesi a partire dalla Camerata dei Bardi, dando vita al dramma musicale. Successivamente, a partire da Monteverdi, l’opera da spettacolo riservato alle corti signorili divenne un genere molto diffuso; l’Italia diventò il centro di diffusione del nuovo genere musicale e i musicisti italiani erano stimati come maestri di tecnica compositiva, in particolare del contrappunto, che lo stesso Mozart venne a studiare con il maestro Martini. Inoltre alcuni musicisti italiani si trasferivano nelle corti estere e la lingua italiana venne usata per indicare i vari elementi musicali. Tra il Seicento e il Settecento emersero numerosi musicisti le cui opere sono eseguite ancora oggi, ma è nell’Ottocento che il melodramma italiano raggiunse la massima diffusione, con Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi. Tra l’Otto e il Novecento accanto ai numerosi rappresentanti del movimento “verista”, si affermò il genio di Puccini, che ha lasciato “pochi” titoli (in tutto 12 opere) rispetto ai compositori ottocenteschi, ma ha saputo rappresentare i sentimenti e le vicende di personaggi indimenticabili, che si esprimono con melodie immortali.
Giacomo Puccini nacque a Lucca nel 1858 in una famiglia di musicisti, il padre era organista e direttore dell’Istituto musicale di Lucca . Si racconta che Giacomo, dopo aver compiuto gli studi musicali con il maestro Carlo Angeloni, si recò a Pisa a piedi per assistere alla rappresentazione dell’Aida. Si trasferì poi a Milano per potersi perfezionare in quel conservatorio e venne a contatto con la generazione di giovani musicisti e con l’ambiente della “scapigliatura”. E’ di questo periodo la composizione di due opere: Le Villi (1883) e l’Edgar (1889), che rappresentano una sorta di esperimento. La la maturità compositiva di Puccini si manifesta nelle opere successive Manon Lescaut (1893), La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1904), in cui il clima verista si esprime con la poetica del quotidiano e delle piccole cose. In queste opere l’autore dedicò una particolare cura all’equilibrio tra le voci e l’orchestra, e conferì alla partitura musicale un andamento sinfonico, anche con riferimento a Debussy e Fauré, Bizet e Massenet e Wagner. È ancora molto presente la melodia (le “arie” e i duetti “cantati”), rispetto alle opere successive, dove i momenti di cantabilità sono ridotti e assume maggiore importanza il recitato (quasi parlato).
Manon Lescaut è un’opera d’ispirazione wagneriana, dove da un lato si manifesta la grande cura che Puccini ha per la parte orchestrale (v. L’Intermezzo), dall’altro la profonda resa psicologica dell’eroina protagonista, capace di suscitare profonda emozione nel pubblico.
La Bohème rappresenta il punto di rottura con la tradizione ottocentesca, nella misura in cui trasforma le emozioni eroiche di stampo romantico nelle semplici emozioni della vita quotidiana, quella dei giovani squattrinati, dal comportamento libero e irresponsabile, che vivono alla giornata sia materialmente che sentimentalmente.
Tosca consolida la fama del compositore anche all’estero. In quest’opera la partitura musicale sostiene e rafforza i momenti drammatici, che vengono espressi da alcune splendide arie (Recondita armonia, Vissi d’arte, Lucean le stelle), e dai due monologhi di Scarpia.
Nelle opere successive Puccini sperimenta soluzioni originali, soprattutto nel Trittico, e presta molta attenzione al colore locale. Con la Butterfly Puccini dà inizio a una produzione che potremmo definire “esotica”, infatti l’opera è ambientata in Giappone e racconta l’amore di una giovane gheisha per il militare americano, che l’aveva “comprata” per il periodo della sua permanenza in quel Paese; un amore che la porterà al suicidio quando l’uomo dopo una lontananza di tre anni ritorna per reclamare il figlio avuto da lei. Ancora una volta è la figura della protagonista che si staglia con forza sugli altri personaggi per la delicatezza dei sentimenti e per le melodie che l’autore le ha affidato (Vogliatemi bene. Un bel dì vedremo, duetto con Suzuky, Che tua madre).
L’esotismo si concretizza ancora nell’opera successiva La fanciulla del West (1910), ambientata in America; mentre con La rondine (1912) si torna in Europa, ma questa opera, ambientata a Parigi, ha riscosso poco successo e viene rappresentata di rado.
Il Trittico (1918, Suor Angelica, Il Tabarro, Gianni Schicchi ) è costituito da tre soggetti diversi, che l’autore aveva concepito come un insieme, ma che di solito vengono rappresentati separatamente. Delle tre composizioni Suor Angelica è quella che ha avuto minore successo. Al contrario Gianni Schicchi ha avuto numerose riprese. L’opera, ispirata a un episodio della Commedia di Dante, è una composizione brillante e ironica in cui la figura del protagonista è resa con un’arguzia tipicamente toscana.
La Turandot (1924), ambientata a Pechino, è un’opera fantastica, corale – scandita dall’intreccio della folla, dei personaggi e delle maschere – ispirata alla fiaba di Gozzi ed elaborata musicalmente sulla base di melodie cinesi, ascoltate da un carillon. Puccini desiderava creare per questa opera un ambiente musicale autentico perciò studiò la musica cinese e introdusse nella partitura alcuni temi musicali autentici. L’opera rimase incompiuta a causa della morte del compositore e fu poi completata da Franco Alfano sulla base degli appunti del maestro. Toscanini, chiamato a dirigere la Prima assoluta alla Scala (25 aprile 1926), poiché non accettava il completamento realizzato da Alfano, quando arrivò al momento della morte di Liù posò la bacchetta e disse: “L’opera finisce qui, perché è qui che il Maestro è morto”.
La critica ha sempre considerato Puccini un maestro capace di incantare il pubblico con le sue melodie e la sua abilità musicale; un musicista che ha scelto con cura i soggetti delle sue opere e ha saputo dare a ciascuno di essi la caratterizzazione e l’immediatezza che li hanno resi immortali.
Giacomo Puccini si è spento il 29 novembre 1924 a Bruxelles ed è stato sepolto nella cappella della sua villa a Torre del Lago.