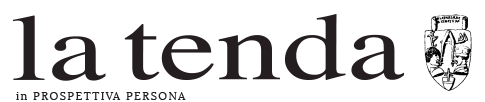Luciano Bianciardi, 1962, Rizzoli Editore, Milano
Romanzo distopico, lo definirei, in questo momento storico in cui l’aggettivo è di moda e ci siamo abituati a scritti e film futuribili e profetici, opere d’arte avveniristiche e sperimentali. Scritto da Luciano Bianciardi 62 anni fa, non ebbe il successo di molti consensi critici, benché molto letto, proprio perché anticipava situazioni e stati d’animo poco diffusi e percepiti allora, molto attuali invece oggi, tanto da diventare contemporaneo. Oggi che l’autore è stato quasi dimenticato, anche perché morto a soli 49 anni nel 1971 e poco letto in tutto questo tempo.
Il fulcro della narrazione è una storia di emigrazione nella Milano del “miracolo economico” dove l’io narrante, che è un alter ego dello scrittore, racconta stralci di esperienze biografiche, delusioni e frustrazioni realmente vissute. Dapprima la disillusione di poter vendicare la morte per lavoro di 43 operai dovuta alla mancanza di sicurezza nel lavoro per la realizzazione di maggiori profitti da parte di una società chimico-mineraria, poi la precarietà del lavoro di traduttore mentre il costo della vita è alto e il bisogno di denaro è cogente. I ritmi di produzione della metropoli sono frenetici e la spinta ai consumi è sempre più incalzante, il traffico stressante per il moltiplicarsi delle auto, le corse snervanti tra lavoro e vita privata, i rapporti umani frettolosi e quelli tra colleghi spesso disumani e cinici, la nebbia grigia soffocante, gli automobilisti aggressivi. Ce n’è abbastanza per gettare in uno stato di prostrazione, di profondo disagio sociale ed esistenziale.
Nelle ultime pagine del romanzo, il protagonista riflette su cosa direbbe se tornasse al suo paese:”…lassù mi hanno ridotto che a fatica mi difendo, lassù se caschi per terra nessuno ti raccatta, e la forza che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche, e se riesco a campare, credi pure che la vita è agra, lassù”. Nella pagina precedente, aveva appena definito la sostanza del “miracolo”, da lui considerato “balordo”: ” Tutto quello che c’è di medio, è aumentato dicono contenti. ….il prelievo fiscale medio, la scuola media e i ceti medi. Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. (…) A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestare i piedi, a tafanarsi l’un con l’altro dalla mattina alla sera”.
Osservava il critico Geno Pampaloni nell’introduzione alla prima edizione BUR del 1974 (quella che possiedo, al prezzo di lire 700, letto da ragazza e riletto da poco) che l’opera può essere anche vista come anticipazione dei motivi che avrebbero sostanziato la contestazione dei giovani nel ‘68 :” C’è la rabbia, anarchico-socialista, contro il potere disumano dell’industria …C’è l’inumanità, o alienazione, cui è ridotta la folla della metropoli…C’è la nausea del traffico e dell’automobile…C’è la pena per il mondo aziendale…C’è il rifiuto del successo e dell’ambiguo meccanismo della selezione…C’è il rifiuto del consumismo…e la contestazione dei valori della civiltà di massa…C’è la satira del mondo editoriale, ove la cultura è mercificata, resa inerte…”. Il tutto, però, su un sottofondo di malinconia e solitudine e con un’ironia che rende gradevole la lettura e stempera i drammi personali e collettivi. Temi che sono diventati materia di un film di Carlo Lizzani con Ugo Tognazzi nel ruolo di protagonista/Bianciardi.
Oggi persistono questi motivi di disagio nella vita e nel lavoro, aggravati addirittura per i giovani dall’estrema precarietà del e dalla svalutazione del potere di acquisto degli stipendi, il che rende instabili anche le relazioni di coppia e fa di questa generazione la prima a vivere in condizioni peggiori di quelle precedenti dopo il boom economico. E in generale le condizioni di lavoro sono peggiorate per tutti, è aumentato lo sfruttamento con un monte ore sempre più alto e uno spazio progressivamente ridotto per la vita di famiglia, le relazioni e il tempo libero.
Lo rappresentano bene i film del regista Ken Loach, nell’indagine sulla spietatezza del mondo lavorativo che riduce l’individuo a strumento spersonalizzato uccidendone lo spirito d’iniziativa e la sensazione di incidere attivamente sul prodotto e, come dice David Graeber, “un essere umano incapace di avere un impatto significativo sulla realtà smette infatti di esistere” (David Graeber, Bullshit jobs).