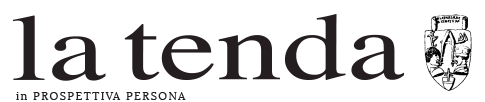Il 19 febbraio scorso all’età di 86 anni Paolo Conte entra con eleganza e a passo lento sul palco del
Teatro alla Scala di Milano, una mano sulla fronte come per proteggersi dalla luce e poi si siede al suo
pianoforte da concerto, dal suono avuto dal misterio, un pianoforte a coda lunga, nero.
Nasce il 6 gennaio del 1937 ad Asti, dove si diploma al liceo classico Alfieri, si laurea in
giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma e inizia a lavorare come assistente presso lo studio
notarile del padre. Grazie ai suoi genitori appassionati di musica colta e popolare, sin da
bambino ascolta dischi stranieri e si nutre di jazz; impara a suonare il pianoforte durante la guerra
quando trascorre un lungo periodo presso la fattoria del nonno e più tardi, a metà degli anni cinquanta,
il trombone, poi il vibrafono. Si avvicina al mondo della canzone principalmente come “autore”,
componendo musiche e arrangiamenti per altri artisti, il brano più celebre di quegli anni è senz’altro
Azzurro cantato da Adriano Celentano, finché negli anni ’70 decide di lasciare definitivamente la
professione di avvocato per dedicarsi alla musica e cantare lui stesso le sue canzoni.
Con la sua voce roca, leonina e travolgente, Paolo Conte è un gentiluomo cosmopolita di provincia,
che con raffinata discrezione invita ad entrare nel suo mondo: un mondo che forse non esiste più o di
cui è rimasto qualche raro e prezioso frammento, custode di molte eredità. La sua musica è carica di
riferimenti che vanno dal jazz allo swing, dal musical al ragtime, ma impossibile da definire; una
“musica popolare”, matura, indolente, elegante e dinamica. La canzone si svuota di ogni
connotazione storica per traghettare l’ascoltatore, con disincantata ironia, verso universi referenziali
carichi di valori universali, dove la provincia diventa metropoli e la solitudine camuffa il tentativo di
sognare in grande e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri
nei miei pensieri all’incontrario va.
Eccellenti musicisti professionisti compongono l’orchestra classica-jazz che lo accompagna da anni:
fisarmonica, violino, chitarre, sassofoni, oboe, fagotto, flauto, basso, chitarra elettrica, contrabasso,
violoncello, tromba, bandoneon; poi il pianoforte e il graffiante kazoo di Conte, che durante i concerti
parla pochissimo, risponde agli applausi guardando la platea con un mezzo sguardo incerto, con gesti
schivi, quasi incredulo (avendo avuto seppur brevissimi scambi verbali ed epistolari, conservo il
bel ricordo di una persona estremamente cordiale, affabile ed accogliente, insomma “un uomo di altri
tempi”). Compone alla vecchia maniera Conte: prima la musica poi il testo; le parole vengono
accostate sapientemente tra di loro, nascondono un mondo sonoro, un mondo fatto di ritmo, di
memoria, di eros, di auto con la capote, di sbagli da professionisti, di gelati al limone e gerani, di mari
vicini e lontani, di sigarette al mentolo e caramelle alascane, di donne dive, di uomini
commendatori, di tinelli, di fisarmoniche, di atmosfere orientali e sudamericane.
Per conoscere un mondo occorre accettare l’invito ed entrarci, fermarsi sotto le stelle del jazz e
guardare con la testa all’insù, essere quelle figure, scoprire i pensieri non detti, l’imprevedibile, gli
intervalli tra una nota e l’altra. Immaginare di galleggiare nel mare onda su onda mentre la nave che
si allontana diventa una lucciola persa nel blu per approdare infine in un’isola dove Il clima è dolce
[…] e ci sono palme e bambù. Aspettare in una strada polverosa che spunti da una curva Bartali quel
naso triste da italiano allegro o sedersi al volante di una Topolino amaranto che fila a briglia sciolta
su tortuose stradine verso il mar Ligure per ritrovarsi in Argentina ad ascoltare il baccano giù nel
porto mentre i bastimenti gridano – Partiamo – davanti a un mare enorme americano che sciacqua
un sogno vecchio ormai. Occorre entrare in una polverosa palestra illuminata da grandi lampade al
neon, sentire l’odore di chiuso, del pavimento consunto, immaginare un vecchio sparring partner che
silenzioso siede in disparte: un macaco senza storia, dice lei di lui, che gli manca la memoria in fondo
ai guanti bui, ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella
giungla. Ascoltare i passi, guardare da lontano un uomo e una donna che nella notte camminano e si
lasciano alle spalle il bar Mocambo, le serrande abbassate pioggia sulle insegne delle notti andate
mentre piove bene sugli impermeabili, sentire l’odore che arriva da una di quelle drogherie di una
volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.
Paolo Conte parte dalla provincia, arriva a Genova e Torino per spingersi fino a Parigi Lo so, lo so
che questa non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che
sono qui davanti a te sotto la pioggia. Mentre tutto intorno è solamente pioggia e Francia; poi tra gli
Incas, a Shanghai, canta di donne e uomini che ballano su ritmi selvaggi ed esotici. Compaiono torride
orchestre, afrori vecchi e nuovi, donne africane, Hemingway, in una canzone che è un omaggio allo
scrittore americano, nella quale la musica è quasi l’unica protagonista mentre il testo serve solo per
evocare quei luoghi che Hemingway descriveva nei suoi romanzi oltre le illusioni di Timbuctù e le
gambe lunghe di Babalù. La sua musica è dunque un lungo sorprendente viaggio dove ognuno può
salire su quel treno che Scomparirà sulle sue ruote rotonde, dietro alle nuvole bionde, su un
aeroplano, che nell’aria bionda e chiara vola piano, lascia un bel mondo dal colore baio, dove c’è il
fiume di gennaio.
Evocazioni di un ambiente di provincia ma anche di luoghi e atmosfere lontani: è tutto un grande
addio, un giorno Gondrand passerà, te lo dico io, col camion giallo porterà via tutto quanto e poi
più niente resterà del nostro mondo, da-da-da, da-da-da uhhh. Nostalgia di un mondo fatto di sguardi,
di parole cercate e scelte, garbate, gentili, nostalgia di sobria eleganza, di un pudore che non rinuncia
all’eros, ma che è lontano dall’esibizionismo grossolano della nostra società contemporanea, di donne
charmant dalla misteriosa personalità, che scendono le scale di un palcoscenico in abiti elegantissimi
e sensuali, suscitando meraviglia nel pubblico e lasciando spazio all’immaginazione.
Paolo Conte è un sarto, cuce bellezza che chiede all’arte di stare alla sua altezza, di scegliere l’abito adatto. Se questo
mondo sembra ormai lontano resta il desiderio di rifugiarsi qui di quando in quando (via, via vieni
via con me, non perderti per niente al mondo), nella sua musica che ammansisce i pensieri, rinnova
e ingentilisce l’anima, salva dalla banalità, istruisce la fantasia, una sorta di “uscita di sicurezza”.
Paolo Conte rimane qua, io sono qua, rimango qua, in questa ruggine densa, come qualcuno pensa
a un treno