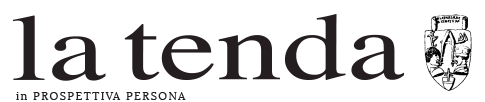La storia di Edipo è centrale nel teatro di Sofocle.
Edipo a Colono, rappresentata postuma nel 405 a. C, è l’ultima opera di Sofocle e si può definire “Edipo ultimo atto”.
La tragedia si inserisce nel ciclo tebano, che tratta del destino dei Labdacidi, discendenti di Labdaco, nonno di Edipo.
Edipo re fu composto fra il 429/25, trenta anni dopo il ciclo si chiuse con la sua ultima tragedia, Edipo a Colono, rappresentata postuma nel 405 (è del 406 la morte di Sofocle).
Edipo ha conosciuto nei secoli una fortuna che va al di là dei motivi puramente letterari ed è diventata una delle chiavi per la scoperta delle forze inconsce della psiche, ma il suo significato nel mondo di Sofocle è soprattutto politico.
Se l’Edipo re è costruito con montaggio dinamico che potremmo definire di tipo cinematografico, in una ricostruzione di eventi a posteriori di sublime perizia drammaturgica, l’Edipo a Colono è la tragedia dell’approdo, della stasi in un luogo sacro dove tutto si compone, e le tempeste della vita, i contrasti, le durezze e le fallaci certezze tacciono.
Edipo è giunto al termine del suo drammatico percorso, l’uscita di scena è memorabile, non è la morte di un uomo ma una dissolvenza (e torniamo al linguaggio cinematografico) nel bosco sacro delle Eumenidi, le dee benevole venerate in Atene, a Colono, patria del poeta, località vicina ad Atene. E’ la discesa nell’Ade dell’eroe leggendario sul modello di tanti eroi della poesia antica. Atene è una presenza importante sullo sfondo del bosco sacro di Colono, ai margini del quale si
svolgono gli ultimi incontri della vita di Edipo.
Sono presenti le due figlie Antigone e Ismene che l’hanno sorretto nella sua vecchiaia indigente, ben presto arriverà il figlio Polinice con la notizia del suo tremendo scontro per il potere a Tebe con il fratello Eteocle e la conseguente, irrevocabile condanna da parte del padre verso i due figli; quindi Creonte, reggente di Tebe, figura viscida di opportunista con cui lo scontro verbale è inevitabile, seguito, dietro le quinte, dallo scontro armato con Teseo, re di Atene, da cui Creonte
uscirà sconfitto. Teseo è il re illuminato a cui Edipo affida la sua eredità di uomo giusto, mentre l’oracolo di Delfi crea un simbolico legame fra i loro due mondi e Atene sarà la città esempio di armonia e giustizia che ne raccoglierà i frutti.
Edipo, alla fine della sua vita, ha raggiunto la verità che ha sempre cercato e può accomiatarsi con serenità dal mondo, poiché sa che alla sua tomba gli Dei attribuiranno il giusto onore. Ecco perché si allontana da tutti diretto all’interno del bosco sacro e vorrà essere accompagnato solo da Teseo a cui consegnerà il testimone.
Teseo e la sua discendenza saranno i custodi della sua memoria che terrà lontano da Atene i nemici, la renderà gloriosa e garantirà pace e giustizia al popolo.
Ma non sono le lodi di Atene che a Sofocle interessa ora tessere, piuttosto a lui preme mettere la città di fronte alla necessità di una riflessione sul presente, e in questo senso possiamo definire l’Edipo a Colono la più politica delle sue tragedie.
Qualcuno comanda su di loro o il diritto di parola è del popolo?
E’ la domanda che Edipo rivolge a Teseo appena il re arriva. Teseo era il mitico fondatore di Atene, la domanda rivolta a lui investe tutta la comunità, e la risposta esige una profonda riflessione del popolo ateniese sulla propria condizione politica.
Il modello negativo è Tebe, città travagliata da lotte per il potere e da un sistema di governo oligarchico presto degenerato in dittatura. L’Atene di Teseo, democratica e rispettosa dei diritti dei cittadini, è il modello che Sofocle addita ad un’Atene che aveva conosciuto nel 411 l’esperienza del colpo di stato oligarchico e, una volta restaurato il regime democratico, non vi era stato un grande miglioramento. Tra il 408 e il 406, Atene aveva subito gravi sconfitte militari e la destituzione dello stratega Alcibiade, un uomo in cui Atene aveva riposto le sue più vivide speranze. La sua fuga nell’Ellesponto e le forti tensioni, dovute alle tendenze democratico-radicali, ostili a qualunque trattativa con il nemico spartano, stavano corrodendo fino in fondo il modello di democrazia creato da Pericle a cui Sofocle si era sempre ispirato.
In questo senso Edipo a Colono è il suo testamento spirituale, affidato nell’ultima tragedia al suo antico e più grande eroe che, avvolto da un alone mitico, consegna la sua tomba a Teseo perché gli ideali di giustizia e buon governo siano custoditi e possano guidare la città nelle tempeste della Storia.
Edipo a Colono è la tragedia della vecchiaia di Sofocle e di Edipo, l’eroe che ha attraversato la vita conoscendo tutto il bene e il male di cui l’uomo può fare esperienza e ha visto quanto siano precarie le umane sorti, scendendo fino in fondo nell’abisso della disperazione. Ma quello che Sofocle mette in scena, pur così lacero, debole e cieco, è un uomo grande che nel dolore ha trovato la verità, e si erge gigantesco contro i malvagi, fino a maledire i suoi stessi figli che l’hanno rinnegato e si ostinano nell’errore e che ha bellissime parole d’amore per le due figlie caritatevoli. E’ un uomo che ha un profondo senso del sacro, Zeus è la divinità che attraverso l’oracolo gli affida il grande compito di salvaguardare, oltre la morte, quello spirito di verità, giustizia e democrazia che l’umanità rischia ogni volta di perdere nelle secche della Storia.
Quella di Edipo è la voce di Sofocle, il grande poeta di una civiltà che nei millenni continua ad additare la strada a tutta l’umanità.
Sinossi.
Cieco e vagabondo, Edipo giunge a Colono, presso un santuario dedicato alle Eumenidi vicino ad Atene, sorretto da Antigone e poi anche da Ismene sua sorella. Tutti lo evitavano nel suo lungo peregrinare ma ora tutti lo cercano, poiché la città che avrà la sua tomba sarà invincibile, così dicono gli oracoli. Edipo nell’Esodo allontana tutti e, affiancato dal re ateniese Teseo che l’ha accolto e a cui ha promesso il suo aiuto perenne, si avvierà verso la morte nel boschetto di Colono.
Personaggi
Le due figlie di Edipo, Antigone che l’ha sorretto in tutti questi anni di vita raminga e Ismene che giunge da Tebe e racconta la drammatica rivalità fra i due fratelli, Eteocle e Polinice per il potere.
Creonte, reggente a Tebe dopo la cacciata di Edipo, arriverà per ottenere che Edipo torni. Conosce l’oracolo secondo cui la città che avrà la sua tomba sarà invincibile, ma pretende che Edipo viva segregato senza alcun onore.
Fra lui e Teseo, illuminato re di Atene presente sulla scena, ci sarà uno scontro armato da cui uscirà sconfitto.
Nel frattempo arriva Polinice, estromesso dal fratello Eteocle, ad implorare l’aiuto del padre. Infine appare il nunzio nell’Esodo a raccontare l’ultimo atto, il cammino di Edipo nel bosco sacro verso la sua tomba, accompagnato solo da Teseo a cui l’eroe consegna il testimone che farà di Atene la città protetta dagli Dei, faro di buon governo e giustizia per tutti i popoli.
La figura di Edipo
Nell’incontro con il Coro dei cittadini di Colono si manifesta tutta la fragilità di quest’uomo.
“Ospiti, io sono senza patria. Stirpe orrenda” così definisce sé stesso e poi tace. Dolore e vergogna si fondono, il Coro non capisce. In un momento di estrema fragilità Edipo chiede ad Antigone: “Che dirò, che farò figlia mia?”
E infine, rivolto al coro: “Noti vi sono i Labdacidi? Noto vi è un figlio di Laio ? Noto vi è il misero Edipo?”
A questo punto il Coro inorridisce, la fama di Edipo era nota in ogni angolo della Grecia.
Il Coro apprende l’identità dei due pellegrini e lo sconcerto iniziale è grande:
E tu, presto, abbandona quel sedile,
togli l’ancora da questa mia terra,
prima che qualche conto da pagare
non maturi per questa mia città.
C’è in tutta la tragedia, ma soprattutto nella Parodo che segue il Prologo, la consapevolezza amara del destino di cui l’eroe è stato vittima ma anche involontario responsabile, ed è tanto più dolorosa e commovente perché un uomo così colpito dal male, un giusto innocente, ha dovuto subire una pena tanto grave e una notorietà così infamante.
Nel corso della tragedia alla sua persona sarà tributato il giusto onore, soprattutto per merito di Teseo, re illuminato di Atene, ma per ora Sofocle pone il suo Edipo sul fondo dell’abiezione, lì dove i suoi eroi solitari sono sempre cacciati nonostante abbiano vissuto una vita all’insegna della virtù.
La profonda umanità di Sofocle è in questa coscienza tragica dell’infinita debolezza dell’uomo di fronte a forze incomparabili e incontrollabili, a cui l’uomo si oppone pur presagendo la sua sconfitta, ma trovando in questo il suo eroismo e riscatto.
I discorsi di Edipo
Sono quelli che è costretto a rivolgere prima al Coro, poi al figlio Polinice.
Nelle parole rivolte al Coro è messa a fuoco la realtà della sua vita dopo l’accecamento, con la rivelazione di uno sviluppo finora sconosciuto al pubblico:
Qual valore ha dunque la gloria,
e quale il vantaggio della fama,
se sono falsamente divulgate?
Di Atene si dice che fra le città
appare la più devota agli dèi,
ch’essa soltanto salva lo straniero
che da sventura è perseguitato;
risponde al vero se voi mi scacciate,
impauriti solo del mio nome?
Non è il mio corpo che vi fa paura,
né per le azioni che non ho compiute
ma sofferte soltanto, se ora posso
parlare di mio padre e di mia madre
per i quali tu di me hai orrore.
Io dunque sarei nato scellerato,
ricambiando il male che ho subito?
Non lo sarei neppur se con coscienza
da scellerato io avessi agito.
Senza sapere nulla, a questo punto
son giunto, ma buona conoscenza
aveva chi causò la mia rovina.
Io vi supplico per queste ragioni,
come prima mi avete allontanato
dal bosco, or di darmi protezione
in nome degli dèi, se veramente
di loro avete ancora rispetto.
Ricordatevi che in egual misura
essi guardano il mortale devoto
come l’empio, e nessun sacrilegio
è stato mai da loro trascurato.
Non offuscate la gloria di Atene
con atti indegni, voi avete dato
a un supplice la vostra accoglienza
insieme con speranza di difesa.
E’ un’autodifesa e insieme una supplica. Edipo, pur se vecchio e lacero, emana grande dignità, è un uomo che ha sofferto molto perciò le sue parole contengono verità e giustizia e il vaticinio che le accompagna dà loro ulteriore valore:
Non disprezzarmi per lo sfigurato
mio volto: io puro son venuto
a portare un aiuto ai cittadini.
E quando sarà qui il vostro sovrano,
chiunque sia, se ascoltar vorrete,
altre cose saprete, nell’attesa
vi supplico di non esser malvagi
Con questo discorso nel primo episodio Edipo racconta le ragioni del suo esilio e della sua
condanna per i due figli a cui negherà il suo aiuto.
Quando con disonore dalla patria
venni scacciato, nessuna difesa
né protezione da lor mi fu data;
entrambi mi lasciarono partire
espulso ed all’esilio condannato.
Tu forse mi potrai anche obiettare
ch’era mio desiderio andare via
e che quello era un dono a me concesso.
L’appunto non risponde a verità
perché quel giorno il cuore mi sanguinava,
e più dolce per me sarebbe stato
morir per mezzo di lapidazione,
ma quest’aiuto non mi fu elargito
da nessuno. Parecchio tempo dopo,
quando il dolore si fu attenuato,
mi resi conto che esagerazione
era stata la mia nel giudicare
antichi errori e le colpe passate,
proprio allora la città mi scacciò,
e i miei figli che la mia difesa
assumere avrebbero potuto,
rifiutarono di farlo e mi lasciarono
vagare esule in terra straniera
come un mendico. Da queste fanciulle,
nei limiti che la natura ha imposto,
ricevo cibo, asilo e conforto,
mentre i figli, anziché il loro padre,
han scelto il trono, lo scettro e il potere.
Ma io non sarò mai loro alleato,
né gioia avranno nel regnar su Tebe;
ne son certo ascoltando gli oracoli
nel ricordo di antiche profezie
che Febo sul mio conto pronunciò.
Infine le parole rivolte a Polinice segnano la condanna definitiva dei figli che l’hanno rinnegato.
A voi, abitanti di questa contrada,
dico che se non fosse per Teseo
che l’ha mandato, ritenendo giusto
lo scambio di parole, mai sarebbe
avvenuto ch’egli mia voce udisse.
Non so però se sarà soddisfatto
di quello che dirò che certamente
non potrà rallegrargli la vita.
Non ti ricordi, figlio sciagurato,
di quando possedevi trono e scettro
di Tebe che ora è di tuo fratello?
Fosti tu stesso a cacciare tuo padre
togliendogli la patria, tu a dargli
le vesti miserande sulle quali
ora piangi, or che a sopportare
ti trovi le mie stesse condizioni.
Risparmia il pianto, commiserazione
non mi serve: io devo sopportare
la mia sorte per il resto di mia vita,
senza scordarmi che sei stato tu
il mio assassino, tu che m’hai obbligato
a vagare ramingo e ad affidarmi
alla pietà degli altri per il cibo.
Se queste figlie io generato
non avessi, in vita non sarei
certamente, per quanto ti riguarda:
son proprio loro a farmi da nutrici,
come fossero uomini e non donne,
partecipando alle mie sventure,
dimostrando chiaramente che voi
siete nati da un altro e non da me.
…………………………………….
No, non espugnerai quella città:
sarai tu prima a cadere macchiato
dal sangue del fratello, e lui egualmente.
Queste maledizioni che scagliai
contro di voi a suo tempo, ribadisco:
siano mie alleate, affinché
il rispetto dovuto ai genitori
impariate, né il padre disprezzare
che cieco è diventato, e come esempio
prender l’agire delle due sorelle.
Le mie maledizioni il supplicare
tuo vinceranno, e così il tuo trono,
se l’antica Dike di Zeus compagna
le immutabili sue leggi onora.
Vattene, detestato e senza padre,
pessimo fra i cattivi, a cui ho scagliato
maledizioni perché tu non possa
impadronirti della patria terra,
né ad Argo mai più fare ritorno,
e di morire per mano fraterna
mentre uccidi colui che ti ha esiliato.
Ti maledico e scendano sul tuo capo
le tenebre dell’Ade, queste dee
io invoco e Ares che ha gettato
fra di voi un odio tanto mostruoso.
Vattene via adesso che hai ascoltato,
annuncia ai Tebani e ai tuoi alleati
quale razza di doni ho dato ai figli.