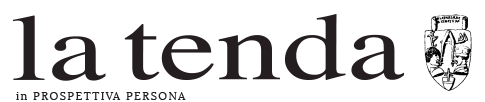| So’ jìte a lu mercate de bbeštiame, / la fire che se te’ pe’ San Martìne,/ ddu ùmmene trattave ‘na lemane,/ vicine a la candine de ‘Ngiulìne. Cercave tande a chile chi vennave,/ lu pâse lu štemave a ùcchie e croce./ «É troppe!» J’aspunnave chi cumbrave,/ «Su ‘n cocce te nu vòzze ‘nde ‘na nòce»./ De mezze ce s’à mâsse nu ssenzale:/ «Defètte c’è, ma è carne da macèlle,/ levamije caccose pe’ ssu male,/ lu rešte pu’ s’aggiušte, vi’ ‘nde bbelle!»/ «Va bbone se te dinghe ddu e cenguande?»/ «È poche, ddu e settande quašte vale!»/ «Tajame ‘mmezze, daje ddu sessande!/ j’ asponne da llà ‘rrete lu ssenzale./ E fa nu ciânne ‘nde pe’ dice è fàtte./ «Faciate štu cundrtatte, qua li mane!/ La bbìštie pe’ ssi solde è pare e pàtte,/ nen serve che l’armìnne pe’ dumane»./ Se huarde dandre a l’ùcchje li ddu parte,/ da ùmmene s’affide a la parole,/ na štrâtte ‘nghe la mane e lu cundratte,/ fermite senza ‘gnoštre e senza scole./ Tra ùmmene l’accorde se respètte,/ nen serve carta cande e verbum vole,/ nen trove cchiù la pace lo lu lètte/ lu fàzze che s’armagne la parole./ L’unore è ‘na vertù, è ‘na reccâzze,/ lu vènde fa ggerì li bbanderole./ l’àsene s’ammandè ‘nghe la capâzze,/ l’òmmene se mandè ‘nghe la parole. Traduzione in Italiano: L’uomo si mantiene con la parola/ Sono andato al mercato di bestiame,/ la fiera che si tiene per San Martino,/ due uomini trattavano un animale,/ vicino alla cantina di Angelino./ Cercava tanto al chilo chi vendeva,/ il peso lo stimava ad occhio e croce,/ «É troppo!» Rispondeva chi comprava,/ «In testa ha un bozzo come una noce»./ Di mezzo ci si mette un sensale:/ «Difetto c’è, ma è carne da macello,/ togliamogli qualcosa per quel male,/ il resto poi s’aggiusta, vedi com’è bello!»/ «Va bene se ti do due e cinquanta?»/ «È poco, due e settanta questo vale!»/ «Tagliamo in mezzo, dagli due e sessanta!»/ Risponde da lì dietro il sensale./ E fa un cenno come a dire è fatta./ «Fate questo contratto, qua le mani!/ La bestia per quei soldi è pari e patta,/ non serve che rimandi per domani»./ Si guardano negli occhi le due parti,/ da uomini s’affidano alla parola,/ una stretta con la mano e il contratto,/ firmato senza inchiostro e senza scuola./ Tra uomini gli accordi si rispettano,/ non serve carta canta e verbo vola,[1] non trova più la pace dentro al letto[2] il falso che rinnega la parola./ L’onore è una virtù, è una ricchezza,/ il vento fa girare le banderuole,/ l’asino si mantiene con la cavezza,/ l’uomo si mantiene con la parola. Questa poesia in dialetto teramano di Gabriele Ruggieri ha vinto il primo premio nella VII edizione del Premio Letterario “Lucius Calidius” – Macchia d’Isernia – Sezione “Poesia Dialettale” con la seguente motivazione: Il dettato poetico di Gabriele Ruggieri s’innesta in una salda tradizione di poesia dialettale abruzzese, che nel secondo Novecento (da Dommarco a Savastano) ha dato prova di valicare ampiamente il campanile e il municipio. L’innesto del dialogo e soprattutto del proverbio sul tronco dell’endecasillabo classico ha certamente il merito, nella poesia di Ruggieri, di mescolare alto e basso, conferendo una (per così dire) “allegra gravità” alle espressioni di un tempo inesorabilmente appartenente – appartenuto – al passato. Così, nel contratto stipulato alla fiera del bestiame di San Martino, la situazione tutta cenni e gesti dell’alterco viene raschiata e prelevata dal suo fondo contigente e resa quasi sentenza, poesia gnomica. La poesia di Ruggieri è come una monade o una goccia che conserva intatti i momenti di una civiltà scomparsa, ma non è affatto nostalgica: il mondo contadino non viene compianto, ma fatto decantare come un mosto, e la lingua teramana non è musealizzata, ma sciolta e articolata nel suo rapporto con l’italiano (la traduzione non è di servizio, ma posta accanto sulla stessa pagina del dialetto). Al punto che, nella poesia Štava penzà, è lo stesso dialetto che si chiede quale sarebbe stata la sua sorte se fosse stato parlato dalla balia di Dante – se il poeta, nutrito a quella fonte, avesse mai composto una “divina cummedia terramane. Elenio Cicchini |
[1] Libera rielaborazione del detto latino Scripta manent, verba volant.
[2] Non dorme sonni tranquilli.