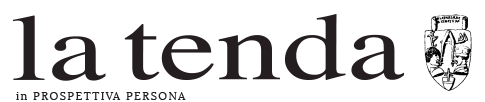Luigi Malerba, A. Mondadori Editore, Milano, 1997.
Come felicemente osserva Marco Corsi nella prefazione al romanzo, l’autore “rilegge in chiave introspettiva e psicologica il ritorno di Ulisse in patria” concentrandosi su quest’ultima fase del poema omerico. Ma lo ripercorre, secondo Paolo Mauri (L’Odissea di Luigi Malerba, la Repubblica), raccontando anche quello che Omero tace narrando in modo ellittico e reticente, come ad esempio la follia simulata per non andare in guerra, Filottete abbandonato su un’isola deserta con una gamba in cancrena, il suicidio di Aiace per le armi sottrattegli da Ulisse con inganno. E mentre nel poema l’eroe viene riconosciuto dal cane Argo, dal porcaio Eumeo e dalla nutrice Euriclea, non da Penelope, qui invece l’autore fornisce una serie di indizi di carattere emotivo e mimetico che conducono il lettore alla percezione di un riconoscimento da lei volutamente nascosto e tenuto segreto finché la situazione delicata con i Proci non lo permetterà.
Il racconto procede in modalità binaria, attraverso l’alternanza della voce di Ulisse e di Penelope e si dipana fino allo spannung della strage e allo scioglimento del nodo tragico nella vittoria dell’eroe con il figlio Telemaco e i pochi fedelissimi. Non più il monolitico punto di vista dell’Autore del poema epico, che pure cerca di indagare l’animo e le reazioni dei protagonisti, ma il confronto a volte conflittuale dei loro punti di vista, della loro interpretazione dei fatti e della storia. Ne viene fuori una donna callida e saggia quanto il marito la quale, come lui ha saputo ingannare i Troiani con lo stratagemma del cavallo di legno, ha raggirato i pretendenti durante la ventennale assenza di Odisseo con l’inganno della tela da tessere per il sudario del suocero. Penelope mostra un carattere determinato e forte, non passivo e remissivo, sia di fronte ai Proci che al figlio Telemaco e all’amato sposo Ulisse, come anche appare nel racconto che dell’Odissea fa Marilù Oliva attraverso la voce di Penelope ed altre donne (“L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre”, Solferino, Milano, 2020). L’Autrice fa dire a Penelope stessa, in una vera e propria autoanalisi:” Ho giocato d’astuzia per tanti anni, rimandando, intrecciando, scomponendo…Ho lottato con le unghie e con le zanne, ma quelle della mente. Ho finto di tessere un sudario, un sudario senza fine…Con la determinazione di chi sa che c’è in gioco il potere, il regno su un’isola, il sogno di un amore, la solidità di una famiglia. Quanto a solidità, l’ho costruita in gran parte da sola, come capita sovente a noi donne.”
In “Itaca per sempre” è addirittura Ulisse a scoprirsi incerto, dubbioso e fragile come ogni uomo moderno: nei suoi monologhi interiori si scopre geloso, tormentato e sofferente per avere ritrovato “Penelope così sicura di sé, così altera”, corteggiata in sua assenza e forse…chissà, condiscendente a qualche tentativo di portarla via al marito che dopo tanti anni di assenza, secondo i Proci, non sarebbe più tornato. “Ma quel fiore rosso di lino sottile che Penelope si è appuntato nei capelli, chi glielo avrà donato? Forse Antinoo o qualche altro dei suoi pretendenti?” – si chiede colpito dalla grazia e dalla bellezza che la sua donna ancora conserva dopo 20 anni. E deve frenare con grande sforzo la rabbia che monta dentro e il desiderio di vendetta nell’attesa del momento più propizio per la strage. Intanto moglie e marito si scrutano e guardano con sospetto, in una diffidenza reciproca, e la stessa Penelope con amarezza osserva:” Così questo ritorno è avvenuto senza gioia e nel segno del sospetto. Come potrò perdonare a Ulisse la freddezza con cui riesce a nascondersi e a scrutarmi come un oggetto senz’anima?”

La stessa dinamica psicologica che avviene anche nel film “Itaca. Il ritorno”, dove il regista Uberto Pasolini ci restituisce un Odisseo (Ralph Fiennes) bramoso di vendetta ma anche cauto e sospettoso, tormentato da dubbi su Penelope (Juliette Binoche), fragile e umano come l’ uomo di oggi, che si interroga sul senso della guerra e del vagabondare. Un uomo moderno che ha preso consapevolezza che la guerra è distruzione e morte e la virilità non si misura sulla forza fisica ma interiore. “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, potrebbe dire con Terenzio.