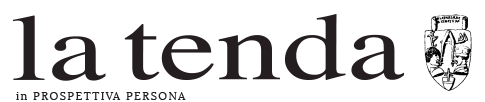di Rosy Bindi- A Lanciano
L’articolo 49 della Costituzione dedicato ai partiti politici afferma che i partiti politici con metodo democratico concorrono all’indirizzo politico della nazione. Metodo democratico. Questa è un termine che i nostri costituenti non hanno scelto a caso, nessuna parola nella nostra Costituzione è scelta a caso, ma “metodo democratico” è un obbligo per una comunità politica perché è nella misura in cui dentro le comunità politiche si riesce a praticare il metodo democratico, che si è scuola di democrazia per l’intero paese: persone che si formano, che hanno una propria visione del mondo, che la mettono al servizio della propria comunità, che lo fanno attraverso il dialogo, il confronto, anche aspro, duro e che maturano una scelta che mettono in pratica.
Non è proprio un metodo democratico quello di cambiare collegio elettorale ai parlamentari. Evidentemente assomiglia di più a qualche altra cosa, però fa parte, diciamo, di una comunità viva. Nella storia politica dell’Italia alla Democrazia Cristiana va riconosciuto il fatto di essere stata, con tutti i suoi difetti, la comunità politica che più di altri ha praticato il metodo democratico. Le tante vituperate correnti democristiane erano espressione di pluralismo interno del partito, condizione fondamentale per perseguire l’unità dello stesso e anche per assicurare, come è stato per lunghi anni, alla Democrazia Cristiana la possibilità di essere il partito di maggioranza relativa del paese. Abbiamo sentito parlare di gaspariani e di fanfaniani della sinistra democristiana e dei dorotei. Potremmo fare un lungo elenco delle varie correnti. Ciascuno di noi è stato democristiano attraverso l’appartenenza ad una componente della Democrazia Cristiana. Io sono stata iscritta alla DC, quindi posso testimoniarlo con molta serenità: se dentro la Democrazia Cristiana non ci fossero state persone come Moro, Benigno Zaccagnini, finanche la famiglia Mattarella, Maria Eletta Martini e molti altri, io forse non sarei stata democristiana. Penso che molti altri che appartenevano ad altre componenti della DC non sarebbero stati democristiani se non ci fossero stati Fanfani, Colombo, Gava e se ci spostiamo al Nord l’elenco si allunga. Lo stesso si può dire per i tanti che hanno conosciuto in Remo Gaspari qui in Abruzzo un grande punto di riferimento.
Un altro punto di riferimento è stato Donat Cattin per moltissimi esponenti, soprattutto provenienti dalla cosiddetta sinistra sociale. Ecco, questa era la forza di quel partito che è riuscito a mantenere la sua unità nella misura in cui ha avuto una guida e ha avuto guide che erano capaci di fare sintesi. Sicuramente lo ha fatto De Gasperi all’inizio. Sicuramente l’ha fatto Aldo Moro fino al giorno in cui è stato rapito. In questo pluralismo, c’è una linea. Lo storico mi dirà che non sono scientifica in questa lettura, ma non faccio la storica di mestiere, quindi me lo posso permettere e del resto non credo di dire sciocchezze. Una cosa è certa: la Democrazia Cristiana non ha mai governato con la destra. La definizione di De Gasperi, per cui la DC è un partito di centro che guarda a sinistra, una sorta di laburismo cristiano, pronunciata dal nostro leader più centrista che abbiamo avuto, è scolpita lì e nessuno la cambia. A tal punto che, lo ricorderete, De Gasperi era un uomo che andava a messa tutti i giorni.
Poiché ormai si sta aprendo la canonizzazione dentro la Chiesa di laici, sposati con famiglia, io credo che De Gasperi, prima o poi, potrebbe rientrare tra coloro che meriterebbero di essere indicati nella lista delle persone da canonizzare, anche per il suo credo, come cristiano, come punto di riferimento. Sappiamo che però ebbe, in un certo momento, un grosso conflitto con il Papa, o meglio con gli emissari del Papa. Quando? La Santa Sede, nel 1952, era tanto preoccupata che il partito comunista vincesse a Roma. Si presentò un monsignore che chiese a De Gasperi di fare l’accordo con il Movimento Sociale per battere i comunisti. De Gasperi disse: “Ma la politica tocca al segretario della DC, non tocca ai segretari di Stato del Vaticano”. “ Sì, ma è il Papa in persona che glielo chiede.” Fu la risposta. De Gasperi, non andò mai dal Papa a farselo chiedere, perché sapeva perfettamente che se glielo avesse chiesto di persona il Papa, si sarebbe dimesso da segretario della Democrazia Cristiana. Lui, che aveva saggezza politica, rispose a questo monsignore: “Se io faccio un accordo con il Movimento Sociale, schiaccio la DC a destra. Tutti quegli elettori che costituiscono le componenti sociali marginali della città, voteranno Partito Comunista, se invece io mantengo la barra dritta di partito antifascista e riformista, riesco a prosciugare il consenso verso il PCI di quei ceti sociali più poveri e marginali che vedono nel partito comunista la possibilità di riscatto. Il PCI sicuramente aumenterà i consensi nella misura in cui io faccio un’alleanza con gli eredi del Partito Fascista”.
De Gasperi fece di testa sua e vinse le elezioni a Roma. Perché vi racconto questo episodio che sta scolpito nei fatti accanto alle parole? Il Partito Comunista Italiano aveva il maggior numero dei consensi tra i partiti comunisti dell’Europa occidentale ed arrivò ad avere un consenso del 30% in Italia, consenso non rubato. Unico partito comunista dell’Occidente, unico partito in Europa (in Francia i comunisti non sono mai arrivati a raggiungere un consenso a due cifre), aveva un radicamento vero. I comunisti, però, non hanno mai governato. Fino a quando? E’ nota la storia: il partito comunista in Italia non ha mai governato perché quando è andato al governo non era più partito comunista sostanzialmente, checché ne dicesse qualcuno. La trasformazione del PCI è avvenuta, non solo perché c’era la Conventio ad escludendum, il mondo era diviso in blocchi e l’Italia per posizione geografica strategica era frontiera tra il mondo sovietico e gli Stati Uniti d’America, ma perché non ha mai avuto il consenso con la legge proporzionale per arrivare a governare il paese. E perché tutto questo? Perché la DC ha fatto politiche ed ha guidato un certo modello di sviluppo economico. Prima ancora del primo Centro-Sinistra, Fanfani faceva la riforma della casa e la riforma agraria.
Il modello di sviluppo industriale di questo paese, con tutti gli errori che si sono commessi soprattutto nel Mezzogiorno e anche in alcune aree del Nord, penso a Marghera, ma anche nella mia Toscana, penso a Piombino per esempio, per citarne una, lo sviluppo economico di questo paese, ripeto, si è ispirato a quegli articoli della Costituzione che si chiamano “costituzione economica” dove sono riconosciute la proprietà privata e la libera impresa, libertà a cui viene affidato un fine sociale. Il nostro modello di sviluppo industriale c’è stato grazie al cosiddetto modello delle partecipazioni statali, perché è stata l’economia pubblica che ha guidato lo sviluppo economico ed il riscatto dell’Italia dalle macerie della guerra. Ricordate il discorso di De Gasperi a Parigi? “Tutto è contro di me, esclusa la vostra benevolenza.” Siamo arrivati a guidare il G 7. C’è stato quindi un lungo cammino incominciato negli anni ’50.
Anche quando la DC ha governato con le forze centriste, i partiti liberali ecc. ed ha avuto la scivolata del governo Tambroni, durata poco, è sempre stato un partito ampiamente riformista, perché se non avesse assicurato e garantito ai ceti popolari di questo paese lavoro, sicurezza, salute, scuola per i propri figli, il Partito Comunista avrebbe vinto le elezioni. Non si riscrive la storia in un altro modo. Uno può fare tutte le scelte che vuole, ma una cosa è certa: la DC è stata ed è nata come partito antifascista che ha voluto dimostrare che non c’era bisogno di essere comunisti per fare politiche riformiste.
Il primo Centro-Sinistra nasce proprio per mettere chiarezza su questo punto. Il paradosso della storia ci dice che è stato più faticoso fare il primo Centro-Sinistra che il secondo. Moro come tutti i democristiani che avevano rapporti con l’Oltre-Tevere ha tribolato per far approvare l’accordo con il Partito Socialista più di quanto non abbiano tribolato per fare approvare la solidarietà nazionale con il Partito Comunista, perché quello è stato il passaggio, lo snodo degli anni Sessanta che ha aperto le prospettive degli anni successivi. In quel momento di grande cambiamento della società, l’accordo con il Partito Socialista, partito che aveva preso le sue distanze ormai dal frontismo con il Partito Comunista col quale si era presentato alle elezioni del ’48, è il compimento di questa visione degasperiana del partito di centro che guarda a sinistra, che fa politiche riformiste. In quegli anni si fa la prima riforma della scuola, si fa la nazionalizzazione dell’energia elettrica, incominciano determinate politiche che poi prepareranno la grande stagione riformista degli anni ’70, in dialogo con il Partito Comunista.
Perché tutto questo? Molto chiaro, basta andarsi a rileggere il discorso di Aldo Moro ai gruppi parlamentari del 27 di Febbraio del 1978, alla vigilia della sua cattura, della sua prigionia e poi della sua morte e del suo sacrificio. Moro dice alla DC, dopo i risultati elettorali, che il destino dell’Italia non è più solo nelle nostre mani. Siamo chiamati a costruire un percorso nel quale si realizza la legittimazione reciproca delle forze politiche a dare compimento alla democrazia. Infatti la democrazia trova il suo sale, almeno dal punto di vista del sistema politico, nella possibilità che nessuno sia escluso, una volta che ha il consenso popolare, dalla possibilità di governare e nessuno sia condannato a governare a vita. Noi abbiamo avuto per molti anni una democrazia bloccata perché la DC era condannata a governare e il Partito Comunista era destinato a stare all’opposizione, perché c’era la divisione del mondo in due blocchi. Tanto è vero che quando Moro inizia questo percorso, che aveva in qualche modo prefigurato Berlinguer col compromesso storico e Moro definì la solidarietà nazionale, chi dissentiva disse a Moro: “ Vuole andare avanti? Ne pagherà le conseguenze.” Moro ha pagato per tutti. Nell’idea di Moro non c’era mica l’Ulivo; c’era la legittimazione reciproca di queste due forze politiche: chi vince le elezioni governa, chi le perde fa opposizione.
Questa è la democrazia: non c’è nessuno che, se ha il consenso popolare, è escluso dalla possibilità di governare. In nome di che cosa? Io sono per le mie idee contrarissima a questo attuale governo, ma è legittimo, perché ha preso il consenso popolare. Sbaglia quando dice che rappresenta la maggioranza degli Italiani, perché in virtù della nostra legge elettorale, rappresenta una minoranza degli Italiani che diventa maggioranza in Parlamento. Questa, però, è la democrazia. Il problema è un altro. Sorge quando uno vince le elezioni, è legittimamente chiamato ad esercitare la funzione di governo e la trasforma in esercizio di potere arbitrario o in comando e si dimentica che in democrazia chiunque vinca le elezioni è chiamato a governare nel quadro della Costituzione, perché la democrazia appartiene al popolo che è sovrano. La sovranità, infatti, viene esercitata nelle regole della Costituzione. La solidarietà nazionale, nell’ottica di Moro, doveva servire a questo; la sua morte ha bloccato quel processo.
La DC del Congresso nel 1980, a poche settimane dall’uccisione di Piersanti Mattarella, che era l’erede del progetto moroteo in Sicilia (ammazzato dalle mafie per mano di un terrorista nero), e a una settimana dalla morte di Bachelet (ammazzato dalle Brigate Rosse), decide la politica del preambolo di Donat Cattin, che esclude qualunque rapporto con il Partito Comunista. Negli anni ’80, la DC continua a sentirsi condannata a governare con l’accordo non con il Partito Socialista del primo Centro-Sinistra ma con il Partito Socialista di Craxi.
Da lì, il disfacimento che tutti conosciamo conseguente a Tangentopoli e al crollo del muro di Berlino accompagnato dall’illusione di aver vinto. In quel momento in realtà la DC perde, perché l’elettorato moderato di destra, persino simpa-tizzante e nostalgico del fascismo, che votava per la DC perché era la grande diga contro il comunismo, non le attribuisce più quella funzione.
De Gasperi e Moro avevano fatto un miracolo perché avevano ottenuto la maggioranza relativa in questo paese con una parte di consenso che veniva da coloro che affidavano alla DC una funzione anticomunista. Nel momento in cui tale funzione è venuta meno, quel nucleo riformista che aveva guidato il paese non era più in grado, a quel punto, di trattenere quel consenso.
Poi arriva Berlusconi e nasce l’Ulivo e quelle forze politiche che hanno scritto la Costituzione si mettono insieme. Cos’altro si poteva per assicurare che la legittima alternanza al potere tra destra e sinistra, Centro-Destra e Centro-Sinistra si realizzasse nel quadro della Costituzione? La coalizione con la quale nel 1994 Berlusconi si presenta alle elezioni è una coalizione che include un partito che si chiama Movimento Sociale, erede di quelli che la Costituzione non l’avevano votata. L’Italia è stata ed è una grande democrazia anche per questo. Attenti noi: la Germania non ha fatto quello che ha fatto l’Italia. L’Italia ha una costituzione antifascista ma è una democrazia talmente forte che uno dei primi atti che ha compiuto la Repubblica italiana è stata in qualche modo la riabilitazione addirittura delle classi dirigenti fasciste in virtù del fatto che in democrazia c’è spazio per tutti. Qualcuno considera questo un grande errore, io lo considero una grande forza, una grande prova di forza. La democrazia non ha paura di chi la pensa diversamente. Va alla ricerca in sedi istituzionali di una sintesi che non risulti impositiva per nessuno, capace di interpretare le esigenze, gli interessi e i bisogni di tutti.
Certo, il Parlamento è lento e forse con regolamenti un po’ più veloci lavorerebbe meglio. Ma perché siamo lenti in famiglia, in un’associazione al Comune quando bisogna rispettare tutti e trovare un punto d’accordo? La partecipazione richiede tempo ma è preferibile a una decisione imposta presa in un minuto. Quei dibattiti, quei congressi sono lunghi e qualche volta hai l’impressione di perdere tante ore nella tua vita. Più veloce la sloganistica di questi tempi, ma anche meno capace di interpretare la complessità della realtà. La democrazia è questo e resta, comunque, per quanto imperfetta, la migliore di tutte le forme di governo.