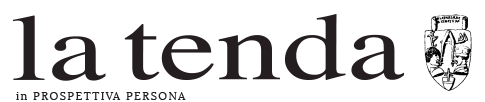Guardando gli eventi storici con curiosità intellettuale e volontà di comprenderne non solo gli aspetti evenemenziali ma anche quei moti e orientamenti che spesso, nello scorrere del tempo, possono modificarsi ma anche ripetersi ed agire di nuovo su nuovi scenari, io ho avuto l’impressione che nei primi trenta anni del secolo scorso apparentemente così lontani si possano scorgere orientamenti di pensiero e di azione che ci mettono in grado, con le loro innegabili similarità e anche diversità, di capire e gestire meglio la nostra vita attuale. E forse vale la pena di riesplorarne motivazioni e aspetti.
1900-1930: sono trenta anni di storia civile e culturale fra i più inquieti e, perciò, fra i più ricchi di movimenti, di intuizioni, spesso di realizzazioni. Sono anni destinati, quasi automaticamente, alla fertilità culturale per l’affermarsi di una concezione nuova, esplorativa e sperimentale della poesia. Si può tentarne una sia pur sommaria descrizione soltanto cercando un qualche appiglio in uno di quei sedimenti culturali che ciascuno di noi si porta dentro: magari una frase di Galileo, il quale nella giornata seconda del Dialogo sopra i massimi sistemi scriveva: “Cominciai a credere che se uno lascia un’opinione imbevuta col latte e seguita da infiniti per venire ad un’altra da pochissimi seguita, e negata da tutte le scuole e che veramente sembra un paradosso grandissimo, bisognasse che fosse mosso, per non dire forzato, da ragioni più efficaci”. Queste parole cadevano, è il caso di dirlo, come pietre su uno dei periodi più dinamici per la storia del pensiero scientifico: l’età della rivoluzione copernicana.
Non meno importanti sotto il profilo scientifico sono gli anni 1900-1930. Basta ricordare puri e semplici nomi: Einstein, Max Planck, Fermi per evocare una specie di terremoto scientifico, un mutamento di principi che per secoli erano stati basilari: quante ragioni “imbevute col “latte” caddero in quegli anni sostituite da altre, paradossali all’apparire ma che non cessano tutt’oggi di essere creative!
La domanda che ci possiamo porre allora è questa: se quelle nuove ragioni furono come colpi di piccone sui concetti tradizionali, sulle coordinate consolidate di spazio, tempo, moto, tali da condurre poi a un precipitoso declino la concezione meccanicistica della natura, se furono cioè, per dirla con Galileo “efficaci“, come operarono nel mondo della letteratura e della poesia in particolare?
La domanda non è un’assurda ricerca di parallelismi arzigogolati a ogni costo se già Edmund Wilson, pochi anni dopo l’uscita dell’Ulisse di Joyce, intravvedeva nella struttura del libro un’analogia con il modello di Einstein. Certo per cercare una risposta adeguata bisognerebbe percorrere un cammino lungo e dettagliato fra gli innumerevoli movimenti e le tante opere letterarie del tempo ma si può almeno cercare di fissare alcuni degli elementi determinanti del clima culturale dell’epoca. Anche perché trovano a volte sì a volte no corrispondenza nel nostro mondo attuale. Ad esempio:
1)la ricchezza di esperienze letterarie e, in particolare, poetiche volutamente nuove, esperienze spesso nate e concluse come avanguardie. Questa multiforme ricerca è molto simile nell’irrequietudine espressiva attuale tuttavia profondamente diversa nella disponibilità dei mezzi espressivi e comunicativi e forse anche nella creatività dei risultati;
2)la condizione oggettiva e soggettiva del letterato nell’ambito di quella civiltà, una condizione segnata dall’estraneità e dalla negazione. Una estraneità che mi pare oggi diversamente segnata dalla precarietà della fama, dalla esiguità dell’influenza sociale e anche dall’oppressione della spinta costrittiva verso la commercializzazione del prodotto artistico.
Ma torniamo a quei tempi. Mai come in quel periodo l’intellettuale europeo fu tanto inquieto ma conscio, nello stesso tempo, della sua ansia e della sua possibilità di scoprire, di disegnare, di inventare una realtà che poteva assumere le forme da lui volute, volta per volta; mai, come allora, la condizione dell’individuo fu sentita come fatto unico e incomunicabile e mai con tanta decisione si fuggì da una letteratura che fosse rispecchiamento del reale; si tagliarono allora violentemente i ponti con la narrazione naturalistica del secondo ottocento.
Eppure queste stesse ragioni della coscienza artistica non erano estraniate dalla realtà della società. Le condizioni nuove delle fasce sociali e dell’artista in particolare nello sviluppo industriale furono determinanti per le vie che la letteratura imboccò e che la coscienza poetica percorse. Anche qui è necessario il riferimento al quadro storico sia pure con citazioni sommarie: la prima guerra mondiale, la rivoluzione russa, l’avvento del fascismo e del nazismo, la grande crisi del’29 con il crollo di Wall Street. Credo, comunque, che si possano tracciare grossolanamente due sequenze fondamentali:
1)il passaggio dallo sviluppo industriale liberistico a quello monopolistico con il conseguente imperialismo. L’approdo delle tensioni introdotte da questo processo sarà la prima guerra mondiale;
2)lo sconvolgimento politico e sociale dell’Europa e il suo declino dalla scena mondiale dopo gli esiti della guerra con la conseguente crisi delle democrazie occidentali. Ognuno credo possa ora cercare a suo giudizio le similarità e differenze di queste tendenze nei tormenti del nostro tempo.
Nella prima sequenza si può collocare la presa di coscienza da parte di molti intellettuali del mutamento della propria condizione. Durante l’ottocento l’intellettuale europeo era stato l’interprete (prima attraverso l’idealismo romantico poi con la fiducia positivistica nel sapere e nella scienza) dello slancio della borghesia protesa alla conquista dell’egemonia politico-culturale affiancata al progresso produttivo, politico e civile. Tuttavia, alla fine dell’ottocento, erano già evidenti gli squilibri sia sociali, sia politici nello scenario internazionale, creati dall’organizzazione monopolistica verso la quale era stata indirizzata la crescente industrializzazione.
Sul piano economico, ad esempio, le stesse innovazioni tecnologiche avevano affermato come pericolosi concorrenti della potenza mercantile inglese il capitalismo americano vitalizzato dai big business, dalle corporazioni, dai trusts, oppure quello tedesco sostenuto dai potenti cartelli e sovvenzionato dallo stato prussiano. Non si trattava soltanto della sostituzione di un grosso soggetto egemonico, l’Inghilterra, con un altro, ma se così si può dire, di una filosofia produttiva con un’altra. Alla libera concorrenza sulla cui dinamica si erano slanciati la Rivoluzione industriale e tutto l’ottocento liberale, si era sostituita la strategia monopolistica entro cui il gioco politico e sociale si legava a centri di potere ristretti e sempre più autoritari.
Un cambiamento strutturale di indirizzi fondamentali sulla vita sociale, ovviamente, non poteva restare senza conseguenze sulla coscienza culturale. Di fronte a questa involuzione dei principi liberistici e liberali, propugnati prima dalla borghesia, l’intellettuale del novecento si colloca con un senso di estraneità e di sgomento. Decisamente interessante è, a questo proposito, il modo come molti poeti vivono il rapporto con un soggetto emblematico della civiltà industriale, la città.
Blocco d’acciaio, di mattoni e di vetro,-avvolta da reti di fili metallici,
tu sei un’instancabile maga,-un magnete che non si affievolisce.-
Come un drago predace senz’ali-rintanata tu vigili gli anni
e per le tue vene di ferro-circola il gas, scorre l’acqua.
E’ la voce di Valerij Brusov un poeta russo nel 1907.
Un po’ più ottimista ma anch’essa mista di paura e di attrazione è la descrizione dell’americano Carl Sandburg:
“Tra magnetiche maledizioni, faticosamente lavorando ad ammucchiare impresa su impresa, ecco la grande ardita lottatrice ergersi vivida tra le piccole effeminate città; feroce come un mastino dalla lingua pendula, pronto all’assalto, astuta come un selvaggio che sfida le asperità del deserto, a testa nuda ammucchi pianifichi cstruisci, distruggi, ricostruisci”
Inoltre si fa sempre più acuta da parte dei poeti la coscienza della crisi del proprio ruolo. Davanti a una società dominata dal pragmatismo degli affari, dalla realpolitik, dal peso dei rapporti finanziari, il poeta “perde l’aura” come afferma il critico tedesco W.Benjamin.
Come vive il letterato questa emarginazione sociale? La reazione non è razionale; anche se molteplice e variegata, è sottolineata da un atteggiamento diffuso di rifiuto che spesso si può esprimere nella fuga. A volte è una fuga nel proprio io che si ingigantisce, diventa ipertrofico e, intanto, non ha più la consolante universalità dell’Io romantico ma è individualista e spesso angosciante. Pensiamo, per questo, alla ricerca di Proust, alla sua fuga dal presente nel passato, tra i meandri della memoria oppure al senso soffocante di disperazione di Kafka per lo schiacciamento operato da un potere oscuro sull’uomo, all’individuo malato del boemo Rilke, al lucido esame della crisi dell’uomo borghese condotto da Thomas Mann e, in Italia, da Svevo e Pirandello.
Altre volte il rifiuto delle condizioni reali si esprime come affermazione orgogliosa del valore sublime del bello e della figura dell’artista o della tragedia esaltante della sua eccezionalità. Pensiamo all’estetismo raffinato di O.Wilde e a quello più casereccio di D’Annunzio. Oppure, sulla linea della poesia francese del secondo ottocento, il rifiuto della realtà spesso avviene con lo slancio verso il mistero toccato e mai svelato completamente dalle immagini della poesia: pensiamo alle visioni di Pascoli, anche se meno stravolgenti di quelle dei simbolisti francesi.
Infine, altri scrittori nell’area tedesca e russa si oppongono a una crisi che percepiscono come storica per la creazione di una nuova concezione sociale del poeta, della necessità del suo impegno di denuncia e di alternativa. Pensiamo ad alcuni scrittori russi come A.Blok e a qualche espressionista tedesco. Tutte queste esperienze hanno, comunque, in comune il senso di solitudine dell’artista, la sua non integrazione nella realtà presente e in alcuni questa alterità viene vissuta programmaticamente come denuncia, rivolta e opposizione anche formale. Ne “Il Cavaliere Azzurro“, una rivista di avanguardia nel 1912 Franz Marc scriveva: “E’ inevitabile che si apra un baratro tra la produzione artistica e il pubblico…L’isolamento di pochi, veri artisti è per il momento assolutamente inevitabile “
Parte I
Immagine in alto: Ritratto di Franca Florio di Giovanni Boldini, 1924