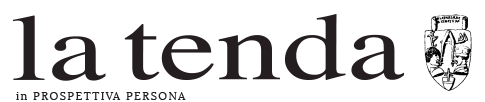Domanda: quando e come il termine «talento» è passato a indicare una dote naturale, una capacità innata, dato che in origine esso designava un’unità di misura di denaro (come è già ampiamente attestato nei poemi omerici)? In genere si dice che è stato Gesù il responsabile di questa traslazione metaforica di significato, con la parabola dei talenti da far fruttare, raccontata nel Vangelo di Matteo. Per essere sicuro ho posto la stessa domanda a ChatGpt e la risposta è stata sempre questa, cioè che il cambio di senso del talento ha origine evangelica. Eppure non è così, e proverò a dimostrarlo seguendo due vie.
La prima via è etimologica, giacché riconduce il termine greco τάλαντον all’atto del «bilanciare» (ταλαντεύω) e alla conseguente inclinazione della bilancia (ταλαντεία), quando si mettono su uno dei due piatti i pesi che possono essere d’oro, d’argento o di ferro. Platone, nel «Cratilo» (395e) spiega in questo modo anche il nome di Tantalo che, essendo stato molto goloso e dedito a ogni sorta di piaceri carnali, ricevette come punizione di contrappasso il fatto di restare inclinato a un perenne desiderio di sesso, di fame e di sete, sempre insoddisfatto e sempre stimolato da ogni sorta di delizie che improvvisamente gli comparivano e subito dopo sparivano. Pertanto, Tantalo è «infelicissimo» (ταλάντατον, superlativo di τάλας, «infelice», «sofferente»), e questo suo supplizio anche da Plutarco (nell’«Amatorius») è esplicitamente collegato ai suoi cosiddetti “talenti” (τῶν Ταντάλου λεγομένων ταλάντων), che altro non sono se non eccesso di desiderio e di eros (σὺν ἔρωτι πολλῷ καὶ πόθῳ). Persino Dante, nel canto di Paolo e Francesca riprende questo significato di talento come desiderio sfrenato e inclinazione irrazionale: «Intesi ch’a così fatto tormento / enno dannati i peccator carnali, / che la ragion sommettono al talento» («Inferno», V, 37-39). Pertanto, la metafora del talento si concentra sui pesi: così come questi fanno inclinare il piatto della bilancia in un senso o nell’altro, allo stesso modo gli amori possono inclinare l’anima in una o nell’altra direzione, positiva o negativa («pondus meum, amor meus», dice del resto anche Agostino nelle «Confessioni», XIII, 9, 10).
C’è però una seconda via, maieutico-socratica, che fa riferimento al rapporto di Socrate con i Sofisti, i quali si facevano pagare per insegnare l’abilità oratoria e le altre virtù. Quindi i “talenti” intesi come gettoni d’oro in cambio di capacità e virtù. Socrate contrappone a questo commercio la convinzione che ogni dote è innata, e quindi è in qualche modo un “talento” naturale che nulla ha a che fare con il denaro scambiabile. Platone dirà che il vero oro è la sapienza. Che questa idea sia anzitutto socratica, prima ancora che platonica, lo dimostra il fatto che si trova in tutte le altre fonti socratiche. Nelle «Nuvole» di Aristofane è proprio il Coro delle Nuvole (vv. 469 ss.) che si rivolge a Socrate, dicendogli di sapere bene che molti uomini bussano alla sua porta, desiderosi di comunicare con lui e avviare con lui un «discorso» (λόγον), per consultarlo su azioni e dichiarazioni giurate «di molti talenti» (πολλῶν ταλάντων), come è «degno delle sue doti mentali» (ἄξια σῇ φρενὶ). Le Nuvole invitano quindi Socrate a istruire gradualmente il vecchio Strepsiade, iniziando con l’«esame del suo intelletto» (διακίνει τὸν νοῦν) e con la «prova della sua mente» (τῆς γνώμης ἀποπειρῶ). Più avanti Socrate si chiede se sia possibile insegnare al giovane Fidippide a difendersi in tribunale, evocando il caso di «Iperbolo che lo imparò al prezzo di un talento» (v. 876: ταλάντου τοῦτ᾽ ἔμαθεν Ὑπέρβολος). Quando infine si confrontano il Discorso Giusto e il Discorso Ingiusto, quest’ultimo riprende il caso di Iperbolo che in realtà «fece fruttare molti talenti grazie alla sua malvagità» (v. 1065: Ὑπέρβολος … πλεῖν ἢ τάλαντα πολλὰ εἴληφε διὰ πονηρίαν), e con questi soldi, corrompendo i giudici, vinceva sempre in tribunale.Anche nei «Memorabili Socratici» di Senofonte troviamo un analogo riferimento ai talenti. In un passo (II, 5) Socrate si trova a discutere con Antistene sul valore dei servi e degli amici. Socrate lo esorta a «esaminare se stesso e a chiedere che valore avesse per i suoi amici» (ἐξετάζειν ἑαυτὸν ὁπόσου τοῖς φίλοις ἄξιος εἴη). Si era accorto che uno dei suoi compagni trascurava un amico povero e, pertanto, cominciò a chiedergli quanto valessero i servi: un servo può valere due mine, un altro meno di mezza mina, un altro cinque mine, un altro non meno di dieci. Nicia, ad esempio, ha dato «un intero talento per l’amministratore della sua miniera d’argento» (ἐπιστάτην εἰς τἀργύρεια πρίασθαι ταλάντου).
Quanto valgono allora gli amici? Anch’essi possono valere poco o molto, secondo Antistene, ma Socrate ribatte che i buoni servi non dovrebbero mai essere messi in vendita, né i buoni amici tradirebbero mai per denaro. In un altro passo (III, 6), Socrate discute con Glaucone (nipote di Carmide e fratello di Platone) sulla sua capacità politica di persuadere dapprima lo zio e poi le altre fratrìe a fare il bene della città. Dato che ad Atene ci sono più di diecimila case, ed è difficile provvedere a tante famiglie contemporaneamente, Glaucone dovrà cominciare facendo qualcosa per Carmide. Ma se non può fare nulla per uno, come farà ad avere successo con molti? «Se un uomo non può portare con sé un solo talento, è assurdo che cerchi di portarne più di uno (εἴ τις ἓν τάλαντον μὴ δύναιτο φέρειν, πῶς οὐ φανερὸν ὅτι πλείω γε φέρειν οὐδ᾽ ἐπιχειρητέον αὐτῷ;)»?Ma veniamo a Platone. Nell’«Eutidemo» (299 d-e), il sofista-erista sostiene che, se l’oro dà la felicità, allora bisognerebbe averne quanto più possibile con sé e dentro di sé, addirittura avere «tre talenti d’oro nella pancia e uno nella testa» (χρυσίου μὲν τρία τάλαντα ἐν τῇ γαστρί, τάλαντον δ᾽ ἐν τῷ κρανίῳ). Il sofisma di Eutidemo in realtà si spiega col fatto che i talenti nella pancia non sono monete d’oro deglutite, ma indicano la virtù della temperanza, così come il talento d’oro nella testa indica la virtù della sapienza.
Ci sarebbe anche una terza via matematico-metafisica, segnalata da Aristotele («Metafisica», I 1053a), secondo cui il talento, essendo un’unità di misura di valore, imita «la monade» (τὴν μονάδα) ed è pur sempre riconducibile alla «misura» (μέτρον) come principio della virtù e all’«uno» (ἕν) come principio del bene. Ma su questo ci vorrebbe un discorso molto più lungo. Ne parlerò più ampiamente al Festival Domosofia, il cui tema è appunto il talento.
Giuseppe Girgenti