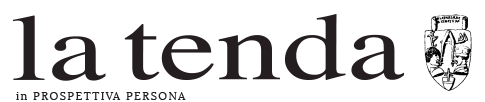(Dalla relazione pronunciata nella premiazione del Certamen dantesco della fondazione Celommi, 22 aprile 2024).
Parte I
Quell’aspirazione umana al benessere che in certe epoche abbiamo chiamato felicità agisce ed ha agito sempre come spinta propulsiva nella vita individuale e collettiva influendo notevolmente sul progresso umano. come bisogno permanente attraverso secoli e culture. Un aspetto della sua significatività possiamo trovarlo nella diversità di interpretazioni che la parola di definizione ha assunto nel tempo. Dal senso estetico ravvisabile nella parola greca eudaimonìa alla pregnante forza materialistica della latina felicitas, dalla radice fe di abbondanza, ricchezza.
La sua perenne influenza nella storia umana si è attuata in varie prospettive nelle diverse epoche culturali,(dalla proiezione cristiana nell’infinito dell’aldilà allo sprofondamento attuale nel culto terreno del denaro o nella dissipazione del consumismo) ma l’orizzonte della felicità non ha mai cessato di attirare i desideri umani. Ovviamente nella visione ideale e combattiva della vita che Dante ci delinea, il raggiungimento della felicità è posto nell’oltremondo attraverso il raggiungimento della beatitudine. Una beatitudine che non è affatto un’astrazione dal sentire ma una fantasmagorica compiutezza di mente e sensi umani: lo si nota già nella centralità della visione che riporta la realtà al soggetto che vede. La prima impressione del panorama descrittivo che Dante ci offre negli ultimi tre canti della Commedia difatti è quella della visualizzazione di un Paradiso non solo presentato ma di un Paradiso contemplato. Si ha subito il segno di una visione che mette in primo piano il rapporto tra l’armonia del creato con la compiutezza dell’uomo “finito” cioè perfezionato nel suo destino di creazione. Di conseguenza gli ultimi canti del Paradiso sono canti non solo pieni di divino ma anche colmi di umanità compiuta.
C’è da chiedersi quali siano le caratteristiche di questa visualizzazione che si presenta subito complessa, tanto da farci sentire il bisogno di un’analisi attraverso tre piattaforme per Dante forse progettuali e per noi percettive. Partiamo con le parole stesse del poeta dalla visualizzazione dello spazio: il cielo a noi profondo (v4) comincia a farsi tal, ch’alcuna stella perde il parere in fino a questo fondo (XXX, vv 4-6). Ci accorgiamo che siamo davanti a uno spazio cosmico illimitato, talmente profondo che potrebbe farci sorgere un senso di sgomento ma che, tuttavia, non ci condanna a un senso di paura perché si lega a un’osmosi armonica tra acqua e luce.
E’ così che dalla piattaforma spazio possiamo passare a quella della luce: così mi circonfulse luce viva, -e lasciommi fasciato di tal velo –del suo fulgor che nulla m’appariva (XXX, vv49-51). Le numerose allitterazioni fruscianti e in nasale danno anche sensitivamente l’idea del movimento vitale nel cosmo e poi nel sentire umano proiettandosi alla fine nella esplicazione della similitudine: di sua fiamma il candelo (XXX, v 54) ed esplodendo di movimento nell’immagine del fiume di luce (XXXvv61-66). Non si tratta, però, di una visione confinata lontana e bloccata nella sua perfezione. Gli elementi del paesaggio appaiono sempre in una intensità quasi circolare di movimento che si espande all’intorno in una specie di comunicazione irrefrenabile della bellezza ed è perciò naturale che in questa fluidità della visione si passi dall’elemento “luce” alla vitalità della piattaforma “acqua”: E come clivo in acqua di su imo c si specchia, quasi per vedersi adorno
Ha allora inizio una mirabile prova di rappresentazione visiva del fiume di luce nella quale non si può dimenticare la bellezza dell’aspetto rappresentata con le vivide immagini metaforiche dei topazi e la meravigliosa metafora del rider dell’erba. Ma la rappresentazione non si ferma alle linee dello spettacolo visto, include anche il vedente; palpita quindi nei versi un tremito di felicità di fronte a uno spettacolo meraviglioso che ha la caratteristica del rigoglio nella molteplicità delle sensazioni, a partire dagli odori nei movimenti bidirezionali delle faville che entrano ed escono in uno spendido gurge. La partecipazione di Dante però, non si ferma alle emozioni sensitive ma include anche l’attività razionale: La vista e ne l’altezza non si smarriva, ma tutto prendeva il quanto e il quale (XXX,vv118-119) e non si ferma neppure all’intendere, anzi dilaga nel sentire come appare nel canto XXXIII attraverso una spirale infinita di intensità sensitiva dopo la preghiera di San Bernardo alla Vergine: “E io ch’al fine di tutt ‘i disii appropinquava, sì com’io dovea, l’ardor del desiderio in me finii (XXXIII, vv46-48).
E’ una forza emotiva che si accende in una progressione segnalata anche dai suoni: e più e più intrava per lo raggio de l’alta luce…( XXXIII, vv 32-34). Si arriva come a un sublime delirio o, meglio, a una compiutezza di potenza sensitiva sulla quale potrebbe forse accendersi un sospetto di panismo e panteismo se non vi fosse a smentirlo il ricordo delle parole di Beatrice, che non solo ha richiamato nel XXX la mente alla linea di confine tra la grandezza divina e la debolezza umana attraverso ricordo del fallimento dell’impresa di Arrigo VII, ma l’ ha definita anche in termini più generali la cieca cupidigia che vi ammalia (XXX,v139) e anche la ferma attestazione dell’ordine verticale della Creazione: là dove Dio sanza mezzo governa /la legge natural nulla rileva. (XXX,vv122-123). Il passaggio dalla percezione della luce all’elemento acqua, già introdotto dalla metafora, a quello forse più quotidiano per le umane sensazioni dei colori appare come una esplorazione molteplice di sensazioni di piacere, nella vista con i colori e nell’olfatto nel miro gurge che appaga e nello stesso tempo accresce l’ altodisio che mo t’infiamma e urge (vv68-70). Niente, però, ha a che fare con con una divinizzazione panteistica della natura per la separazione tra il terreno e il divino
E tuttavia, nonostante il confine tra lo spazio del creato e quello del Creatore rimanga, questi canti sono pieni – come avverte Angelo Gianni – non solo di Dio ma anche di uomo, l’uomo Dante in una straordinaria capacità di assembrare movimenti e sensazioni. E la presenza dell’umano si già avverte in una terzina che sembra avere tutta la suggestiva malinconia della consapevolezza dell’infinito ineffabile anche nel suono delle parole, come il rincorrersi delle nasali e delle rotanti che riesce a rappresentarla con una specie di incanto doloroso: Così lo rimembrar del dolce riso la mente mia da me medesmo scema”(vv26- 27 ). Sembra però quasi che lo smarrimento sia stato sopraffatto, anche dentro l’ onda sonora delle allitterazioni, nel campo semantico della novella vista per l’aiuto che Dante riceve. E’ così che il paesaggio celeste diventa anche partecipazione umana, dell’uomo che ha rifiutato il male, si è purificato e ha perfezionato con la sua volontà il piano divino della creazione.