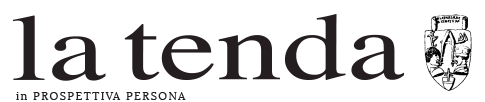I tempi sono maturi per chiedersi se il pacifismo ad ogni costo non sia una forma di neutralismo codardo e di accettazione tacita della violenza. Cosa facciamo se veniamo offesi, picchiati, derubati, bombardati? Possiamo limitarci a difendere la nostra pace se assistiamo ad atti di palese ingiustizia tra due parti, di cui una è più fragile? Se la necessità impone di proteggere i propri cari, i confini e gli interessi del proprio popolo, se falliscono gli sforzi diplomatici, ci si può sentire costretti a impugnare le armi. Come essere sordi a chi subisce un’aggressione, non riesce a difendersi da solo e chiede aiuto? Non possiamo propinargli vaghi richiami ai giusti principi. Prima o poi veniamo messi di fronte alla vacuità delle proclamazioni generiche per legittima difesa, per solidarietà o per dovere, facendo ciò che in teoria non ammetteremmo mai. Eppure il più delle volte si sente parlare di guerra e pace limitandosi ad indignarsi contro la crudeltà, specie su donne e bambini. Nelle relazioni quotidiane, come tra gli Stati, ingiustizie, conflitti e violenze (verbali e di fatto) contraddicono e soffocano la profonda e universale aspirazione alla pace.
In famiglia i genitori cercano di evitare che i figli vedano immagini shock, che arrivano a fiotti nelle nostre case attraverso i media, ma ormai le nuove generazioni si sono abituate alla guerra come uno spettacolo non di rado ‘avvincente’. I bravi genitori ascoltano e rilanciano le sollecitazioni del Papa, ma poco sanno testimoniare sulla necessità di gestire la pace nelle relazioni quotidiane. Del resto non è il caso, specie con i più grandicelli, di indugiare su un pacifismo di bandiera, parolaio e in pantofole, pago del proprio focolare che si chiude agli estranei.
Non si possono chiudere occhi e orecchie alla realtà, che impone di prendere atto che le guerre tornano a ondate. Se la nostra generazione forse riuscirà a passare indenne, non sarà così per figli, nipoti e pronipoti. Continuiamo pure ad ascoltare i richiami e costruire per quanto possibile la pace attorno a noi, ma sapendo che essa non è una conquista definitiva, un capitolo chiuso dopo la seconda guerra mondiale. La guerra esiste e basta, rispunta qua e là come l’ineliminabile della storia, è sorda alle prediche, si beffa dei sogni di pace a basso prezzo e dello sdegno dei pacifisti; diffida delle manifestazioni plateali, delle omelie degli idealisti e dei pacifisti, delle bandiere multicolore.
A tutti piace abitare un mondo pacificato. Non ho ancora incontrato qualcuno che dica di non volerlo e non sbandieri ai quattro venti la propria buona disposizione. Eppure lungo il corso della storia non sono pochi coloro che avrebbero voluto evitare la guerra e sono stati obbligati a farla. La pace la vuole Putin, se gli si concede Donbass, Crimea, ecc., verosimilmente la vuole l’Ukraina (se riesce a ricacciare i russi nei propri confini); la vogliono gli USA, se la Russia riconosce il suo potere e sta paga dei confini; la vuole Israele, se le si concedono i territori ambiti dai coloni, la vogliono i palestinesi, se si cancella Israele, la vogliono gli Houthi (branca minoritaria dell’Islam sciita) in funzione anti-USA e anti-Israele (soprattutto dopo l’invasione americana del 2003 in Iraq), la vuole l’Europa, a difesa dei propri principi e degli interessi commerciali. La realtà effettuale è diversa, anche quando la guerra viene celata dietro un lessico particolarmente adatto a creare confusione: ‘operazione speciale’, “armate disarmate”, “guerra giusta”, “armate pacifiste”, “pacifismo armato”, “missioni di pace”, “ingerenza umanitaria”, “politica internazionale”, “guerra preventiva”, “missione di pace”. Sono espressioni edulcorate che servono ad esorcizzare la guerra, a rimuoverla dalla coscienza della gente e trasfigurarla.
Sarebbe fuorviante e persino diseducativo indurre a credere che si possa vivere in una pace irenica, in famiglia come nei più estesi rapporti sociali e politici. Si può eliminare la parola guerra dal vocabolario, ma non dalla vita, come non è possibile fronteggiare la prepotenza con la buona educazione o trasformare le bombe in pallottole di carta. Si può fare l’impossibile per evitare la guerra, la si può governare con regole più cogenti, ma come realizzare con le nostre forze un mondo in cui il lupo e l’agnello si abbracciano?
Eppure, anche se consapevoli che lo sviluppo si realizza passando attraverso e oltre i conflitti aperto o latenti, gli esseri umani non cesseranno di perseguire ostinatamente la pace. Auschwitz e la ferocia degli scontri Oriente-Occidente, destra sinistra, conservatori-progressisti, ci costringono ad ammetterne la fragilità e la instabilità. Mostrano che il male non è stato affatto eradicato dall’animo umano ed erutta violentemente e senza preavvisi. La storia non procede per via lineare verso orizzonti sempre più pacificati, come volevano gli evoluzionisti, fiduciosi nel progresso a 360 gradi.
Sarebbe il caso di rileggere Dandieu, quando diceva che i pacifisti sono i peggiori nemici della pace. A sua volta Simone Weil, sindacalista pacifista fino al 1938, che giudicava ogni guerra la tomba dei buoni ideali, dopo il suo viaggio in Germania (1932) si rese conto che i comunisti pacifisti erano tiepidi nei confronti del nazismo e li giudicò corresponsabili: avrebbero dovuto affrontare il toro per le corna usando la forza. «Dal giorno in cui – ha scritto – dopo una lunga lotta interiore, ho deciso in me stessa che, malgrado le mie inclinazioni pacifiste, il primo dei miei doveri diveniva ai miei occhi perseguire la distruzione di Hitler con o senza speranza di successo, da quel giorno non ho mai desistito; è stato il momento dell’entrata di Hitler a Praga… Forse ho assunto tale atteggiamento troppo tardi» (S. Weil, Scritti sulla guerra 2005).
La pace non è un diritto da rivendicare urlando slogan spesso violenti, cantando canzoni che invitano a mettere i fiori nei cannoni, sbandierando bandiere colorate, dividendo il mondo in amici e nemici, fomentando l’anti americanismo e l’anti capitalismo (lo si è fatto a lungo nel secondo dopoguerra, specie a partire dagli anni Sessanta e Settanta). I popoli che godono della loro pace ne parlano troppo, quelli schiacciati dalla brutalità del potere giungono ad augurarsi una guerra per poter rimuovere situazioni incancrenite. Questo hanno desiderato, sino alla caduta del muro, non pochi intellettuali dell’Est, che hanno rimproverato all’Occidente il pacifismo satollo di chi difende i privilegi dei diritti conquistati e fa come lo struzzo, per non mettere a rischio la propria pace (‘quieta non movere’). Una pace stagnante è la palude egoista dei sazi sulla pelle degli affamati.
La visione realistica non esalta di certo la guerra – come taluni hanno fatto specie nel passato – come fonte di avventura, di rimescolamento delle classi, di rinnovamento della storia (allo scoppiare della prima guerra mondiale, ci sono cascati anche grandi nomi come Thomas Mann, poi pentito amaramente). Si tratta semplicemente di non cullare operazioni di funambolismo concettuale, di rimestamento magico di parole per edulcorare la realtà. In tutti gli ambiti, occorre prevenire, ascoltare le diverse prospettive, gestire diplomaticamente i conflitti in atto, rifiutare letture semplificate e retoriche che riducono la guerra all’estremo maleficio dei cattivissimi, Hitler in testa. La pace è un compito gravoso da perseguire ostinatamente e costantemente. A volte costa la vita.