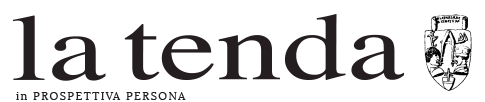Regia di J. Glazer, con Sandra Huller, Christian Friedel
La zona di interesse non è un film, è un’esperienza dolorosa e terribile, che non riesce nemmeno ad assumere valore catartico, perché troppo grande è l’orrore che ci trasmette. All’inizio c’è solo uno schermo vuoto, con rumori di fondo disturbanti, persistenti e lontani, che ci accompagneranno come agghiacciante colonna sonora per l’intera durata del film. La scena poi cambia e ci troviamo in un idilliaco paesaggio in riva al fiume dove una famiglia con dei bellissimi bambini biondi si riposa trascorrendo ore serene. Si tratta della famiglia di Rudolf Hoss, comandante di Auschwitz, che con la moglie ha scelto di vivere nella “zona di interesse”, termine con cui i nazisti chiamavano la zona di quaranta chilometri adiacente i campi di concentramento.
La vita della famiglia trascorre serena in una villa completamente ristrutturata, con prati fioriti, piscina, orto, serra. I bambini giocano, bisticciano, studiano. La signora Hoss si dedica alla loro educazione, alla cura delle piante, alle relazioni sociali con amiche e colleghi del marito, e sua madre, venuta a trovarla dalla Germania, ne è orgogliosa: mai avrebbe sperato che sua figlia potesse raggiungere un simile benessere. Il comandante Hoss lavora con coscienziosa devozione alla causa nazista: valuta l’opportunità di realizzare un nuovo tipo di forno per accelerare le operazioni nel campo, riceve encomi dai superiori e viene promosso a supervisore di tutti i campi di lavoro. L’orrore è al di là del muro che divide la casa dal campo di sterminio e lo nasconde – non completamente, però, tanto che la padrona di casa progetta di piantarci davanti molte piante di viti – ma gli abitanti della villa lo ignorano o meglio sono abituati a viverci e conviverci. Da lì arrivano calze e sottovesti da regalare alle domestiche, un’ elegante pelliccia che la signora indossa ammirandosi allo specchio e persino denti di metallo prezioso con cui i bambini giocano come fossero sassolini. Ogni tanto passa un treno, si sentono spari e lugubri latrati, il fumo si fa più denso e il fiume si riempie di cenere e polveri, usate anche come concime. E’ puro orrore.
In sala lo sappiamo che cos’è stata la Shoah, sappiamo che il film parla di persone e fatti reali, eppure siamo costretti a non guardare dietro il muro, ne siamo tenuti fuori, respinti ma nello stesso tempo tenuti incollati da suoni e schermate vuote o simboliche via via più inquietanti. Il finale è altrettanto spiazzante. Con un salto temporale ci troviamo nell’Auschwitz di oggi con le custodi addette alle pulizie che spazzano e lavano i pavimenti, spolverano con igienizzanti spray i forni crematori e le teche contenenti migliaia di scarpe o abiti o valigie: è diventato “normale” anche l’orrore del ricordo.
Il film è liberamente ispirato al libro omonimo di Martin Amis e ha ottenuto positivi giudizi di critica e pubblico. Candidato all’Oscar come miglior film, migliore sceneggiatura e miglior sonoro, frutto di una coproduzione Gran Bretagna/Polonia ha la particolarità di esser stato girato in tedesco e non in inglese come nella maggioranza dei casi. Da vedere senz’altro per cercare quanto meno di non essere impassibili e fatalisti di fronte alla spettacolarizzazione dei drammi di guerra che stiamo attualmente vivendo.