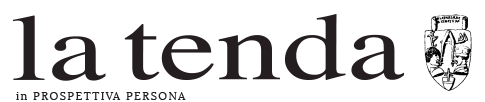La tragedia Medea è altamente espressiva del mondo concettuale euripideo, è la più famosa tragedia del drammaturgo, ottimo indagatore dell’animo umano. Per la prima volta nella storia della tragedia greca il conflitto si dibatte entro un animo solo: è lei Medea che da sola, barbara e abbandonata, si dilania negli opposti sentire, lacerata tra razionalità e passione, insicurezza e decisionismo. Mentre nelle tragedie di Sofocle Antigone trova il suo antagonista in Creonte, qui l’antagonista non c’è. Giasone è una figura sbiadita, borghese, opportunista, non un uomo degno di spessore eroico, anzi diremmo che è l’anti-eroe per eccellenza. La tragedia, benché ad essa sia legata gran parte della fama di Euripide, non vinse alle Grandi Dionisie del 431 a.C., ma si piazzò terza, dopo un’opera di Sofocle, vincitore, e di Euforione ( figlio di Eschilo) secondo classificato.
Il che dimostra che i tempi ad Atene non erano maturi per accogliere e interiorizzare il messaggio innovatore di Euripide che spostava l’attenzione dal dio all’uomo, indagato con il bisturi dell’analista. La radicale impostazione psicologica e il conflitto conseguente sono il segnale della crisi della polis, che non si ritrova più nei suoi antichi costumi e si prepara a perdere la dimensione di città-stato democratica cadendo sotto l’egida prima degli Spartani e poi dei Macedoni. Dobbiamo immaginare una rivoluzione copernicana, in cui tutto ciò che si è acquisito in termini di grandezza eroica e di stabilità politico-sociale frana sotto l’ascia della guerra del Peloponneso, che decreta la vittoria di Sparta. Nel 431 a.C. siamo dentro la guerra che coinvolse tutta la Grecia, perché tutti si schierarono con Atene o con Sparta e amaro fu il destino di chi si astenne, come ci ricorda Tucidide nelle sue Storie, riferendoci l’episodio dell’isola di Melo, che, non schieratasi, venne rasa al suolo.
La psicologia di Euripide scava dentro l’animo umano e ne esprime tutto il disagio esistenziale, frantuma l’essere tetragono e apre faglie di debolezza e momenti di amarissima riflessione sulla condizione umana. L’essere si moltiplica nelle sue infinite sfaccettature e ha difficoltà a parlare con se stesso, figuriamoci con gli altri! Siamo caduti nella temuta incomunicabilità tra gli umani e gli dei sono assenti; se appaiono, sono solo fantocci utili a risolvere l’intreccio, il famoso deus ex machina; ma questo non interviene nella tragedia di Medea trascinata dalla più spasmodica tensione verso un tragico finale.
Andiamo alla trama: dopo la conquista del vello d’ora nella Colchide (si vedano gli Argonauti di Apollonio Rodio), Medea e Giasone si trasferiscono a Corinto, insieme ai due figli. Va detto che Medea è un nomen omen e significa Maga, ha la radice del verbo medèomai, curare con intrugli magici; è lei che fornisce a Giasone il farmaco per addormentare il drago custode del vello d’oro; quindi, è grazie a lei che l’impresa si compie. L’ardimento e la passione della eroina sono non comuni per i Greci, infatti lei è la barbara donna che tradisce la sua gente, suo padre, e uccide il fratello Ipsirto per inseguire il suo amore. La grandezza della figura sta proprio nella potenza del mondo irrazionale che la travolge senza mediazioni, lei è puro istinto e acceso furore, lei è corpo e anima che amano fino all’autodistruzione. Dopo qualche anno però di convivenza a Corinto, Giasone si rivela in tutta la sua bassezza e meschinità, ripudiando Medea per sposare la figlia di Creonte, re di Corinto; il che gli darebbe diritto di successione al trono.
Egli è dunque l’uomo freddo e calcolatore, scialbo e opportunista che non sa cosa sia la passione e nella sua sprovvedutezza disarmante non riesce a presagire gli effetti della sua decisione nel fiero animo della barbara, che non si è mai integrata nell’ambiente che la ospita, dove si sospetta di lei in quanto straniera e dotata di una superiore sapienza (la magia, appunto). Tutta la tragedia si svolge dentro il suo animo ed è straordinario come in questa rivoluzione euripidea lei, barbara, risulti l’eroina, mentre il greco Giasone è l’ombra di se stesso: figura assolutamente secondaria. Lui sa opporre solo convenienti ragionamenti, mentre Medea con ardore e passione incontrollate si lamenta col coro delle donne corinzie. Creonte, che sospetta una vendetta, le ordina la lasciare la città. Ella finge di scendere a miti consigli e ottiene di rimanere un giorno, che le servirà per realizzare il piano. In un colloquio drammatico con Giasone, parodia dell’eroe mitico, si scava un abisso incommensurabile tra le due figure; sicché Medea decide di infliggere al traditore una terribile vendetta. A ciò la induce un viluppo di sentimenti, che ella è in grado di esaminare razionalmente ma non di superare col cuore; sicché in lei dibattono diverse anime, come dicevo sopra, ma soprattutto razionalità e passione; questo configgere ne fa un personaggio straordinario. Si sente frustrata nella sua sessualità, ordisce la vendetta, ha orrore dell’isolamento, smania di affermare la propria personalità superiore, consapevole della sua forza intellettuale, interpreta profondamente il senso della giustizia violata.
Il tutto genera un’ansia disperata che la induce al progetto fatale: per vendicarsi dell’uomo annienterà ciò che ha di più bello: i suoi figli, ferendo a morte la sua maternità. Masochismo femminile? Freud direbbe di sì, si tratta di un autentico progetto di autodistruzione. Manda quindi i figli dalla novella sposa con in dono una ghirlanda e una veste avvelenate. La fanciulla, indossatele, muore in fiamme insieme al padre che tenta di salvarla. I poveri bimbi, che non parlano mai, vittime sacrificali, ora non hanno più scampo: Medea li uccide con le proprie mani, poi si leva con i loro corpi sul carro del Sole suo progenitore, irridendo crudelmente allo strazio di Giasone.
Vendetta, atroce vendetta che è affermazione della dignità della donna, conculcata in Atene, polemica contro le argomentazioni di una falsa giustizia, interpretata da Giasone, accusa contro l’isolamento dell’intellettuale, ma in primis rivendicazione del libero arbitrio nel bene e nel male. L’uomo, rimasto senza dei, è faber fortunae suae, anche se il pessimismo euripideo identifica tale destino con un processo di autodistruzione.