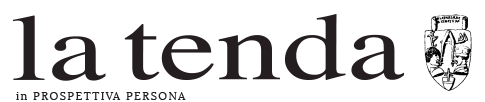Impressioni e ricordi
Un secolo con Calvino è il titolo dovuto all’occasione, sotto il quale, però, si stende il fil rouge di un Calvino favoloso e mitico.
È questo soltanto un tributo di affetto a una intelligenza proteiforme e insieme rigorosa, ma soprattutto trascinante e liberatoria… Dalle Fiabe italiane ascoltate da bambino a quelle lette a mia figlia, alle numerose suggestioni intellettuali e fantastiche dei suoi scritti, Calvino ha esercitato su di me un’impressione profonda, certamente non coltivata con giudizio né assiduità, ma sentita e apprezzata. Se, però, questo non facesse parte del suo stesso modo di pensare la scrittura, non ci sarebbe motivo per rendere pubbliche le mie impressioni, perché di queste, e non d’altro, si tratta.
Il percorso «mitico» è suggerito da una serie di circostanze – la mia formazione di stampo antichistico (Lettere classiche con tesi in Numismatica antica) e da aspetti dell’opera di Italo Calvino; un’opera che – a dispetto dei suoi numerosi interessi culturali (cinema, fotografia, disegno e pittura, ecc.) e della sua caleidoscopica produzione – sembra basata sulla necessità
dell’affabulazione, del narrare a qualcuno che ascolta (o legge). Cifra essenziale di Calvino è trasformare tutto in racconto, apologo, mito, cioè in una lingua capace di penetrare la nostra attenzione, lontana dagli spigoli dei lessici burocratici, ma vicina alla precisione del linguaggio tecnico, che è quello di chi ha da dire qualcosa; lontanissima dalla georgica profusione di
descrizioni o estenuate adesioni al “paesaggio sentimentale o storico”. Queste ultime – si ha l’impressione – devono essere rimaste imprigionate nelle maglie di ormai vecchie, troppo vecchie prescrizioni (penso addirittura al peso di Cicerone o di Quintiliano).
La polemica con Pasolini sulla lingua italiana e gli articoli di Calvino apparsi in Una pietra sopra – soprattutto il fortunatissimo articolo L’antilingua (più o meno recentemente riscoperto) – testimoniano con chiarezza il dato da cui partire. E come qui l’intento critico si serve dell’invenzione di un «brigadiere» burocrate della lingua, così il riassunto stesso dell’Orlando furioso si trasforma in amabile invenzione (sotto alla quale potremmo addirittura scoprire i dettami di
una critica attanziale): «In principio c’è solo una fanciulla che fugge per un bosco in sella al suo palafreno. Sapere chi sia importa sino a un certo punto: è la protagonista d’un poema rimasto incompiuto, che sta correndo per entrare in un poema
appena cominciato (I. Calvino, Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino. Con una scelta del poema,
Torino, Einaudi, 1970, p. 3).
Proprio in questa occasione, nell’introdurre la Chanson de Roland e il ciclo carolingio, le sue parole colgono l’essenziale (mai detto con tanta forza e chiarezza): questo «oscuro fatto d’armi» è ingigantito dalla sua essenza mitica e solo in virtù di questa si propaga per la letteratura.
Allo stesso modo, Calvino, per spiegare agli studenti delle scuole medie il suo Barone rampante, si inventa un cavillosissimo e astioso esegeta del suo romanzo: Tonio Cavilla (anagramma di Italo Calvino). Poi, di fronte a un’opera di un artista a lui congeniale come Fausto Melotti – Gli effimeri, nella mostra fiorentina a Forte Belvedere (1981) –, lascia che la sua interpretazione ricorra a una filosofica fantasia, che resta una delle pagine più intense della sua produzione (poi confluita in Collezione di sabbia del 1984):
Le effimere nella fortezza
Uno sciame di effimere volando in una fortezza si posò sui bastioni, prese d’assalto il mastio, invase il
cammino di ronda ed i torrioni. Le nervature delle ali trasparenti si libravano tra le muraglie di pietra.
“Invano vi affannate a tendere le vostre membra filiformi” disse la fortezza.
“Solo chi è fatto per durare può pretendere d’essere. Io duro, dunque sono; voi no.”
“Noi abitiamo lo spazio dell’aria, scandiamo il tempo col vibrare delle ali. Cos’altro vuol dire essere?”,
risposero quelle fragili creature. “Tu, piuttosto, sei soltanto una forma, messa li a segnare i limiti dello spazio e del
tempo in cui noi siamo”.
“Il tempo su di me scorre: io resto” insisteva la fortezza. “Voi sfiorate soltanto la superficie del divenire
come il pelo dell’acqua dei ruscelli”.
E le effimere:
“Noi guizziamo nel vuoto così come la scrittura sul foglio bianco e le note del flauto nel silenzio. Senza di
noi non resta che il vuoto onnipotente e onnipresente, così pesante che schiaccia il mondo, il vuoto il cui potere
annientatore si riveste di fortezza compatta, il vuoto-pieno che può essere dissolto solo da ciò che è leggero, rapido
e sottile”.
Date queste premesse, non sarà difficile scoprire, anche sulla scorta delle sue letture – Claude Lévi-Strauss, Marcel Detienne, Roger Caillois, Roland Barthes e gli amici dell’OU.LI.PO – che la sua è la vena di un mitografo, e che lo è stata fin dal Sentiero di Pin, per arrivare alle Fiabe italiane, a Marcovaldo novello picaro, alle Cosmicomiche vecchie e nuove, alle selve ombrose e ‘opache’, dentro le quali, prima ancora che nelle scoperte della modernità, si annida il caos combinatorio, quello che, come nell’antichità, precede il cosmos. Per non parlare dei Castelli o delle Taverne. E come concepire le Metamorfosi ovidiane – altra dimensione speciale del narrare, in assoluto – senza quel suo titolo de Gli indistinti confini? (1979)
Il discorso sulle Città – la forma del cosmos?– è troppo complesso e richiede troppo tempo per essere sviluppato; può, dunque, provvisoriamente arrestarsi su un pensiero dello stesso Calvino:
Non ha capito nulla dei muri chi ha preteso di farli parlare inalberandovi parole scritte: i muri si esprimono
nei lunghi silenzi della luce e dell’ombra, o negli sguardi ciechi delle finestre in fila (Il silenzio e le città, 1982; per Fabio
Borbottoni [1820-1902, autore di vedute fiorentine], da Guardando disegni e quadri).
Raffaele Giannetti