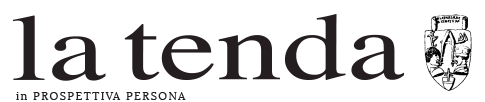Anche nel mondo romano esisteva il culto dell’amicizia. Sul piano pratico il termine indicava spesso il rapporto tra soggetti appartenenti a ceti sociali diversi; si trattava di un rapporto asimmetrico per cui i cittadini del ceto inferiore, i clientes, si mettevano sotto la protezione di un cittadino influente, cui era dovuta assoluta fedeltà da parte del protetto, e si basava su motivi di interesse, al contrario dell’amicizia che si fonda su un rapporto tra pari o simili, e rappresenta un legame etico importante anche nell’ambito sociale. Tale distinzione si riallaccia alla differenza stabilita dai pensatori greci, in particolare Aristotele, tra l’amicizia fondata sull’utile e sulla convenienza e quella nobile e disinteressata.
Nel periodo ellenistico il pensiero e la civiltà della Grecia influenzarono profondamente la cultura romana; l’epicureismo, accolto da Lucrezio, ebbe diffusione limitata, mentre lo stoicismo ebbe un’influenza più ampia e prolungata nel tempo. Gli intellettuali più importanti che raccolsero l’eredità ellenica, ma in modo diverso, furono Cicerone e Seneca; Cicerone
accolse gli spunti di più correnti filosofiche in funzione di una realtà politica e sociale diversa da quella greca, mentre Seneca cercò di moderare il rigorismo originario dello stoicismo. Entrambi gli autori vissero esperienze di conflitti politici e disordini sociali, di fronte ai quali sentirono il bisogno di rivolgere esortazioni e precetti capaci di indurre al bene e alla virtù, cioè alla felicità; entrambi ritenevano l’amicizia un elemento essenziale dell’etica e un fattore importantissimo nella pratica della vita virtuosa.
Il tema dell’amicizia è sviluppato da Cicerone nel dialogo Laelius de amicitia e da Seneca nelle Epistulae morales ad Lucilium. A differenza del trattato filosofico aristototelico, le forme preferite dai due autori romani, il dialogo e la lettera, denotano il desiderio di mantenersi aderenti alla realtà concreta, coniugando la trattazione della tematica con l’esortazione alla meditazione e alla pratica della virtù. In entrambi riscontriamo il diffuso preconcetto sull’epicureismo, considerato dai romani una dottrina volgarmente edonistica.
Il Lelio ciceroniano, ambientato nel 129 a.C. e scritto nel 44 dopo la morte di Cesare, rievoca la figura umana e politica di Scipione Emiliano, e ne esalta le virtù, il coraggio, la generosità, la bontà, la gentilezza. Il dolore per la perdita di Scipione è temperato dalla consapevolezza di essere vissuto in amicizia con lui e di aver condiviso “l’impegno per le cose pubbliche e per le private”, nonchè l’amore per gli studi. Nel dialogo Cicerone intreccia la celebrazione di Lelio con la trattazione dell’amicizia,
proponendo una concezione diversa da quella tradizionale di un legame basato su rapporti di convenienza o utilità. Cerca di stabilire un fondamento etico ricollegandola alla virtù, ritenendo che tutti gli eventi umani sono inferiori rispetto alla virtù: l’amicizia è propria dei “boni viri“, e in essa devono coesistere probitas e virtus, fides e constantia. Dell’amico dovremo fidarci come di noi stessi, perciò bisogna trovare chi è veramente degno di amicizia in modo da poter discutere con lui di ogni cosa “senza timore“. E’ necessario scegliere con cura l’amico perchè con lui si condividono anche i propri segreti senza timore di
essere traditi. Ne consegue che non si deve riporre la propria fiducia in chi non si conosce bene: non ci si può confidare con degli sconosciuti né con persone che non abbiano una giusta condotta.
La fedeltà è l’elemento più importante sia nei rapporti privati sia nella vita pubblica ( nec enim ulla res vehementius rem publicam continet quam fides), ma occorrono anche la sincerità e un comportamento amabile. L’amicizia è “conveniente” sia nelle situazioni favorevoli (ad res vel secunda) sia in quelle sfavorevoli (adversa), per questo è possibile solo tra i buoni. L’autore dimostra un atteggiamento aristocratico in quando distingue tra l’amicizia tra i buoni e quella comune, rifacendosi alla distinzione aristotelica dell’amicizia tra simili e dissimili: se l’amicizia si basa su lealtà, integrità, generosità, fermezza, senza cupidigia e imprudenze, è possibile solo tra pari (i boni viri). Senza virtù non ci può essere amicizia: solo coloro che ripongono il sommo bene nella virtù si trovano d’accordo su tutte le cosa umane e divine e trattano fra loro con benevolenza e affetto. Coloro che sono dotati di virtù e saggezza sono autonomi e sicuri di sé e non hanno bisogno di niente per coltivare l’amicizia, al contrario di quelli che riducono tutto al piacere perchè non guardano a nulla di alto. Il dialogo contiene anche una “precettistica”, quasi guida alla scelta dell’amico: controllare l’impeto degli affetti; scegliere come amico chi cerca di migliorarsi e rendere l’altro migliore; distinguere la vera virtù dalla parvenza di virtù; rifuggire dalla falsità, dall’adulazione e dalla demagogia in politica; sia nell’amicizia sia nella vita pubblica commisurare il valore sulla verità. In tal modo, condividendo una vita virtuosa, si può conseguire la felicità.
Il desiderio di conseguire la felicità è alla base anche del pensiero di Seneca, uno dei massimi esponenti della cultura romana. L’antica Stoà, cui egli si ispirava, concepiva una virtù “assoluta”, contrapposta radicalmente al vizio, così il saggio poteva attuare la virtù solo chiudendosi in se stesso in condizione di indifferenza, volto solo a conoscere e ad adeguarsi all’ordine naturale nel quale era inserito, in una prospettiva in cui non avevano senso né il consiglio né l’esempio dell’uomo virtuoso; ma nel mondo romano non era concepibile un individuo isolato: ciascuno faceva parte dello stato, anche se in posizione
di sudditanza. Nella sua concezione etica sono presenti i due capisaldi dello stoicismo antico: la coincidenza di virtù e felicità e l’autonomia del saggio, e in tale prospettiva si colloca il tema dell’amicizia. Seneca intende la virtù non tanto come adeguazione all’ordine razionale dell’universo, come i pensatori greci, quanto come ricerca costante di perfezionamento dell’animo; in tal modo cambia anche la concezione del saggio, che non si può chiudere completamente di fronte alle difficoltà e isolarsi in una inattaccabile “imperturbabilità”, ma deve porsi come paradigma e guida per gli altri. A tale convinzione si
lega la scelta della forma letteraria, l’epistola, che meglio si presta al tono precettistico del suo insegnamento etico.
Essere saggio non vuol dire stare lontano dalle contrarietà, ma cercare di vincerle; non vuol dire stare lontano dagli altri, ma cercare dei veri amici: “…il saggio basta a se stesso non nel senso che vuole vivere senza amici, .. ma che lo può. .. tuttavia non li cerca per essere felice; anche senza amici egli è felice“, poiché la felicità, sommo bene, nasce dall’interno. Il filosofo riconosce che nell’uomo esiste un “impulso naturale, un’attrazione istintiva”, che lo spinge a desiderare degli amici. Tutti cercano di avere amici, ma il saggio cerca la virtù nell’amicizia, pratica l’amicizia come un bene fine a se stesso, senza nessun interesse di carattere egoistico o utilitaristico . Per questo deve scegliere con discernimento gli amici; infatti se stare con l’amico vuol dire stare con se stesso, è necessario trovare colui che è veramente degno di fiducia, con cui poter discutere senza timore di qualunque cosa e a cui poter confidare i propri segreti senza timore di essere tradito. Non ci si può fidare degli sconosciuti né di persone che non abbiano un retta condotta di vita. “.. Il saggio basta a se stesso per vivere felice. Non per
vivere. Per vivere, infatti, ha bisogno di molte cose; per la felicità solo di un animo retto, coraggioso e
noncurante della fortuna” (cfr. Lettere a Lucilio I, 3,9).