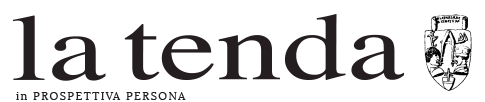Vorrei parlare un po’ del linguaggio agricolo-pastorale, per rammentare alcuni vocaboli e modi di dire. Ci sarebbe anche qualche imprecazione, ma non mi sembra il caso.
Il duro lavoro di contadini e mandriani, a continuo contatto con la varietà della natura, riempiva le loro bocche di espressioni multiformi, talvolta persino divertenti.Ricordo qualcosa che riguardava per esempio il granturco, che iniziò ad esser chiamato mais più o meno da quando quello “nostrano” – così buono arrostito o lessato – venne soppiantato dal cosiddetto “americano”, più conveniente sotto certi profili.
Nella grande famiglia patriarcale dalla quale provengo la farina di granturco – mi raccontavano – veniva utilizzata soprattutto per fare il pane, ovviamente in casa. Dopo la seconda guerra, quando nacqui io, ne prese il posto il buon pane bianco, fatto col “fiore”, la farina di grano. Un cugino più grande di me, che amava parlare del passato con una certa ironia, diceva che, se qualcuno avesse scagliato una pagnotta di pane di granturco contro un muro, avrebbe causato un buco, tanto era duro.
Il tòrsolo legnoso della pannocchia di granturco, sul quale sono inseriti i chicchi – tùtolo in italiano, forse dal latino tutŭlus – veniva da noi chiamato lu tozzere (e mute), probabile deformazione dialettale di “tòrsolo”. Lo stelo che restava dopo l’asportazione della pannocchia e che, secco com’era, veniva utilizzato anche per il fuoco, veniva chiamato lu sgammelò (e muta). Il termine veniva scherzosamente usato anche per indicare una persona alta e magra, oggi diremmo dinoccolata. Come Carletto F., mio compagno di classe alle elementari, già alto a quell’età. La parola, di etimologia incerta, corrisponde all’italiano “sgamòllo” ed è connessa con la sgamollatura, un tipo di potatura che lascia le piante discretamente spoglie.