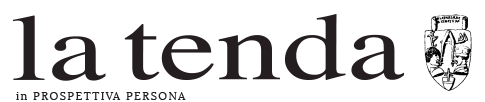di Vincenzo Lisciani Petrini, con una prefazione di G. Dadati e una nota critica di M.
Bordini, peQuod, Ancona 2022, pp. 130.
I libri di poesia non sempre o non soltanto sono oggetto di critica letteraria e/o di attente analisi poetologiche. Spesso – anzi, da sempre, come si vedrà meglio appresso – sanno suscitare una “schiuma di pensieri” a partire da un diverso scorcio: quello della filosofia. Ed è questo il caso del libro di poesie di Vincenzo Lisciani Petrini. Un libro apparentemente smilzo – composto da un Prologo, sette Sezioni e una Dedica –, ma di grande intensità e appunto capace di suscitare delle riflessioni a largo raggio, che lo immettono in un quadro storico e teorico di ampio respiro.
Il ‘la’, per dir così, della prospettiva di pensiero dischiusa da questo libro si può cogliere in particolare nella sua pagina conclusiva – e non a caso direi alla sua conclusione, quasi si trattasse di una “cadenza finale” che suggella il senso dell’intero “sviluppo” che modula i diversi passaggi poetici (uso volutamente questo lessico musicale perché Vincenzo è un fine pianista e nelle sue poesie trapela una sottile musicalità di fondo). Appunto nell’ultima pagina – con un palese richiamo a un verso del poeta Friedrich Hölderlin – l’autore conclude tutto il discorso fin lì svolto dicendo che occorre abitare “‘poeticamente’ la terra”. “Perché – aggiunge – solo ciò che si è amato può dirsi salvo”. Due frasi-chiave. Hölderlin è un poeta che ha ispirato molti filosofi, fra cui quello che ha segnato indelebilmente tutto il Novecento: Martin Heidegger. Del resto – come questi ha
ininterrottamente sottolineato – da sempre la filosofia frequenta la poesia. Poesia nel senso ampio di poiesis, che in greco significa ‘creazione’, ‘produzione di forme’. Una frequentazione dovuta al fatto che – come dice appunto Heidegger – “il poetare e il pensare vivono su monti vicini anche se separati”, ovvero vivono la stessa inquietudine problematica, benché con modalità diverse. Quale? La rende palese proprio il verso prima ricordato: “poeticamente l’uomo abita la terra”. Che cosa sta a dire questo verso così emblematico? Esso richiama la complessa e problematica condizione specifica dell’uomo. Infatti ciò che contraddistingue l’uomo rispetto agli altri animali – immedesimati nella realtà ambientale esterna grazie ad un apparato di istinti pre- fissato – è la mancanza di tale apparato. Il che determina nell’essere vivente umano una distanza inesorabile rispetto a quel ‘fuori’, quell’“Aperto” circostante – come dice di nuovo Heidegger richiamandosi questa volta al poeta Rilke – per lui ignoto. E lo obbliga a dargli una forma – appunto per renderlo ‘abitabile’. Ecco perché l’uomo è da sempre l’animale creatore per eccellenza: “weltbindend”, “formatore di mondo”, come dice ancora Heidegger. In quanto capace di pro-durre, tirar-fuori, forme – ‘poesie’ nel senso lato evocato prima –, per ‘dire’, ‘abitare’, la realtà nella quale si trova ‘gettato’. Dalle forme più quotidiane (case, utensili, abiti ecc.) a quelle artistiche (poesie, musiche ecc.) fino a quelle scientifico-conoscitive (la matematica, la chimica ecc.).
Qui si spiega il fatto che l’uomo viva in una condizione di costitutiva trascendenza – come si usa dire in filosofia e in teologia. Per quella separazione originaria che determina la sua costante ‘estroflessione’, la sua continua uscita da sé, verso un ‘fuori’ mai veramente afferrabile. Diciamo pure – con Platone e Giordano Bruno – determina la sua continua tensione ‘erotica’, desiderante, verso quell’‘ignoto’ esterno imprendibile, ma proprio perciò sempre desiderato, agognato.
Da tutto questo nasce il “poeticamente l’uomo abita la terra” di Hölderlin. Perché solo così l’uomo ‘salva’ – e ‘si salva’ – dalla temibile realtà che lo circonda: accogliendola dentro forme ‘abitabili’. ‘Poetiche’ nel senso prima detto.
Ne segue che il luogo dove tutto questo viene massimamente alla luce non può essere che l’arte: la poesia in senso proprio. Perciò la filosofia frequenta la poesia. Per ritrovare in essa quella spinta creativa specifica dell’uomo, quell’incessante desiderio di ripensare la realtà in modi nuovi, insomma quella visione dell’essere del reale come qualcosa di incessantemente plastico che costituisce e inquieta la filosofia stessa. Visione che altrimenti viene smarrita, quando l’uomo crede – con molta presunzione – di poter conoscere, possedere, la realtà esterna, di fatto impossedibile.
Ed ecco allora perché occorre che un Hölderlin ci ricordi: “poeticamente l’uomo abita la terra”. Che significa: l’uomo può fare solo poesie, può imprimere solo continue forme alla realtà: senza mai pretendere di afferrarla, conoscerla definitivamente. Qui il limite dell’uomo, la sua finitezza. Ma esattamente qui si radica tutta la sua forza, la sua potenza, la sua incessante
creatività. La sua possibilità di ‘amare’ – in questo senso – la realtà esterna e ‘salvarla’ dentro le forme che, sia pure in modo contingente e precario, la mettono, appunto, in forma dicendone la bellezza.
Questo è ciò che la poesia ci ri-cor-da: ci ri-dà-al cuore, al pensiero: che l’uomo abita – e deve abitare – poeticamente, creativamente, la terra.
Ebbene, questo ci ri-cor-da soprattutto l’arte contemporanea, nella sua differenza “rivoluzionaria” (Stuckenschmidt) rispetto a quella tradizionale. Quest’ultima, infatti, custodiva naturalmente quanto fin qui è stato richiamato. E tuttavia il suo compito primario era un altro. L’arte – sosteneva il pittore Kandinsky – è sempre “figlia del proprio tempo”. Di conseguenza l’arte
in passato muoveva dalla convinzione – tipica dei secoli passati – che l’uomo riesca a vedere l’essere profondo delle cose e dunque a possederlo col pensiero. Secondo la celeberrima lezione di Platone, che ha consegnato così, ai secoli successivi, un legato perdurante: l’essere del reale è, come il sole, to ekphanestaton: il più luminoso, il più visibile, il veramente conoscibile. E gran parte dell’arte classica, così come la conoscenza e i saperi tradizionali discendono da questa convinzione.
Non così l’arte contemporanea. Essa parte dalla consapevolezza che la realtà è sfuggente all’uomo, inafferrabile, imprendibile. La nostra contemporaneità ha ritrovato il senso della finitezza dell’uomo. E perciò, insieme, la necessità per l’uomo di sostare incessantemente di fronte alla realtà, non per catturarla, ma per dirla “poeticamente” dentro forme finite, incompiute. Per
questa ragione la forma, nell’arte contemporanea, ha perduto quel perimetro “rotondo e compatto” – per dirla con le parole del grande filosofo-musicologo Adorno – che essa aveva un tempo. Si pensi a tutte quelle immagini, statue, poesie, musiche ecc. del passato, perfettamente costruite attraverso raccordi precisi (per esempio, un sonetto). Erano l’espressione della
convinzione dell’uomo di vivere dentro una realtà armoniosa, compatta, stabile, ordinata.
Illusione oggi smantellata. E non solo. Ma proprio per tutto questo l’arte contemporanea, più che volgersi verso i grandi ideali per lo più infranti, si sporge verso le piccole cose della vita quotidiana. Verso quella dimensione nella quale maggiormente sperimentiamo l’inafferrabilità delle cose, la magmaticità delle nostre esistenze consegnate a un terreno instabile e insicuro. Di qui una forma creativa – tipica di tutta l’arte contemporanea – sfrangiata, incompiuta, fatta di raccordi instabili e “nascosti”, come diceva il grande Debussy. Nascosti precisamente per rendere la forma artistica più flessibile, plastica, aderente al flusso sfuggente della realtà. (Peraltro non posso non ricordare che diverse poesie di Lisciani Petrini – proprio come i celebri Préludes del musicista francese – portano il titolo alla fine della composizione poetica: a dire che il significato è
così impalpabile e sfuggente da non poter essere perimetrato con esatta sicurezza).
Tutto quanto fin qui tratteggiato profila, dunque, la cornice dentro la quale si collocano – e vanno lette, per poterne cogliere tutte le sottili risonanze di senso – le poesie di questa piccola ma densa raccolta. L’autore è un uomo, un artista, del nostro tempo: quel “tempo della povertà” – come, di nuovo, diceva Hölderlin – nel quale siamo tutti immersi. Ne respiriamo l’aria, ne viviamo le incertezze, ne sperimentiamo le lacerazioni. Vincenzo Lisciani Petrini è dentro questo orizzonte.
E ce lo restituisce lucidamente nelle sue poesie. Poesie che, non a caso, lungi dal magnificare grandi ideali, si sporgono invece sulle piccole cose della quotidianità, gli affanni giornalieri, “la percezione nervosa” tipica della vita metropolitana – come diceva il filosofo sociologo Georg Simmel. E Roma difatti – nella quale Vincenzo ha a lungo abitato – è sullo sfondo di molte delle sue poesie. Della grande metropoli – come accade a tutti gli artisti metropolitani: da Baudelaire a Pasolini – egli disegna le stimmate più dolorose. Di qui le intense poesie dedicate alle mattine nella metropolitana o sugli autobus romani: Stazione Tiburtina, Alba a San Lorenzo, Paracadutisti a Basilica San Paolo… Come anche le poesie rivolte al quotidiano – quale quella, davvero struggente, dal titolo emblematico Assalto al quotidiano.
Ma il vero, vibrante leitmotiv che percorre tutto il libro è l’amore. Come ci dice il titolo stesso, cadenzato su tre parole messe in continuità: Amare essere amati. “Un infinito attivo e un infinito passivo” come scrive l’autore stesso. A dire: un movimento, inscindibile, di donazione e ricezione, di ‘andirivieni’ fra estroflessione verso l’altro e rimbalzo su di sé. Come sempre l’amore
è. A livello sentimentale e corporeo. Il critico Dadati, nella sua prefazione al libro, parla giustamente di “canzoniere affettivo […] crepuscolare e novecentesco”. Certamente il libro è ricco di rimandi, più o meno celati, a poeti quali Caproni, Montale, Gozzano, Pavese (lancinante il verso ‘riadattato’: “scendiamo nel gorgo muti”) ecc., risalendo fino a Leopardi e oltre; ed è orchestrato sui registri tonali tipici di questo genere: lirico ma insieme disincantato, proteso ma insieme nostalgico, perentorio ma insieme sconfitto. L’autore lo dice esplicitamente: questi versi nascono anche dagli amori attraversati e poi
finiti, quelli che lasciano “giù nel fondo, come morto” (p. 71), quando la “vita si scrolla via dal corpo” (p. 75); ma anche quelli che aprono nuove strade: la dedicataria del libro, in tal senso, esprime questo rinnovato slancio verso il futuro.
Dunque queste poesie sono senz’altro poesie ‘classicamente’ d’amore. E lo sono nel modo migliore: con leggerezza quasi calviniana, senza alcuna retorica, senza mai scadere nel sentimentalismo. Nulla di più insopportabile dei libri interamente cadenzati dall’inno verso il (solo) bene (o, con la maiuscola, il Bene)! André Gide ebbe a dire acutamente : “Avec les bons
sentiments ont fait de la mauvaise littérature [con i buoni sentimenti di fa della cattiva letteratura]”. Vincenzo ne è assolutamente consapevole: sa che una scrittura d’amore può essere: “bella appassionata bella struggente bella ridicola” (p. 90) – attenzione, la frase è significativamente senza virgole. Così come Vincenzo è ben consapevole che l’amore non
costituisce, non deve costituire, un fondamento troppo sicuro – per conservare la carica desiderante di cui si nutre. Perciò l’amore è: “pura luce che brilla sul niente” (p. 91). Sul niente perché, come diceva S. Agostino, “La misura dell’amore è amare senza misura”, ossia l’amore è fondato solo su se stesso. E Vincenzo, agostinianamente, scrive: “amare serve solo ad amare” (p. 87).
Ma, accanto a questo strato più immediatamente evidente, c’è dell’altro. Quel più ampio senso dell’amore di cui parlavo prima. Che non è solo personale o autobiografico, ma rende la poesia corale: come se nell’io di Vincenzo, dietro la maschera di Vincenzo, parlassero le tante altre persone che siamo noi tutti. Accomunati dalla tensione verso quel “Grande Ignoto” – come dice acutamente un verso di p. 105 – che ci ‘travolge’ eppure ci attira, e che perciò ‘poeticamente abitiamo’. Quell’“amare essere amati”, quel donarsi e ricevere che sperimentiamo dai primi istanti dell’esistere fin nei suoi aspetti minimi, quella passione per le cose e la vita che ci nutre, per ‘salvarle’ esattamente amandole.
In questo senso, collocandosi nell’alveo della vera poesia, questa di Vincenzo Lisciani Petrini ci ri-cor-da, ci ri-dà-al cuore, la nostra insuperabile inquietudine, per la quale – come egli scrive, con un verso splendido e icastico, che non a caso ricorre in due poesie: “Siamo ancora la domanda che non sa chiudersi” (pp. 81, 107). Che non deve chiudersi, si potrebbe aggiungere.
Insomma ci ri-cor-da quel “poeticamente abita l’uomo la terra” per il quale – come abbiamo visto prima e come egli stesso scrive con le ultime parole del libro, citate qui all’inizio “solo ciò che si è amato può dirsi salvo e ciascuno, se vuole, è un angelo custode” (p. 130).