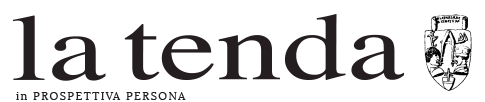di Emanuela Verdone

Raccontami una favola, papà, e mentre la racconti non lasciare mai la mia mano. Anche se mi addormento, non andare via (canzone turca)
Oggi, come spesso accade il venerdì, sono stata a pranzo dal mio amico Yusuf che ha una kebabberia ed esporta in Italia un po’ dell’ospitalità e calore del popolo turco. Anche nel periodo del covid, mentre la maggior parte dei ristoratori era esasperata dalla situazione che si protraeva da mesi, lui si è sempre mostrato sereno e fiducioso, offrendomi il solito çai, il tradizionale tè turco servito nei bicchierini a forma di tulipano, e un baklava, un dolce a base di pistacchio.
Inevitabilmente il discorso è scivolato verso il terremoto che ha colpito il sud-est della Turchia ed il nord della Siria il 6 febbraio scorso, provocando un numero esorbitante di morti che attualmente è quantificato intorno alle 40.000 vittime. Anche il mio amico, stavolta, era turbato dalla gravità dell’accaduto: due terremoti differenti avvenuti in un’area di 450 km, entrambi molto potenti (7.8 e 7.5 della scala Richter) tanto da avvicinare la costa turca e quella greca di tre metri. Molti lo hanno definito il più grande cataclisma del secolo, mille volte più forte di quello di L’Aquila (2009) e di Amatrice (2016) e trenta volte più forte di quello dell’Irpinia del 1980, registrato dai sismografi di tutto il mondo fino alla Groenlandia.
Notevole anche l’estensione dell’area interessata. In Turchia dieci province sono state polverizzate dalle lunghe scosse delle 04:17 e delle 13:24; da allora più di 300 scosse, di cui molte vicine alla potenza delle prime.
“E la tua città”, gli chiedo? So infatti che proviene da quella zona, confinante con la Siria. Mi risponde che lui è nato a circa 100 km dall’epicentro, l’onda sismica si è avvertita molto ma le case dei suoi familiari non hanno subito grandi danni perché in quell’area da tempo si lavora con l’edilizia antisismica.
La Turchia non è nuova a fenomeni sismici. Nell’ultimo secolo ci sono stati diversi terremoti devastanti, uno dei quali raccontato dal premio nobel per la letteratura Orhan Pamuk nel suo libro Altri colori dove fissa nelle pagine scritte le emozioni vissute durante il terribile sisma del 1999, che procurò circa 30.000 morti e la distruzione di molti quartieri di Istanbul. In quel caso fu ad attivarsi una delle due grandi faglie che attraversano la Turchia, quella sud-est anatolica, tra le più
attive del Medio Oriente.
Chiedo ancora a Yusuf dei soccorsi, gli domando se a suo parere sono stati efficienti. Mi risponde che l’estensione e l’entità del sisma, unite ad una congiuntura stagionale particolarmente fredda ed alla neve -la Turchia e la Siria, a dispetto dell’immaginario comune, sono paesi dagli inverni molto rigidi-, in principio hanno reso difficoltosi i soccorsi, sia quelli interni che quelli da parte dei paesi confinanti. Poi mi parla di un aspetto che mi ha commosso e precisa che l’Italia si è subito attivata negli aiuti, con la sua esperienza e i suoi corpi specializzati. Una vasta area colpita, diverse province
con grandi centri abitati dove sono implosi interi palazzi di dieci piani; una situazione che anche il premier Erdogan, in visita ai territori colpiti, ha definito “il più grande disastro dal 1939” ammettendo che i soccorsi sono arrivati in ritardo, ma che ora si procederà in tempi record a costruire abitazioni, a dare una somma di denaro mensile alle persone coinvolte ed a ristabilire i collegamenti di acqua, luce e gas.
Nel frattempo le autorità turche hanno arrestato ieri più di cento costruttori, persone legate alla progettazione e all’edificazione di edifici crollati, tra cui non mancano complessi di lusso, e sospettati di aver violato le normative edilizie del Paese come del resto trapela dalle parole del presidente degli architetti in Turchia che rivela “le case nuove sono
state spesso costruite con materiali scadenti”.
Una sciagura che arriva in un momento molto particolare per il paese fondato da Ataturk, che negli ultimi mesi si è ritagliata una parte di rilievo come mediatore nelle trattative nella guerra tra Ucraina e Russia e ha visto anticipate da giugno a maggio le tanto attese, se non temute, elezioni politiche.
Un cataclisma, insomma, che si ripercuote nello scenario internazionale non solo per la sua vastità, e che mi scuote intimamente per i rapporti di familiarità che ho verso questo Paese. Sui social leggo un messaggio di un italiano, un professore di Lettere classiche che vive da molti anni in Turchia: “L’intera Mesopotamia è andata distrutta, terra antica e di impareggiabile bellezza” e di seguito posta immagini del suo recente viaggio nelle zone dell’epicentro tra cui Gaziantep, con
il suo castello di origine romana, da poco patrimonio dell’Unesco, andato in frantumi dopo più di duemila anni, e poi Adana, Antakia, Alessandretta, nomi che ci rimandano alle nostre radici, menzionate nelle opere letterarie classiche e presenti nelle pagine del testo biblico. Nel suo post il docente di Greco descrive Antakya come una città magnifica, raccolta attorno al suo fiume, ornata di ponti in legno, parchi, caffè lungo il corso, serate di musica, “sembra di stare in Trentino” dice a chi lo legge dall’Italia e ben può comprendere il paragone.
Nella zona dell’epicentro c’è un altro sito diventato negli anni patrimonio UNESCO, quello di Nemrut, famoso poiché possiede una delle più incredibili testimonianze archeologiche conosciute, le Teste Giganti, protome colossali di re, regine, aquile e leoni conservate a 2100 metri di altezza, sulla catena montuosa del Tauro Orientale. Immagini, tante e strazianti, a cui si mescolano ricordi di studi fatti e di viaggi passati e ci riportano al nostro presente dove tra i Media si afferma l’altra vetrina di immagini del Festival di Sanremo, che ha spinto qualcuno a sottolineare la mancanza di empatia manifestata dalla rassegna canora, verso un dolore così prossimo.
L’immagine più toccante è costituita forse da una fotografia: un ritratto, tra i più struggenti che abbia mai guardato. È stato scattato dal fotografo Adem Altan e ritrae un padre accanto alla figlia di quindici anni, morta, ancora sotto le macerie. Il padre è lì, nonostante la pioggia e il freddo, con uno sguardo ormai rassegnato e sereno a tenere la mano della sua piccola.
Tra le rovine dei palazzi compaiono oggetti di vita quotidiana, sbalzati via dallo spazio domestico e esposti improvvisamente ai nostri occhi. Una foto ritrae la cattedrale di Iskenderun (Alessandretta) ridotta in macerie; soffocata da cumuli di cemento grigio emerge una statua della Madonna in equilibrio precario; quel luogo, ridotto ad uno scheletro, continua ad accogliere un centinaio di persone di tutte le religioni a cui vengono date acqua potabile ed un pasto caldo, piccoli gesti capaci di alleviare l’attesa, prima di conoscere il destino dei loro cari. Padre Antuan, rappresentante del Vicariato apostolico dell’Anatolia, in un’intervista descrive questi sforzi come quelli del capitano di una nave che affonda, ma poi conclude: “il terremoto mi ha insegnato una cosa: da una tragedia è nata una buona collaborazione tra i Paesi”.
Ci sono altre immagini di speranza: quelle dei bambini salvati dalle macerie dopo diversi giorni dalla sciagura, che nei video girati ci riempiono l’animo con i loro sorrisi e la richiesta ingenua di due bottiglie d’acqua, una da bere subito, l’altra da tenere per quando avranno ancora sete. E ancora il ritratto della neonata salvata dopo molte ore passate sotto le macerie, ancora attaccata al cordone ombelicale della madre; il suo nome è Aya (parola che in turco vuole dire ‘miracolo’), e per lei ora
c’è una lunga lista di persone pronte ad adottarla. O anche il bambino di sette mesi, ancora vivo dopo 140 ore di pietre e detriti, che ci fissa con il suo sguardo incredibilmente consapevole e profondo. E poi i due soccorritori, uno greco e uno turco, che salvano delle persone lavorando fianco a fianco, dimenticando decenni di tensione politica tra i loro paesi.
È proprio vero. Solo davanti a situazioni di questo tipo troviamo un momento per fermarci a riflettere sul comune destino. Solo in certi momenti, purtroppo, ci riappropriamo della nostra umanità, del bisogno di solidarietà che strinse i mortali in social catena, come suggerisce Leopardi, ne La ginestra.
Ed è qui che recuperiamo la capacità di sperare, nella metafora del sorriso di un bambino estratto miracolosamente dalle rovine.
Emanuela Verdone