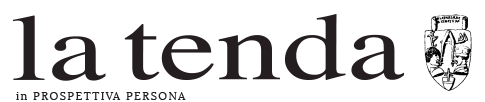Dalla terra di Turchia
C’è una cosa che mi meraviglia, ogni volta. L’indole tranquilla di questo popolo. La bontà del loro cuore espressa in quel modo tipico di salutare degli anziani che portano il pugno della mano destra prima sulla fronte e poi sul petto. Per significare che sei presente nel loro pensiero e nel loro cuore.
Se sali su un battello, ti accorgi che i turchi sono sempre raccolti. Non osservano nessuno, non sembrano preoccupati per nulla. Eppure non sono chiusi in se stessi come gli occidentali. Sono molto presenti. Tuttavia, guardano dinanzi a loro, nel vuoto, in modo grave e pensoso. Come in un continuo dialogo con l’assoluto. E se ti osservano, è solo per un attimo, come chi tocca terra involontariamente e torna a librarsi in volo. Quanto potere ha una religione nel modellare il carattere di un popolo. Perché, è evidente. Alla base di questo raccoglimento c’è un motivo religioso. E’ come se questa gente fosse sovrastata da una presenza trascendente. Dalla percezione che alla base di tutto c’è un ordine inalterabile. Dalla certezza che ogni cosa accade perché voluta dall’alto. Ed è per questo che ciascuno accetta la sua vicenda biografica con calma, con devozione. Anche se non esiste popolo più attivo. Qui, tutti lavorano. Il lavoro è un valore centrale di questa cultura. Chi è senza lavoro, raccoglie la spazzatura nei carretti. E sono in tanti.
E’ quasi un mese che mi trovo per incarico d’insegnamento in questa città. Seduto sul battello osservo, al mio fianco, la donna che prega con un libretto dalla tipica scrittura araba. Quando ha finito, lo chiude e lo ripone nella borsa. Poi, fissa di fronte a sé lo sguardo, sereno, pacificato. Non si è neanche accorta che la guardo. Eccoci arrivati ad Eyup, il monumentale cimitero di Istanbul. Un mare di lapidi che popolano un’intera collina di fronte al Mar di Marmara. Qui, le tombe non hanno nomi. Riportano solo versetti coranici, incisi sulla pietra come ricami. La cosa è evidente. Per gli islamici, le soggettività umane non hanno valore. Nulla lo ha al di fuori di Dio. L’uomo non è, come per noi cristiani, l’immagine vivente di Dio, né il cosmo è l’orma della sua perfezione. Per loro, mondo ed uomo sono il nulla di fronte al tutto di Dio. Essi non hanno avuto il Rinascimento con la centralità dell’uomo, o l’Illuminismo con la centralità della ragione e del cittadino.
Oggi ho fatto delle scoperte di spessore antropologico. Proprio ad Eyup, santuario islamico di prim’ordine, mi accorgo dei cosiddetti principini, i bambini vestiti di bianco, con corona e spada di legno in mano. Mi spiegano che si vestono così nei giorni che precedono la circoncisione. Li vedi camminare rigidi come condannati. Ma si sforzano di apparire coraggiosi. Sono scortati dai parenti, nel cui sguardo affiora un misto di preoccupazione e di fierezza per l’ingresso ufficiale dei loro piccoli nel consorzio della comunità islamica. È il tipico caso in cui un’idea di livello superiore (l’identità religiosa, l’ammissione ufficiale nella società) riesce ad avere la meglio, sublimando la paura, dando un significato sacro ad un rito doloroso, specie per un bambino.
E poi, proprio oggi, aggirandomi per il cimitero, mi sono inoltrato in un padiglione di cui ignoravo l’esistenza. Il reparto del sacrificio religioso delle pecore. Sono lì rinchiuse in un recinto. Rassegnate, impotenti, presaghe del loro destino. La gente arriva e ne sceglie una. Gli addetti la prendono, le legano le zampe, la pongono su una carriola e questa la porta nel tunnel della morte. Gli acquirenti assistono allo spettacolo dall’alto di un corridoio, separato da vetrate dal luogo del sacrificio. Operatori addestrati eseguono il rito con abilità e velocità da catena di montaggio: sgozzamento, decapitazione, scuoiamento, riduzione in pezzi. Lo spettacolo è tale che non è il caso di descriverlo. Sono rimasto sconvolto per un giorno ed una notte. Servendomi del traduttore, ho chiesto ad un signore distinto perché facevano questo: Come atto di adorazione e di amore ad Allah – mi risponde – ed anche perché protegga i nostri cari, vivi e defunti. E perché faccia riuscire un progetto che ci sta a cuore. Chiedo se quella carne viene bruciata. Mi risponde che è donata alle persone bisognose. Osservo la gente che assiste. La cosa sorprendente è che dal loro volto è lontano, nel modo più assoluto, qualcosa che possa essere definita crudeltà. Per loro è un atto religioso. Un sacrificio. Gli arabi lo chiamano kurban, gli ebrei korban, cioè ‘riservato a Dio’. Noto una ragazza che, già commossa fuori dal padiglione mentre guardava, nella carriola, la pecora che aveva scelta, ora piange a dirotto mentre la immolano. Ma perché lo ha fatto? Per la guarigione della nonna, per la buona riuscita di un esame, per il buon esito del suo amore?
Non siamo ipocriti. Cosa pensate che sia la macellazione degli animali in un mattatoio dell’Occidente cristiano? Da dove viene quella bistecca che abbiamo nel piatto? Eppure, mai come adesso ho capito che grande macelleria fosse il tempio di Gerusalemme, duemila anni fa. Ed anche da quale scempio ci ha liberato il Cristo col suo sacrificio che ricapitola in sé, totalmente, il male, la sofferenza e la morte. Ma ho anche compreso che tragedia sia stata la crocifissione di Gesù. Chissà se anche gli animali partecipano, anche loro, all’universale sacrificio della sofferenza. E perché no?
Luciano Verdone
Docente di Filosofia – Teramo – 329 1906667