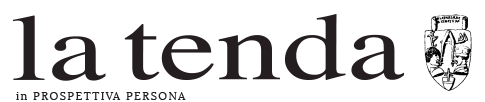Si tratta, come è noto, del racconto dell’esperienza atroce di Primo Levi, torinese di famiglia ebrea, vissuta dentro un non luogo, il lager di Auschwitz, lì dove tutti i bisogni, vengono calpestati, annichiliti, fino a creare ombre fatue, che sono fame vivente. Lo scrittore, chimico, datosi alla macchia l’8 settembre 1943, fu catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre. Ebreo, oltre che partigiano, fu consegnato ai nazisti che lo deportarono ad Auschwitz. Per sua fortuna, nel 1944 il governo tedesco, vista la crescente scarsità di manodopera, stabilì di prolungare la vita media dei deportati, comunque da eliminare. La sua laurea in chimica fece il resto. Per questo sopravvisse, uno dei pochi, e tornò a casa, come si racconta nel testo in appendice, La tregua.
Credo che tutti almeno una volta nella vita debbano leggere Primo Levi, non solo per il valore di testimonianza storica diretta , in un’epoca di relativizzazione di tutto e di nichilismo strisciante, in cui proprio per questo forte e presente deve essere la memoria degli orrori della storia, ma anche per il pregio della scrittura che graffia l’anima, la attraversa, vi incide con caratteri indelebili un monito perenne: mai più!
Mai più dovere assistere alla violenza inaudita, ai progetti manicomiali di sterminio di una razza, e non è un’ attenuante il fatto che anche i comunisti hanno perpetrato simili eccidi: i morti non si contano, non si pesano, non si catalogano, di fronte a loro bisogna tacere e meditare. Leggere Levi aiuta a capire quel che è stato il più feroce sterminio, sostenuto da un progetto studiato scientificamente a tavolino con la ragione assente e il furore cieco negli occhi. Nessuno prima aveva pensato di sterminare un intero popolo, togliendogli ogni dignità, svuotandolo dentro, annichilendolo psicologicamente, fino a farlo coincidere con quella nebbia perenne di Auschwitz, sì proprio lì dove è inciso in modo inverecondo e folle: Il lavoro libera.
Rileggere Se questo è un uomo, e non solo la toccante poesia iniziale ma tutto il diario, aiuta a capire la necessità della memoria e la difficoltà del perdono. A me risulta molto difficile perdonare quel popolo e ancoro lo temo ( Timeo Danaos et dona ferentes!). Amo la sua letteratura e il suo culto del classico ( H: Hesse, Thomas Mann…) ma non posso non pensare alla testimonianza di Primo Levi, risento le grida di persone che scompaiono o di sopravvissuti che lentamente si spengono perché muoiono dentro ogni secondo. Già nel momento in cui vengono catturati, i deportati cominciato a morire: sradicati dalle loro famiglie, soli, abbandonati dagli uomini e da Dio, ombre solinghe, fuochi fatui, miseria umana, carne, anzi ossa, da macello. Giorni interi senza bere, con i piedi nel fango, senza scarpe, nudi, esposti al ludibrio e all’offesa di chi insensatamente e deliberatamente li deride, li frusta, si diverte a vederli perire ogni giorno, nella lotta per la sopravvivenza. Lotta impari, in cui i più sono chiamati, non si sa perché, musulmani, e sono quelli che si rassegnano subito, che rispettano gli orari, che eseguono gli ordini, che non rubano, che non fanno nulla per ottenere una razione di pane in più. Questi muoiono tutti e presto; scientificamente provato, non resistono più di tre mesi.
Gli italiani ebrei, quelli col numero basso, sono tra i musulmani; Primo Levi ha stampigliato sul braccio una cifra a sei numeri ma ce la farà perché deportato nel 1944 e soprattutto perché, chimico, serviva. Smise di fare domande che non avevano risposta e trovò una strategia di sopravvivenza: cercare una razione in più di pane o di nera brodaglia, imparare a farsi un cucchiaio/coltello con le sue mani, convivere col puzzo suo e dei compagni, col vuoto esistenziale, con l’aberrazione mentale degli aguzzini. Era piccolo e gracile, ma forte di ingegno e, pur spegnendosi di giorno in giorno, riuscì a sopravvivere alla discesa negli inferi. Si tratta di un viaggio all’ingiù, come lui stesso dice, verso la bolgia infernale del lager, ma anche un viaggio, il più doloroso, dentro se stessi, in corpi irriconoscibili : visi e palpebre gonfie, piedi piagati e sanguinanti, ferite purulente. Scheletri in fila a marciare verso il lavoro insostenibile: travi pesantissime di ghisa da trasportare in un’attività insensata, perché di fatto in quel lager nulla si produceva; era tutta una messa in scena per deprimere i bisogni anche minimi dei deportati, per vederli diventare un nulla da camera a gas. Lo scopo ovviamente non era farli lavorare, ma rendere tutto impossibile, togliere tutto ciò che è vitale con un progetto capillare: meglio un colpo di pistola in testa senz’altro. E invece no! L’uomo è più abietto e crudele: gioca con i morti, perché nel momento stesso della deportazione essi smettono di vivere. Giorni da incubo straniante e notti fantasmatiche in cui i bisogni insoddisfatti galleggiano e le torture subite ritornano a boomerang dentro il cervello, si risente lo sparo in mezzo alla fronte a bruciapelo senza motivo che ha posto fine alla non-vita di un compagno. Ma qui nulla ha senso; qui tutto si ripete fuori dal tempo usuale, qui c’è solo il lager, luogo di nebbia, qui dove l’inverno non passa mai e nulla si vede, perché non c’è speranza, anche se qualcuno ancora si illude, qualcuno presto destinato a morire, anzi già morto.
Sullo sterminio degli ebrei è stato scritto molto, ma nessuna opera è al contempo diario e memoriale, elaborazione letteraria e studio sociologico, storico, filosofico, nel senso di riflessione sulla storia e sull’uomo
L’opera di Levi è un documento il più sincero possibile, un racconto con la misura del classico, un’analisi psicologica e sociologica dell’uomo, un trattato scientifico sull’abisso della mente umana che produce umiliazione, offesa, degradazione…nulla. Perciò, non appena il freddo, che per tutto l’inverno ci era parso l’unico nemico, è cessato, noi ci siamo accorti di avere fame…Ma come si può pensare di non avere fame?