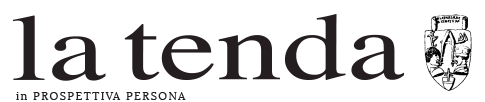Capita che proprio chi non ha scritto nulla e ha affidato il suo pensiero ai discepoli e agli Ateniesi tutti, perché riteneva che compito del sapiente fosse quello di far partorire le anime gravide con l’uso della parola dal potere taumaturgico e maieutico, risulti il più studiato, il più discusso, quello il cui pensiero è stato più tramandato. Platone, Diogene Laerzio, Senofonte, il commediografo Aristofane (che interpreta il punto di vista degli incolti) sono le fonti più famose, ma anche Antistene, fondatore del Cinismo; Aristippo, iniziatore della scuola Cirenaica; Euclide, il primo dei Megarici; Fedone e la scuola di Elide; Eschine, il retore, senza dimenticare Aristotele, discepolo del discepolo Platone.
Grazie a tutti questi, la figura di Socrate è giunta compiuta e sedimentata fino a noi, sì da essere il filosofo per antonomasia presso un pubblico di gran lunga più vasto di quello degli studiosi.
Gli aforismi “ so di non sapere” e “conosci te stesso”, incisi sul tempio di Delfi, sono sulla bocca di tutti, ma non tutti sanno cosa è loro sotteso, quanto lavorio della mente e dell’anima, quanto impegno, quanto amore per quella città ingrata che lo generò e lo mise a morte, quanto rispetto per le Leggi e per il dio che parla per oracoli siano insiti nella sua sapienza.
La consapevolezza di non sapere nulla lo fece salire sul podio del massimo filosofo secondo il dio di Delfi, il suo dio, quello la cui sacerdotessa Pizia emetteva oracoli anfibolici, perché l’ammissione del limite, che è strutturale dell’esistenza, dischiude orizzonti illimitati e ci fa cogliere l’arroganza superba e sciocca di chi se ne va sicuro senza considerare l’ombra che si riflette “sopra lo scalcinato muro”. Missione di Socrate era allora quella di interrogare gli Ateniesi, non solo i suoi discepoli, sull’essenza delle cose che si nasconde sotto tutte le stratificazioni della coscienza, compiendo un’operazione intellettuale di difficile conseguimento. E’ infatti umano, troppo umano fermarsi alla superficie della realtà, amare un corpo perché bello, una casa perché fastosa, un uomo perché ricco, ma difficile, di accesso al filosofo, è cogliere il bello in sé e per sé, quello che giace in un’anima bella.
Ecco, Socrate voleva cogliere attraverso il dialogo, con lo scalpello dell’ironia, cosa fosse il bello, il buono, il giusto, la virtù e massime l’amore…, un amore che non circola solo tra gli uomini in senso orizzontale, ma si eleva anche in senso verticale verso il suo dio, che è però anche dentro di sé, ed è chiamato dàimon. Avere un buon dàimon è la porta di accesso all’eudaimonìa, che non è il soddisfacimento dei piaceri e dei bisogni che procura piacere (edoné), ma anzi la riduzione di questi: questo solo conduce alla felicità, che è l’autarchìa del sapiente.
Un dialogo/interrogatorio che mette alle strette l’interlocutore con l’insistere sul “ti estì” (che cosa è?) vuole far partorire l’essenza che è anche l’essenziale delle cose e dell’uomo; l’interrogato, per via dell’incalzare delle domande, è anche infastidito, perché costretto a guardare oltre l’apparenza ingannevole della realtà, a gettare la maschera, a scavare dentro di sé per ritrovare le immagini originali, come in una serie di sedute psicoanalitiche. Spesso i dialoghi platonici (esempio per tutti Il Simposio) si chiudono senza che si sia pervenuti ad una verità: i discepoli vengono congedati con la mente gravida di interrogativi, costretti a loro volta ad interrogarsi e ad interrogare, mettendo in crisi l’Atene pseudo-democratica, che era cresciuta col mito della doxa (falsa e dominante opinione).
Questa è la causa vera per cui Socrate fu messo a morte, perché minava alle radici le certezze di Atene, mentre quello che il dio di Delfi aveva indicato come il più sapiente degli uomini ammetteva di non sapere nulla. Non contento della risposta del dio, Socrate andò ad interrogare con la consueta ironia tutti quelli che si ritenevano i più sapienti, irritandoli fin nella ossa, giungendo alla conclusione che davvero lui era il più sapiente, dato che gli altri che vedevano solo l’ombra della realtà si reputavano tali. L’uomo sapiente è colui che attraverso un ragionamento razionale (razionalismo socratico) arriva a conoscere la virtù che è il dominio dell’anima sul corpo (dualismo socratico e poi platonico); il che comporta la conoscenza del bene. Una volta conosciuto, nessuno vorrà ritornare prigioniero delle tenebre della caverna (Repubblica di Platone), ma tutti vorranno contemplare la luce della conoscenza. Chi conosce il bene non può che farlo (intellettualismo etico).
La conoscenza del bene si sviluppa in senso orizzontale, contagiando i discepoli; di qui l’accusa di corrompere i giovani; non c’è quella ascesa in verticale che trova sviluppo in Platone nel Mondo delle Idee. Quindi, la sua teologia è anche teosofia, perché sapiente al massimo grado è il dio di Delfi e dopo di lui c’è Socrate, il nemico dei Sofisti relativistici, che incarna lo spirito del dio e da esso si lascia guidare. Il suo dàimon è un deterrente a compiere azioni non virtuose più che un’ esortazione ad agire, perché conoscere se stesso equivale a misurarsi con i propri limiti e ad abbracciare il principio delfico che esorta a non compiere nulla di eccessivo (medèn àgan).
L’ascolto del dàimon gli fa rigettare gli dei falsi e bugiardi di Omero, come già in Senofane, perché il suo dio lo obbliga a purificare l’anima attraverso un procedimento di contenimento razionale, mentre gli dei eccentrici e bizzarri sono ad immagine e somiglianza degli uomini incolti, gravidi di passioni e di bisogni da soddisfare. Gli dei dell’Olimpo allontanano dalla via che mena alla virtù e si rivelano un cattivo esempio per gli Ateniesi; non bisogna infatti dimenticare che Socrate parla agli Ateniesi e ad Atene, le cui Leggi sono sacre e da rispettare, anche quando ingiuste.
Ecco che Atene che preferì le tenebre alla luce, condannò Socrate per empietà e corruzione dei giovinetti, per quanto Alcibiade sia la prova vivente del controllo che il Maestro aveva sul suo corpo (Simposio), rifiutando le avances del giovinetto più bello di Atene. E Socrate andò incontro alla morte nel 399 a.C. per ossequio alle Leggi, rigettando l’invito dei suoi discepoli alla fuga. Se fosse fuggito, le Leggi lo avrebbero condannato moralmente; questa sarebbe stata una conclusione di vita di gran lunga peggiore del bere la cicuta.
Anche per questo suo immortalarsi in nome della sapienza, Socrate è entrato nell’immaginario del nostro Occidente come il filosofo più virtuoso e leale, pronto a morire in nome del suo dàimon.
Giovanna Albi