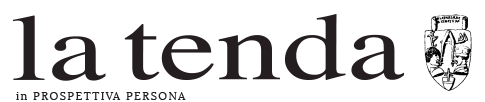1. Un libro
Mi è capitato recentemente tra le mani un libro[1]1 che, come dice il suo titolo (in italiano: La notte degli altri. Testimonianze di una visitatrice d’ospedale), narra le esperienze di una visitatrice dell’associazione laica V.M.E.H., associazione che dal 1953 in Francia si occupa di visite agli ammalati in ospedale. Nonostante i numerosi anni trascorsi da quello della sua pubblicazione, si tratta di un libro che mantiene tuttora la sua validità: dai numerosi incontri dell’Autrice con persone differenti per età, sesso, cultura, estrazione sociale, molte delle quali morte in seguito al disturbo per cui erano in ospedale, emerge un comune bisogno, da parte degli ammalati, di tenerezza, vicinanza, amicizia, aiuto, gioia, delicatezza, dialogo, contatto umano, un bisogno di piangere, di avere sostegno per superare la disperazione, per ritrovare coraggio e dignità, per calmare la paura, un bisogno di non morire soli. Si tratta di necessità che ancor oggi possiamo riscontrare negli ammalati e comunque in chi è sofferente. Il libro termina con una frase di un giovane, poi morto: “La sofferenza non è una crudeltà gratuita, ma una lezione e una chiamata”.
Però non è tanto del libro in sé che voglio parlare, quanto delle riflessioni conseguenti alla sua lettura. La provocazione costituita dal fortuito incontro con questo libro nel periodo presente ha infatti suscitato in me due tipi di reazione.
Da una parte, ha suscitato sia la considerazione di quanti, nell’attuale periodo di pandemia di Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale – per Covid-19 o per altre malattie – ed hanno dovuto restare soli, talvolta con al massimo 30 minuti al giorno di presenza di un parente, ma quasi sempre totalmente soli, ininterrottamente soli e quindi anche morendo soli; sia la gratitudine nei confronti di quanti, medici, infermieri ed altro personale, sono rimasti al loro posto a fronteggiare la situazione, spesso fino al sacrificio della propria vita in seguito a loro personale infezione da Covid-19, e sono rimasti non solo curando, ma anche confortando i malati al posto dei parenti che non potevano essere presenti.
Dall’altra parte, la lettura del libro ha suscitato il ricordo di tanti anni di mie esperienze personali presso gli ammalati in ospedale. E di queste esperienze vorrei riportare qui pochi significativi esempi, da ognuno dei quali è risultato un insegnamento per me da parte dei malati stessi. Solo pochi esempi, ma emblematici del fatto che bisogna usare fantasia e non schematismi negli incontri con tanti svariati ammalati; pochi esempi che spero possano veicolare, anche per eventuali lettori non legati all’ambiente ospedaliero, l’invito ad avere fiducia nell’incontro tra noi e chi è differente da noi.
2. Esperienze personali
Se le riflessioni che intendo riportare non sono pensieri altrui ma riguardano esperienze, e se tali esperienze sono personali, ciò non è per un desiderio di mettermi in mostra, bensì per il desiderio di condividere quanto ho appreso durante tali esperienze. Ho operato come membro dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Napoli[2] dal 16 novembre 1983 (come tirocinante, e dal 25 ottobre 1984 come effettiva) fino al 1 marzo 2020, data dopo la quale è stato proibito anche a questi volontari l’ingresso in ospedale a causa del Covid-19 (e, anche se, con pericolo proprio ed altrui, fosse stato permesso l’ingresso in ospedale, il giusto obbligo di mascherine e specialmente di distanziamento tra persone evitando qualsiasi contatto avrebbe totalmente stravolto la modalità di approccio dei volontari agli ammalati). Non essendo più in grado di offrire cure a mia mamma e a mio marito, che da poco tempo non erano più in questo mondo, nel 1983 avevo seguito il corso teorico di formazione dell’Associazione.
La spontanea preghiera che precedeva ogni mio ingresso in ospedale era che il Signore mi aiutasse ad esprimere con tutta me stessa la Sua misericordia, indice del Suo amore. Quante volte ho colto un dolore profondo, dall’epoca del quale era iniziata tutta una serie di malattie: “sono sei mesi, o dieci anni, che è morto/a mio marito/mia moglie”, “sono venti anni che è morto/a mio figlio/mia figlia”! Quante volte ho percepito una paura attanagliante: “domani mi devono operare”! Quanti lunghi racconti di importanti eventi ho ascoltato, anche se non sembravano importanti a me! Quante volte ho dovuto suggerire a parenti, che pure stavano lì per ore ma senza poter essere visti dall’ammalato, di posizionare la loro sedia in direzione opposta (cioè di fronte alla loro persona cara malata) e di tendere una mano sulla quale l’ammalato, se avesse voluto, avrebbe potuto poggiare la propria mano! Quante carezze, quanti lievissimi massaggi!
Ricordo ancora i capelli bianchi che ho carezzato la prima volta, quando ho incontrato la prima ammalata durante la mia prima visita; o il capo di un’altra persona che ho carezzato un’altra volta, in un altro istituto ove eravamo andati in visita: la persona era seduta su una poltronagabinetto, con le braccia legate ai braccioli della poltrona affinché non portasse alla bocca le proprie feci con le mani. Gesti, i miei di carezza, forse non inutili per comunicare un amore che voleva superare la situazione angosciosa. E ancora: numerose volte anche un semplice, leggerissimo massaggio alla schiena, al di sopra del pigiama o della camicia da notte, era servito a calmare un dolore dovuto non a cause legate a disturbi dell’apparato scheletro-muscolare, ma ad un’ansia invincibile.
Pochi casi particolari desidero ora descrivere: li ricordo con speciale intensità, sia come frutto di un mio coinvolgimento profondo sia anche come insegnamento da me ricevuto eapplicabile in altri incontri con ammalati al di là del caso particolare che lo aveva originato, uninsegnamento comunque generalizzabile anche ad altre differenti situazioni della vita.
2.1. Lo “scemo”
Una volta mi era stato chiesto, da chi di dovere, di andare a dare da mangiare allo “scemo”[3]3.Avevo quindi trovato un giovane, bello come un Cristo morto deposto dalla croce, cheteneva sempre gli occhi chiusi, non si muoveva mai e non parlava con nessuno. Gli ho detto che gliavrei dato da mangiare. Non ha risposto (era “scemo”). Ho appoggiato alle sue labbra il primo boccone infilato alla forchetta. Lo ha ingoiato, e così i successivi bocconi. Gli ho detto che avrei portato la forchetta vicino alla sua mano e non più alla sua bocca. Non ha risposto; ma ha preso la forchetta e la ha portata alla bocca e poi io la ho ripresa, e così con i successivi bocconi. Gli ho detto che gli avrei porto l’ultimo boccone. Lo ha preso, lo ha ingoiato, ha proteso la mano con la forchetta verso di me e, in un soffio quasi impercettibile, ha pronunciato “Grazie”. Altro che “scemo”!
Era reduce, come poi ho appurato, di esperienze terribili all’epoca di rivolgimenti politici nel suo paese islamico. Per anni lo ho seguito, insieme con altre due care persone, anche fuori dell’ospedale. Viveva su una panchina. Per lunghe ore gli ho parlato, sulla panchina, sperando (invano) che rispondesse. Gli ho letto il “suo” Corano, per rafforzarlo nella sua fede. Nuovamente è stato definito “scemo” perché aveva buttato il prosciutto prima di mangiare un panino che gli avevano donato: gesto di fedeltà, il suo, alla sua religione nonostante la fame e la povertà. Che gioia la mia quando un giorno, dopo anni, ha ricominciato a parlare. Che gioia sul suo volto quando – avendo io scoperto che aveva una sorella in Francia, e avendolo condotto lì in un viaggio avventuroso – egli ha rivisto la sorella: una gioia che valeva tutti gli anni di fatiche di noi tre per lui.
E quando aveva capito che lui ed io dovevamo separarci definitivamente, che io sarei tornata in Italia ma lui invece sarebbe rimasto in Francia, le sue ultime parole furono: “l’amicizia è per sempre”. Tutto questo però è un’altra storia, che esula dal tema qui proposto. Piuttosto, quello che ho imparato dal semplice dover dare da mangiare allo “scemo” è che in generale, ed in particolare incontrando gli ammalati, non bisogna fermarsi, nel capire e valutare una persona, a ciò che una prima superficiale percezione suggerisce, ma è necessario cercare e arrivare all’essenza profonda di quella persona, sia per valorizzarla sia per riuscire a stimolare una reazione.
2.2. Un pianto
Stavo accudendo, fisicamente e moralmente, nel modo consueto, una anziana signora di circa settanta anni. A un certo punto, inaspettatamente, ella è scoppiata in un pianto dirotto, irrefrenabile, inconsolabile: tanto dolore potevo solo condividerlo, senza indagarne il perché. Alla fine, ha solo esclamato: “Quando avevo venti anni ho voluto abortire”. Un’angoscia custodita per cinquanta anni; una situazione di cui non mi erano noti i contorni, le cause; comunque, una piccola vita volontariamente scartata. Quello che ho imparato è che esiste un nucleo affettivo profondo in ognuno di noi, un nucleo affettivo che è sensibile alle nostre esperienze (recenti, o antiche) di gioia ma anche di tristezza, di speranza ma anche di angoscia; sono queste esperienze di gioia, tristezza, speranza, angoscia che dobbiamo cogliere negli ammalati che incontriamo e che dobbiamo fare nostre in modo solidale[4] affinché l’incontro sia vero e non solo banalmente superficiale.
2.3. I pantaloni
Avevo terminato il mio servizio di quel giorno. Percorrevo non più uno dei reparti dove stavano gli ammalati, ma il lungo corridoio che portava all’uscita. Una distinta signora (che avevo ritenuto essere presumibilmente una perente di ammalato) mi ha chiesto dove fosse il gabinetto. Glie lo ho indicato (ovviamente, un gabinetto per gli estranei, non per gli ammalati). Mi ha chiesto di aprirne la porta. Lo ho fatto, pur meravigliandomi della richiesta inusuale. È entrata e mi ha chiesto di calarle i pantaloni. Ho rifiutato con cortesia e me ne sono andata. Ha cominciato a inveire violentemente, ininterrottamente, a gran voce contro di me lungo tutto il corridoio.
Ne aveva ben donde! Infatti, avendola infine raggiunta per calmarla (inutilmente) cingendole le braccia, avevo appurato che le due braccia, gli avambracci e le mani erano una protesi di plastica, perfetta a vedersi ma che però non poteva essere mossa da chi la portava. Quello che ho imparato è che non basta l’usuale correttezza di comportamento per evitare di non aver calato i pantaloni a Gesù[5], ma serve una attenzione particolare alle situazioni per scorgere la necessità più impensata, che però ci sollecita non meno delle altre necessità che siamo abituati a rilevare nelle altre persone che incontriamo: non solo sprimacciare un guanciale, non solo indicare l’ubicazione di una stanza, ma, appunto, calare i pantaloni.
2.4. Gridava
Mi ero accostata a un letto. Una signora gridava per un po’ come un’ossessa, a ripetizione ad intervalli di un paio di minuti. Inutile parlarle: era sorda. Le solite carezze non sortivano alcun effetto. Una gentile ed efficiente badante mi ha informata che la signora faceva così da quando, la notte precedente, era stata colpita da ictus cerebrale. Ho ascoltato e cercato di capire il significato di quelle grida. A un certo punto, ho colto non rabbia (come poteva sembrare al primo ascolto), ma terrore. Immaginiamo cosa possa succedere nella mente di una persona nel momento in cui è colpita da ictus cerebrale, nell’attimo in cui forse percepisce coscientemente tutto lo sconvolgimento che si abbatte su di lei e forse conserva questa esperienza come ultimo, ormai unico, ricordo, terrificante ricordo. Che fare? Tutto era risultato inutile a calmarla. Mi sono allora chinata su di lei, protendendo il mio capo fino ad averlo proprio di fronte al suo. Ho intensamente desiderato trasmetterle positività, serenità, fiducia nonostante tutto. La ho fissata ininterrottamente nei suoi occhi, dicendole solo con i miei occhi: “non ti preoccupare, andrà tutto bene”.
Si è calmata, non ha più gridato per tutto il tempo in cui sono rimasta nelle varie stanze di quel reparto. Non mi illudo che non abbia gridato mai più. Ma in quel momento la positività era arrivata a lei. Quello che ho imparato è che abbiamo varie risorse interiori di cui possiamo far uso; e che talvolta può essere necessario far uso di tutte queste nostre risorse, al di là di quelle solitamente messe in atto nei vari tipi di incontri, al di là del semplice discorso ed anche della abituale carezza, sforzandoci di essere all’altezza di una situazione totalmente imprevista.
2.5. Tozza-tozza
Era un giovane. Aveva l’AIDS. Chi di dovere mi aveva detto che era molto difficile che guarisse e che al momento era in una fase veramente critica. Gli infermieri giustamente si accostavano a lui per accudirlo con i guanti. Quella sera era molto triste ed anche agitato. Gli chiesi di cosa avesse bisogno, cosa desiderasse. Mi rispose che voleva fare “tozza-tozza”. Così, abbiamo fatto tozza-tozza, urtandoci alcune volte fronte contro fronte. Dopo il tozza-tozza, la sua agitazione è sparita, si è calmato, si è rasserenato, si è messo tranquillo a riposare. Sono stata con lui, sempre tranquillo e sereno, fino alle dieci di sera. Alle quattro del mattino era morto.
Quello che ho imparato è che alcuni eventi che abbiamo vissuto rivestono per noi un particolare significato che è capace di produrre effetti. Chissà quando e con chi quel giovane aveva avuto l’abitudine di fare tozza-tozza; forse quando era ragazzino, forse con un amico o con un familiare a lui caro, probabilmente quando non era ancora stato travolto dalle vicissitudini della vita; chissà cosa gli suscitava ora interiormente quel moto del capo, quel contatto fugace fronte contro fronte, quel brevissimo uscire dall’isolamento; chissà quale ricordo di condivisione e di pace era stato destato ora in lui, un ricordo tale che ora lo aveva aiutato ad avviarsi serenamente al morire.
3 Riflessione teologica conclusiva
Queste esperienze personali ed anche ciò che esse hanno insegnato a me dal lato pratico, in vista dell’atteggiamento più idoneo da tenere nei confronti di persone sofferenti che uno incontra, rivestono però un’importanza più generale, che va oltre le esperienze stesse e gli insegnamenti da esse scaturiti. Si tratta della possibilità di cogliere ancora una volta e di approfondire, attraverso l’emozione che il ricordo di tali esperienze di sofferenze altrui suscita, il valore della dignità di ogni persona.
A proposito del valore, B. Lonergan afferma che le “apprensioni [di valore] sono date nei sentimenti”, precisando che ciò avviene nel caso particolare in cui il sentimento sia una “risposta intenzionale la quale accoglie il valore ontico della persona o il valore qualitativo della bellezza, del comprendere, della verità, di nobili imprese, di azioni virtuose, di grandi conquiste”, dato che noi rispondiamo “con l’agitazione emotiva del nostro stesso essere allorché intravediamo la possibilità o l’attualità dell’auto-trascendenza morale”[6].
È ciò che avviene, per esempio, quando proviamo emozione di fronte al martirio affrontato per amore degli altri, come nel caso di Massimiliano Kolbe[7] – il presbitero francescano polacco, che nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia destinato alla morte per fame –, di Salvo d’Acquisto[8] – il vicebrigadiere dei Carabinieri, che nel 1943 si accusò di un atto di sabotaggio verso i tedeschi, da lui non compiuto, offrendo la propria vita in cambio di quella di ventidue ostaggi condannati a morte –, di Janusz Korczak[9]– che, quando nel 1942 i bambini dell’orfanatrofio ebraico del ghetto di Varsavia stavano per essere condotti al campo di concentramento e sterminio di Treblinka, pur potendo egli essere risparmiato, si rifiutò di abbandonare i bambini e andò con loro incontro alla morte –, di suor Cecilia Basarocco[10]10 – che si prodigava per gli ammalati dell’ospedale di Niscemi e che, quando nel 1943 un plotone di esecuzione stava per giustiziare dodici soldati tedeschi, di cui alcuni feriti, rifugiatisi nell’ospedale, cominciò a correre davanti ai dodici condannati gridando di sparare anche su di lei, ma allora nessuno osò sparare –.
In questi casi cogliamo “il valore ontico della persona” che si sacrifica per amore degli altri, la “bellezza” della sua “azione”. D’altra parte, anche quando proviamo emozione di fronte alla sofferenza di un altro, che sia o no in un ospedale come nei casi particolari sopra riportati (nel § 2), noi possiamo cogliere “il valore ontico della persona”, che in questo caso soffre, ma è sempre caratterizzata dalla bellezza del valore della dignità che è proprio di qualsiasi persona.
Lo “scemo”: una persona che, nonostante le difficoltà di comportamento conseguenti a terribili pregresse esperienze, è capace di cogliere un segno di interessamento e di elaborare autonomamente il valore perenne dell’amicizia.
Un pianto: nell’angoscia di un prolungato, tristissimo ricordo, una persona che è cosciente della propria responsabilità nell’aver rifiutato un dono, certo a suo tempo difficile da gestire, ma comunque un valore sia in se stesso sia per lei se lo avesse accolto.
I pantaloni: la reazione giustificatissima di una persona che ancora una volta, fra chissà quante innumerevoli altre volte, vede calpestata appunto la propria dignità nel trovare messe a nudo le proprie evidenti incapacità senza ricevere aiuto.
Gridava: una persona che esplicitamente manifesta il terrore suscitato dalla disintegrazione della propria personalità, ma implicitamente esprime l’intima necessità di essere rassicurata riguardo ad una propria possibile reintegrazione.
Tozza-tozza: una persona che nella sofferenza finale, ancora poco prima della morte, esprime e vuole sperimentare un’altra volta, anche se a un livello minimo, l’umana capacità di interrelazione[11], l’importanza cioè della relazione[12].
Come non cogliere la bellezza del “valore ontico della persona”, provando emozione anche di fronte a questi casi di sofferenza, e non solo di fronte ai precedenti casi sublimi di autodonazione?
Note
[1] N. Kesmarky, La nuit des autres. Témoignage d’une visiteuse d’hôpital, Étoile de la Pensée, Paris 1996, pp. 158
[2] Tale Associazione di Napoli è stata fondata nel 1981, come parte della Federavo.
[3] A quell’epoca, non era ancora proibito ai volontari dare aiuto agli ammalati nel mangiare o nel bere; anzi, questo aiuto
era esplicitamente sollecitato.
[4] Cf Gaudium et spes, n. 1.
[5] Gesù, infatti, ha detto “[…] tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”:
Matteo, 25,45. Cf anche Francesco, Fratelli tutti, n. 85.
[6]B.J.F. Lonergan, Method in Theology, Darton, Longman & Todd, London 1972, pp. 37-38, ora Method in Theology,
R.M. Doran e J.D. Dadosky (edd.), CWL 14, University of Toronto Press, Toronto 2017, pp. 38-39, tr. it. Il metodo in
teologia, G.B. Sala (trad.), N. Spaccapelo e S. Muratore (curr.), OBL 12, Città Nuova, Roma 2001, p. 68
[7] Cf S. Ragazzini, San Massimiliano Kolbe, Edizioni dell’Immacolata, Pontecchio Marconi (BO) 1999.
[8] Cf R. Pomponio, Salvo d’Acquisto. Il martire in divisa, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2008.
[9] Cf https://it.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak#Biografia consultato l’1-2-2021.
[10] Cf E. Rizzo, Donne disobbedienti, Navarra Editore, Palermo 2019, pp. 24-26.
[11] Di tale capacità di interrelazione B. Lonergan ha fornito numerosi esempi: cf C. Taddei-Ferretti, “Intersubjectivity in the thought of Bernard Lonergan and in cognitive science”, in Ead. (cur.), Going Beyond Essentialism: Bernard J. F.Lonergan, an Atypical Neo-Scholastic, Istituto italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2012, pp. 191-213.
[12] Abbiamo imparato che addirittura, nella Trinità, è sulle relazioni (sussistenti) che si fondano le Persone: cf Tommaso d’Aquino, Summa theologiae I, q 30, a 2, ad 1; q 40, a 2, ad 4.