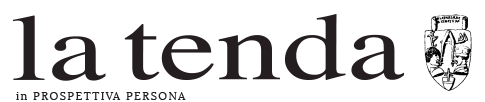Dal Partito socialista al Partito comunista d’Italia

Nel 1892 viene fondato da Filippo Turati il Partito dei lavoratori italiani, che l’anno successivo assume la denominazione di Partito Socialista Italiano. Il nuovo partito si differenzia notevolmente dai gruppi politici, come la Destra e la Sinistra storiche. Questi erano delle aggregazioni, dei movimenti che si possono definire “Partiti di opinione”, basati sulla figura di notabili appartenenti all’aristocrazia e all’alta borghesia, non radicati sul territorio e aventi una base elettorale omogenea, anche perché il suffragio era limitato e censitario; il PSI è invece un “partito di massa”: si regge su uno statuto, un programma ben definito ispirato a una visione ideologica – quella marxista -, una diffusione capillare curata da funzionari, una rigida disciplina. La nascita dei partiti di massa è collegata allo sviluppo industriale e alla crescita del movimento operaio; le prime formazioni socialiste, chiamate da Marx “utopiste”, che avevano dato vita nel 1864 alla I Internazionale, vengono ben presto soppiantate dai gruppi basati sulla teoria comunista di Marx, che domina la II Internazionale (1889). I partiti socialisti uniscono l’obiettivo dei movimenti sindacali, che rivendicano i diritti dei lavoratori, con il fine di una trasformazione rivoluzionaria della società. Ma sulle strategie più adatte a realizzare una società socialista si sviluppano due tendenze, due “anime”, una rivoluzionaria e una moderata, che si contrappongono, ma convivono “dialetticamente” fino allo scoppio della Grande Guerra.
Nel primo quindicennio del ‘900, durante l’età giolittiana, l’Italia attraversa un periodo positivo: l’economia gode di una situazione favorevole, si sviluppa l’industria e con essa cresce anche il movimento operaio, che si organizza nella Confederazione generale del lavoro (CGL); è la belle époque in cui sorgono le avanguardie artistiche e il pensiero positivista preconizza l’inizio di un’età progressiva di benessere e felicità. Ma nel 1914 scoppia la Guerra, una guerra mondiale in cui viene coinvolta anche l’Italia (1915-18), e con la partecipazione alla guerra si accentua la precarietà degli equilibri sociali. Nel dopoguerra, si apre una crisi profonda cui i deboli governi succedutisi nel periodo 1918-19-20 non riescono a far fronte. Negli anni precedenti il titanico sforzo sostenuto con “l’economia di guerra” aveva visto l’industria finalizzata alla produzione di materiale bellico (ricordiamo che in mancanza della manodopera maschile impegnata nella guerra vengono chiamate in fabbrica anche le donne), ora si rende necessaria una riconversione dell’apparato industriale, che provoca nuova disoccupazione. Il rafforzamento dell’industria pesante accentua lo squilibrio fra città e campagna, economia industriale ed economia agraria, mondo operaio e mondo contadino, e ciò si traduce da un lato nella crescita del mondo operaio e dall’altro nell’acuirsi della “questione meridionale”. Le campagne risentono della carenza di manodopera per cui i generi alimentari scarseggiano; mentre aumenta la disoccupazione si chiude lo sbocco dell’emigrazione; è enormemente cresciuto il deficit del bilancio statale, che provoca l’aumento delle tasse; la moneta si svaluta; i prezzi salgono alle stelle; e tutto ciò viene a gravare sul popolo e sulla piccola e media borghesia; viceversa si accrescono a dismisura i profitti dei grandi capitalisti (i cosiddetti “pescecani”), generando un diffuso malcontento.
Tra il 1919 e il 1920 si succedono rivolte e scioperi, che culminano nell’occupazione delle fabbriche: è il “biennio rosso”, che scatena una vampata di panico nella piccola borghesia, gravemente colpita dalla crisi. La classe politica liberale, inadeguata a fronteggiare la crisi chiama al governo il vecchio Giolitti, che, pur risolvendo la crisi jugoslava, scatenata da Gabriele d’Annunzio con l’occupazione di Fiume, non riesce a risolvere i gravi problemi del paese. Il gruppo dei politici liberali si rivela incapace di cogliere la portata dei mutamenti geo-politici conseguenti alla caduta di imperi secolari (Russo, Austrico, Ottomano e Tedesco), e dei nuovi equilibri internazionali dovuti sia all’impegno militare ed economico americano nella guerra, sia a una accentuata internazionalizzazione del grande capitale, sia alla situazione venutasi a creare in Russia con la rivoluzione comunista. Nelle trattative di pace Orlando, capo del governo, e Sonnino, ministro degli esteri, si dimostrano inadeguati a trattare e contrattare le clausole dei trattati di Versailles con le altre potenze vincitrici, scontentando l’opinione pubblica e coloro che si erano impegnati nel conflitto, e dando vita la mito della “vittoria mutilata”.

Di fronte alla difficile situazione in cui si viene a trovare l’Italia emergono i contrasti nel partito socialista tra la parte moderata, “riformista”, che pur mirando alla trasformazione radicale dell’ordine sociale, intende raggiungerla in modo graduale, e la fascia rivoluzionaria, ”massimalista”, che guarda al modello sovietico e propende per una rivoluzione proletaria immediata, senza compromessi con le altre forze democratiche. Dopo il Congresso di Bologna del 1919 viene liquidato il gradualismo riformista a favore della posizione massimalista; ma i contrasti diventano più violenti e non più componibili seguito al fallimento dell’occupazione delle fabbriche. Nel Congresso socialista di Livorno (15-20 gennaio 1921), i delegati torinesi raccolti intorno all’Ordine Nuovo (quotidiano sorto nel ’19 su ispirazione di Antonio Gramsci), e il gruppo napoletano capeggiato da Amadeo Bordiga, abbandonano l’assemblea e danno vita al Partito Comunista d’Italia – sezione della III Internazionale (Internazionale Comunista o Comintern), sorta nel 1919 per volere di Lenin e subordinata al PCUS.
Il partito comunista sovietico si presenta come partito di massa e partito di classe, in cui ha grande rilevanza l’aspetto teorico, la dottrina di Marx, rivisitata da Lenin: nel marxismo-leninismo viene rimandato il raggiungimento della società socialista, senza classi, cioè la parte utopistica del marxismo, così la rivoluzione si ferma alla “dittatura del proletariato”; l’internazionalismo paritario viene sbilanciato verso l’affermazione del Paese guida e del partito guida; la rivoluzione sovietica si propone come modello per tutti gli altri partiti dell’occidente. Infatti sul modello sovietico si afferma anche in Italia una struttura rigida e centralizzata, regolata da uno statuto e formata da funzionari che sono politici di professione. L’azione politica è stabilita dai congressi e dal comitato centrale, e attuata dagli uffici e dalle segreterie locali, le federazioni provinciali e le sezioni locali. La posizione teorica del PCd’I è basata sulla dottrina marxista-leninista, esplicitata nel Rapporto sul fascismo del 1924 di Bordiga, che rimane segretario dal 1922 al ’24: creazione della società comunista, cioè presa del potere e collettivizzazione dei mezzi di produzione; rifiuto di alleanze con altri partiti democratici e antifascisti, in quanto questi hanno una base sociale comune al fascismo; costituzione di una struttura di partito gerarchizzata e capillare, basata sulle cellule create nel luogo di lavoro, sul modello sovietico. Questa posizione viene poi in parte abbandonata perché troppo dogmatica.
Intanto dopo la marcia su Roma si insedia un governo fascista, mentre continuano le intimidazioni contro la sinistra. Il rapimento e l’uccisione di Giacomo Matteotti provoca una crisi con cui si devono confrontare le opposizioni antifasciste, che reagiscono con la “secessione dell’Aventino”, ma senza alcun risultato. Il rafforzamento di Mussolini sarà seguìto da una serie di provvedimenti, a partire dal dicembre 1925 (leggi fascistissime), fra cui lo scioglimento dei sindacati e dei partiti non fascisti. Nel 1926 il Congresso comunista si tiene a Lione dove, sulla base delle “tesi” presentate da Gramsci, si prende atto della particolarità e novità del fascismo e della situazione conseguente all’emanazione delle leggi speciali. Vengono accettate le regole del Comintern ed è ribadito il programma rivoluzionario, ma si riconosce la peculiarità del comunismo italiano. Il partito rimane subordinato al PCUS che si ritiene non solo espressione del proletariato, ma anche avanguardia e parte cosciente di esso; vuole essere il partito guida basato su un sistema di cellule che riuniscono gli iscritti nello stesso luogo di lavoro: officina, fabbrica, cantiere, etc., in cui gli iscritti vengono diretti e controllati dai funzionari locali; ma il comunismo italiano se ne differenzia perché si basa sulle sezioni territoriali. In tal modo riesce a radicarsi nel territorio, facendo maggiore presa sulle masse, e può svolgere una intensa attività anche in clandestinità. Antonio Gramsci, incarcerato nel 1926, continua ad approfondire la sua concezione politica, anche alla luce della tradizione culturale e artistica italiana e lascia le sue riflessioni nei Quaderni dal carcere, in cui delinea la visione di un partito, riconducibile ad alcune idee chiave: il marxismo come filosofia della prassi; il partito capace di esercitare una egemonia non solo politica, ma anche culturale, tenendo conto del patrimonio storico e culturale dell’Italia; il partito “moderno principe”, mutuando tale definizione dal pensiero di Machiavelli, cui dedica una attenta riflessione.