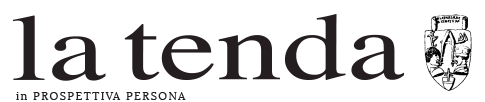Da geografo, condivido l’urgenza manifestata nella Proposta di un manifesto per l’innovazione della conoscenza storica. Per ragioni di brevità, mi soffermerò su cinque questioni che ritengo di nodale importanza tra quelle sollevate da Carlo Ruta. Esse sono:
1) nel mondo contemporaneo ci troviamo a soffermarci su quelle che Carlo Ruta chiama chiusure iperidentitarie, e cioè, richiamando le sue parole, con le «logiche di risentimento e paura, che portano ancora a concepire il portatore di differenze come antagonista e, si potrebbe dire, ‘ladro di risorse’». Un sentire, ahimè, diffuso oltre ogni previsione nelle diverse società umane;
2) invece di attardarsi ulteriormente all’interno di un impianto teorico ed epistemologico espresso dalle scienze storiche, sociali e umanistiche del XX secolo (si pensi ad esempio al dibattito postmoderno), si impone la necessità di accelerare il passo e produrre nuove rotture paradigmatiche;
3) tali rotture non possono che maturare nella zona di confine tra la ricerca storica, le scienze sociali e quelle naturali;
4) occorre misurarsi, dice Carlo Ruta, con «le tre prospettive che reggono, avvolgendola, l’esperienza umana: il contatto con la natura, il confronto con il mondo sociale e il rapporto con la storia, che, come dimensione del passato, in ogni persona è costume, memoria, lingua, background culturale, senso e misura del tempo, in definitiva, percezione orientata del sé;
5) il ruolo della mobilità nelle società contemporanee, ovvero, come osserva Carlo Ruta, la mobilità sfuggente dell’oggetto che evoca poi una ulteriore mobilità, quella del punto di vista (mobilità dello sguardo).
Tratterò tali questioni in un ordine che mi sarà dettato da un percorso, condiviso da un gruppo di ricerca internazionale, interdisciplinare e intergenerazionale che per anni ha coinvolto anche uno sparuto drappello di geografi nell’ambito del Dipartimento Culture e società dell’Università degli studi di Palermo.
Sguardo cosmopolita e geografie dell’ascolto
Il vertiginoso accavallarsi di processi di crisi e mutazione degli equilibri economici, degli assetti politici e delle dinamiche culturali in atto ha costretto tale gruppo di ricerca – formatosi in un contesto regionale, come la Sicilia, fortemente esposto alle prorompenti e spesso tragiche vicende che anche da orizzonti lontani si sono scaricate sul mondo mediterraneo – a interrogarsi sul proprio posizionamento etico e scientifico rispetto ai fenomeni da analizzare e alle strategie d’azione da adottare. Sotto i nostri occhi si snodava un film molto più impressionante delle Torri Gemelle: una strage di migranti per i continui naufragi avvenuti nelle acque del Mediterraneo. È avvenuto così che un gruppo di studiose e studiosi, che si era raccolto attorno al programma di ricerca nazionale dedicato alla «Città cosmopolita», ha dovuto a più riprese ridefinire sia il metodo che gli obiettivi della ricerca fino a comprendere che la diaspora mediterranea in corso costituisse una vera e propria sfida epistemologica.
Mostrare una mutazione in atto, a livello globale, degli assetti urbani e territoriali era l’intento iniziale di tale gruppo di studiose e studiosi. Si trattava di un gruppo ampio e articolato. Un’équipe transnazionale di ricerca coordinata da Ola Söderström aveva, infatti, scelto Palermo per indagare sull’intreccio tra la dimensione culturale e quella urbana dei processi di globalizzazione. Urban Cosmographies. Indagine sul cambiamento urbano a Palermo ha mostrato con evidenza come nel capoluogo siciliano fosse in atto un processo che esponeva la città a flussi globali di persone, idee e capitali e inscriveva entro gli spazi della sua vita quotidiana nuovi paesaggi e regimi urbani cosmopoliti. Le azioni di governance urbana messe in atto da due amministrazioni della città di segno opposto vennero così valutate alla luce del complesso dei flussi di mobilità di persone, conoscenze e capitali che tali politiche erano state in grado di intercettare. Leggendo questo lavoro e le immagini che lo corredano, ciascuno potrà formarsi un proprio giudizio sull’efficacia di tali politiche, ma non potrà comunque negare che dall’uno e dalle altre scaturisce un’immagine inedita della città. Gli artefatti urbani attivano luoghi di contrasto e nuovi posizionamenti identitari ma, se reinscritti nelle catene d’azione che li generano, essi svelano le retoriche cui si ispirano le diverse pratiche di governance urbana e i regimi urbani cosmopoliti a esse correlati. Il caso di Palermo è stato poi rivalutato dallo stesso Söderström in un quadro comparativo a scala globale con altre dinamiche urbane in contesti asiatici e africani.
In parallelo si è sviluppata un’altra esperienza di ricerca che ha promosso un quadro di comparazioni a scala, questa volta, nazionale. La composizione del gruppo di ricerca ha consentito di mettere a fuoco dinamiche in atto in città di diverse dimensioni, dalle grandi alle medie, e dislocate sia al Nord (Venezia e Trieste) che al Centro (Bologna e Pisa) che al Sud d’Italia (Palermo e Bari). Si è potuto così constatare quanto diffusa e capillare fosse la mutazione in atto nel nostro Paese. Una metodologia innovativa basata sui sopralluoghi e sulle pratiche dell’ascolto attivo ha consentito di esplorare, inoltre, i diversi contesti urbani nelle pieghe più intime della vita quotidiana e di valutare quanto fosse profondo il grado di coinvolgimento delle popolazioni e dei luoghi indagati in un processo di transizione che coinvolgeva il locale e il globale proprio al confine tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Aprendosi ad altre esperienze disciplinari, il gruppo di Palermo giungeva alla comprensione di quanto traumatica e spaesante fosse la transizione in atto e di quanto ineludibile la necessità di adottare una strategia di ricerca innovativa. La diaspora mediterranea s’impose, così, come asse portante dell’esperienza di ricerca e dei suoi prodotti a stampa e come fuochi tematici di due eventi cui si decise, come vedremo, di dare vita all’insegna de La città cosmopolita.
La compressione spazio-temporale aveva prodotto contesti urbani e territoriali il cui profilo non poteva essere descritto senza adottare uno «sguardo cosmopolita». Senza mettere, cioè, in discussione quel «nazionalismo metodologico» che è, per così dire, congenito alle scienze sociali e territoriali e che consiste nel considerare ogni evento di natura socio-spaziale entro l’orizzonte costituito dai singoli Stati nazionali e dalle loro frontiere. Nel corso della ricerca il gruppo locale di Palermo è pervenuto alla convinzione che, piuttosto che esporre i paesaggi urbani a uno sguardo cosmopolita, una strategia più appropriata s’imponesse e che si dovessero sondare le opportunità metodologiche offerte dalle «geografie dell’ascolto. Procedere dunque per sopralluoghi, esplorare quelle che Clifford chiama «zone di contatto» e provare a costruire «luoghi dell’ascolto», situazioni e contesti, cioè, in cui la narrazione autobiografica fosse resa possibile dall’interazione tra intervistatore e intervistato. Il mondo vissuto dei migranti incontrati nel corso dell’inchiesta si dimostrava così intenso, sofferto e partecipato da sconsigliare ogni forma di generalizzazione o di astrazione. Il valore di ogni singola esistenza umana, che emergeva dalle interviste, era tale da imporsi come qualcosa di singolare e non sovrapponibile alle altre esperienze. La stessa diaspora mediterranea, da esodo di massa, si diversificava e frastagliava così in una varietà e molteplicità di esperienze soggettive.
Praticare le geografie dell’ascolto acquisiva il senso di misurarsi non con fenomeni collettivi quanto piuttosto con orizzonti di eventi specifici e singolari. Tutto questo induceva anche noi stessi ad assumere, rispetto al campo della ricerca e alla drammaticità delle esperienze di cui siamo diventati testimoni, un atteggiamento che non poteva che ispirarsi all’icastica frase di Michel Foucault: «La sofferenza degli esseri umani non deve mai essere un residuo muto della politica» e a fare nostro il programma d’azione enunciato dal pensatore francese: «non siamo altro che singoli individui che parlano, e lo fanno insieme, unicamente a titolo di una certa comune difficoltà a sopportare quanto accade».
L’orizzonte di eventi mediterranei
Il Mediterraneo descrive attorno a noi un orizzonte di eventi. Non sono due i mondi che entrano in contatto, né quattro (Nord/Sud, Est/Ovest) ma molti in una combinazione plurale – per dirla con Roberto Esposito –, e sempre mobile di singolarità. Per cogliere l’eco di tali eventi, per raccoglierne i molteplici segnali, le scienze storiche e sociali devono assumere posture nuove e dimostrarsi sensibili a ciò che è mobile, singolare e plurale al tempo stesso. Nelle pagine che seguono proverò ad articolare un discorso sulle nuove geografie, quelle che chiamerò «geografie dell’ascolto». Nella speranza che da esse si possa accedere a qualcosa che accade all’incrocio tra l’altra vita e un mondo altro.
Le politiche europee nei confronti di migranti, rifugiati politici e richiedenti asilo disegna attorno a noi un tragico orizzonte di eventi. Ciascuno di essi, nello stillicidio della successione, merita di essere affrontato per il valore che ha in sé, ma la serie assume una rilevanza tale da indurre ad adottare la più pregnante parola «strage» e tende ad assumere i connotati di un vero e proprio crimine contro l’umanità.
Pensare ogni singolo evento – e il luogo – rappresenta una sfida sia per il pensiero filosofico sia per la ricerca geografica in quanto comporta la necessità di operare uno sfondamento nel regime di pensiero consolidato e confrontarsi con una situazione paradossale. L’elemento chiave, che mi preme sottolineare, è che il pensiero critico si attiva quando ci si trova in presenza di una relazione paradossale, cioè di una relazione che non è tale. Riuscire a pensare insieme il dramma del naufragio e la banalità della vita quotidiana non è così semplice, né naturale, perché c’è un mare che li separa. Un mare che oggi funziona come una frontiera.
Il gruppo di ricerca, però, si convinse ben presto che un obiettivo così ambizioso come pensare in forme inedite un evento, che si ripeteva con ossessiva cadenza sotto gli occhi di tutti (e nell’indifferenza di tanti) non potesse realizzarsi all’interno della ristretta arena della comunicazione scientifica. Per operare lo sfondamento, occorreva confrontarsi con una platea più vasta. Ecco perché il programma di ricerca aveva avuto inizio con due edizioni (2006 e 2007) di un evento denominato, come abbiamo visto, La città cosmopolita, in cui s’intrecciavano i momenti del dibattito scientifico, i sopralluoghi in «zone di contatto» e manifestazioni pubbliche comprendenti spettacoli, musica e performance artistiche.
Topografie diasporiche
Se non si pongono spazio e luogo in opposizione, fare del mapping equivale a disegnare un orizzonte di eventi. E tale orizzonte altro non è che un universo di senso. Anzi, universi di senso. Il plurale è d’obbligo, in quanto attorno a ciascun evento si dispiegano molteplici universi di relazioni. Il singolo evento non ha significato e valore per sé, ma lo acquista entrando in relazione con gli altri. Se assumiamo che il luogo è l’evento. Allora, ad un estremo troviamo il luogo, all’altro estremo, il mondo. Cioè, ad un estremo, gli eventi la cui ripercussione si esaurisce alla scala locale, all’altro estremo, gli eventi la cui eco si estende al mondo intero, cioè alla scala globale. Ma tra l’uno e l’altro estremo si dispiegano orizzonti di senso, cui noi abbiamo accesso in virtù delle scelte che operiamo. Non tutti gli eventi sono alla nostra portata. Ecco perché assume valore euristico la nozione di «orizzonte». Ogni volta che il pensiero e l’azione, che ne deriva, operano uno sfondamento, si amplia l’orizzonte di vita a cui abbiamo accesso.
Il movimento ha – come dice Chiara Giubilaro – un ruolo decisivo in tutto questo. È, per così dire, il moltiplicatore e il differenziatore dei luoghi. Quando due esseri umani si incontrano – e uno rimane, mentre l’altro parte o arriva – è quest’ultimo a innescare il processo e scatenare più scie sul suo cammino. Per questo motivo, forzando un po’ le cose, si può affermare che è il movimento a creare lo spazio e i luoghi. Seguiamo il ragionamento di Giubilaro. Il primo richiamo è a Edward Said, il quale si domanda: Ma se invece il mondo fosse cambiato così drasticamente da consentirci oggi, forse per la prima volta nella storia, una nuova coscienza geografica, decentrata e/o multicentrica, restituendoci la consapevolezza di un mondo non più confinato nei compartimenti stagni dell’arte, della cultura e della storia, ma mischiato, confuso, vario, complicato dalla nuova e complessa mobilità delle migrazioni, da nuovi stati indipendenti, da nuove culture emergenti?
Si tratta, dunque, di alimentare una nuova coscienza geografica a partire da quei luoghi, disseminati per il mondo, in cui s’impara fin da piccoli che essere cittadini del mondo vuol dire assistere senza paura alla diaspora dei luoghi, oltre che delle persone: «Essendo stati portati attraverso il mondo […] sono uomini e donne traslati». Riconoscersi come persone che appartengono a più di un mondo, parlano più di una lingua (letteralmente e metaforicamente) abitano più di un’identità, hanno più di una casa; che hanno imparato a tradurre tra le culture, e che, essendo irrevocabilmente il prodotto di molte e intercomunicanti storie e culture, hanno imparato a vivere, anzi a parlare con la ‘differenza’. Parlano dalla ‘via di mezzo’ tra le differenti culture, sempre rimuovendo i presupposti di una cultura dalla prospettiva di un’altra, e trovando così il modo di essere ‘uguali’ e ‘differenti’ dagli altri in mezzo a cui vivono.
L’esperienza dell’esilio è cruciale in tutto questo: «L’esilio è qualcosa di singolarmente avvincente a pensarsi, ma di terribile a viversi. È una crepa incolmabile, per lo più imposta con forza, che si insinua tra un essere umano e il posto in cui è nato, tra il sé e la sua casa nel mondo. La tristezza di fondo che lo definisce è inarrivabile».
Ma cediamo di nuovo la parola a Chiara Giubilaro: «Se il movimento, dunque, rappresenta la caratteristica costitutiva del soggetto e dell’esperienza migrante, è opportuno provare a soffermarsi sulla sua definizione e sulle implicazioni ad esso connesse. Il movimento è l’azione di muoversi da un punto ad un altro, ed implica sempre una dislocazione (displacement), uno spostamento da un luogo ad un altro. Spazio e tempo si compongono in ogni evento dinamico secondo modalità interessanti. Il movimento – scrive Cresswell – non è altro che una spazializzazione del tempo e una temporalizzazione dello spazio. È, potremmo dire, un tempo percorso e uno spazio trascorso, richiama cioè una durata e una distanza, e le fa coincidere. Ogni spostamento distende lo spazio sull’asse del tempo, lo trasforma in linea, o meglio, in segmento, come risulta evidente in ogni sua rappresentazione visuale. Ma il movimento a cui qui ci richiamiamo è ben lontano dall’astrattezza nella quale considerazioni come quelle appena fatte potrebbero confinarlo. Al di là delle figure e dei modelli utilizzati negli spazi della rappresentazione e nei discorsi che a questi si rifanno, infatti, spostamenti e dislocazioni sono anzitutto esperienze corporee (embodied experiences), fisiche e concrete.
Sin qui mi pare di avere chiarito il nesso tra le città cosmopolite, le nazioni plurali e le esperienze del limite. La comprensione degli eventi in un orizzonte così mobile presuppone quella che Carlo Ruta chiama «mobilità dello sguardo» e noi «geografie dell’ascolto». Presuppone cioè la capacità di misurarsi con l’universo sconfinato delle narrazioni, di cui esuli e migranti sono straordinari interpreti. Soggetti migranti e intellettuali di frontiera sono stati i veri protagonisti dei due volumi dedicati a La città cosmopolita.
And So Europe Deshumanized Itself: performance artistica e convegno internazionale
Nel 2014, ancora una volta, una performance artistica ha dato avvio a un nuovo stadio della ricerca. Questa volta l’iniziativa fu assunta da Giulia de Spuches che decise di organizzare un evento aperto a un pubblico di non addetti ai lavori. Mise in scena con attori, musicisti e una cantante un evento teatrale dal titolo «And So Europe Deshumanized Itself». L’efficacia dello spettacolo si fondava sul ricorso alla lettura di pagine altamente drammatiche di Beloved di Toni Morrison, creando una connessione emotiva e intellettuale tra il dramma della schiavitù e lo sconvolgente destino cui le politiche europee espongono i migranti. In entrambi i casi, l’esercizio del potere è così violento e prevaricante da compromettere l’umanità non soltanto di chi lo subisce, ma anche di chi lo pone in essere.
Il momento scientifico seguì nel novembre del 2015 e fu convocato attraverso una Call for Action, nella consapevolezza che le parole del discorso scientifico non fossero più sufficienti a opporre resistenza all’ondata di xenofobia e nazionalismo avanzante e che occorresse mettere in campo più decise azioni di contrasto. I convegnisti si sforzarono di elaborare un nuovo linguaggio e nuove pratiche, nella consapevolezza del fatto che l’impegno scientifico e politico messo in atto negli anni precedenti non facesse più presa sull’opinione pubblica, sopraffatto da parole d’ordine certo più rozze, ma di gran lunga più pervasive, ovvero le «chiusure iperdidentitarie» di cui parla Carlo Ruta. Il gruppo dei geografi palermitani che aveva promosso l’iniziativa, raccolse quanto emerso dalla discussione e gli fece prendere la forma del Manifesto e che è stato riproposto nel corso del XXXII Congresso geografico di Roma (7-10 giugno 2017) nella sessione «Il Mediterraneo: per una geografia critica della frontiera» coordinata da C. Brambilla, A. Casaglia, R. Coletti, P. Cuttitta, G. de Spuches e V. Guarrasi.
Dopo la complessa azione performativa messa in atto con La città cosmopolita, in cui per la prima volta provavamo a confrontarci con un pubblico costituito non soltanto da addetti ai lavori, il Manifesto And so Europe Dehumanized Iteself segnò una ancora più forte esposizione al contemporaneo e alle sue contraddizioni. Nacque dalla consapevolezza del trovarsi in Sicilia in una vera zona di frontiera, luogo dello scontro e della spettacolarizzazione di alternative e conflittuali visioni del mondo e della vita.
La nostra terra brucia
Quando si parla di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, da qualche anno sentiamo riproporre una improbabile distinzione tra chi fugge dittature, guerre, persecuzioni politiche e chi, invece, non è altro che un migrante economico. Tale distinzione artificiosa è funzionale a delle politiche che tendono – sulla carta ovviamente – ad accogliere i primi e respingere i secondi. Fatica a farsi strada una più pregnante espressione, quella di «profughi ambientali», che nella realtà tende a coprire la gran parte delle attuali e future generazioni di migranti. A causa del riscaldamento globale, i fenomeni più estremi – siccità, alluvioni, perdita di fertilità dei terreni, desertificazione, ecc. – tendono a essere sempre più frequenti in ogni parte del globo, ma in alcune aree manifestano particolare virulenza. Chi abbandona la propria casa e la propria famiglia spesso è forzato a farlo dal fatto che la terra, in cui è sempre vissuto e da cui ha tratto sostentamento, è diventata inospitale, di fatto inabitabile. Perché stenta a farsi spazio un’espressione che pure sembra attagliarsi a un alto numero di spostamenti? Il motivo è lo stesso, ritengo, che ha portato una parte del mondo politico e pubblicistico ad adottare termini meno appropriati alla realtà attuale – cambiamento climatico piuttosto che riscaldamento globale, migranti economici piuttosto che rifugiati ambientali – e meno cogenti rispetto alle politiche da adottare. Mutamenti del clima ce ne sono sempre stati, ma l’attuale riscaldamento globale è un fenomeno inedito, le cui responsabilità sono chiaramente da imputare all’azione umana.
Eppure, che il riscaldamento globale sia la priorità assoluta, anche per i tempi ristretti che impone all’agire umano, è una convinzione e un sentire profondo che tende a diffondersi tra la popolazione in ogni angolo della superficie terrestre. Soprattutto tra i giovani. Ecco perché non può non suscitare sgomento un fenomeno, per cui la Sicilia si presenta ancora una volta come terra di frontiera e di evidenti contraddizioni. Essa, infatti, continua a distinguersi per un fenomeno presente e diffuso in ogni dove, in Italia e nel mondo, ma che nell’Isola mostra una sorta di orrida e beffarda sistematicità: la distruzione ad opera di incendi di natura dolosa del manto boschivo. Le attività distruttive messe in atto ogni qual volta spiri lo scirocco o comunque le condizioni climatiche siano favorevoli alla diffusione degli incendi ci hanno indotti a pubblicare una petizione, promossa da Giovanna Soffientini e da me, su un canale dedicato, change.org, che in pochi giorni ha raccolto più di 4.000 firme. La petizione intitolata «La nostra terra brucia: appello alle Siciliane e ai Siciliani» così recita:
«La nostra terra brucia. Da ieri sera, per tutta la notte. Dappertutto. Vanno in cenere interi boschi, la macchia mediterranea, ogni copertura vegetale. La nostra terra si spoglia del suo manto protettivo e siamo tutti più indifesi di fronte all’avanzare del riscaldamento globale.
Evidentemente, in questa terra desolata si è dimenticato che l’ambiente della vita è stato creato dalle piante e che questa potenza generativa è all’opera in ogni momento e in ogni dove. Essa costituisce la nostra unica garanzia di sopravvivenza. Come ha magistralmente mostrato Stefano Mancuso ne La nazione delle piante la nostra speranza di vita è, sicuramente, legata alla decisa determinazione umana di smettere di avvelenare l’ambiente con le emissioni dei nostri veleni. Ma questo sforzo da solo sarebbe destinato all’insuccesso se non venisse accompagnato da una nuova alleanza con quel mondo vegetale di cui siamo figli: bisogna arrestare il processo di deforestazione ancora in atto in ogni parte del mondo – pensiamo a quanto sta avvenendo in Amazzonia – e piantare alberi e altre essenze vegetali dappertutto, anche e soprattutto nelle città e metropoli, che ospitano ormai la stragrande maggioranza della popolazione mondiale.
Se vogliamo vivere, se vogliamo che i nostri figli e i nostri nipoti possano vivere, dobbiamo chiedere aiuto a chi ha la potenza di rigenerare ciò che abbiamo colpevolmente distrutto sia sulle terre emerse che nella profondità degli oceani. Le piante sì, lo ribadisco: molto dipende da loro.
Perché tutto ciò avvenga è necessaria una profonda svolta culturale. Una messa in questione del senso stesso d’identità. Al di là delle maschere che indossiamo, non vi è identità che non sia relazionale, non vi è identità che non sia plurale. Anche in questo, le piante ci fanno da modello, esse vivono in comunità di diversi. Cooperano con insetti e animali in un tipo di rapporto in cui la solidarietà batte nettamente il conflitto. La concorrenza lasciamola al mercato e alle sue logiche perverse. Abbandoniamo un darwinismo malinteso che ci induce a pensare all’ambiente naturale come a un mondo in cui tutti sono contro tutti e vince il migliore. Come dice David Quammen ne L’albero intricato, la selezione naturale premia il più adatto e non il migliore. E, comunque, il migliore non siamo certo noi, essere umani, come la storia naturale dimostra a piene mani.
Come sostiene Bruno Latour ne La sfida di Gaia, a forza di cure, si può guarire dalla convinzione che noi non apparteniamo al mondo, che quel che accade al mondo non ci riguarda. Ci riguarda, eccome. E dobbiamo imparare a prendercene cura. Soltanto così potremo imparare a guarire noi stessi: è un compito impellente, soprattutto in Sicilia, dove agli effetti devastanti del riscaldamento globale, dovuto all’azione umana su scala globale, si sommano le azioni criminali di quanti per perseguire i propri miopi personali interessi continuano a distruggere quanto di più prezioso ci circonda e ci sostiene e la colpevole latitanza delle istituzioni, che continuano a lamentare i danni, ma non mettono in atto alcuna azione di contrasto significativa rispetto a un fenomeno le cui modalità sono assolutamente ripetitive e prevedibili in ogni occorrenza.
Come avvenne, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, si richiede oggi una mobilitazione straordinaria dei Siciliani per interrompere questa nuova stagione di stragi. Iniziamo, prendendo a modello Danilo Dolci e organizziamo uno sciopero alla rovescia, che consista nel piantare alberi luoghi della Sicilia che abbiano un grande valore simbolico (…).»
La rottura paradigmatica: fare appello alle piante per riscoprire il senso della solidarietà e della cooperazione
Eccola qui la rottura paradigmatica: l’ambiente dell’esperienza umana si qualifica come una sottile pellicola, che ospita la vita. Ma questo sottile strato biotico, che fa del pianeta Terra un apax, osserva Bruno Latour ne La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico, non è il prodotto né del caso né della necessità. Come scrive Stefano Mancuso ne La Nazione delle piante, esso è il frutto di un processo di creazione e di manutenzione costante da parte delle piante. Il punto sta proprio qui: il pur breve percorso evolutivo – tale appare se commisurato alla scala del mondo abiotico – che ha interessato la comparsa e la diffusione della vita sulla Terra ha come protagonista assoluto il mondo vegetale. Esso prevale sul mondo animale, non soltanto per il suo ruolo attivo e generativo, ma anche per la durata e per la dimensione quantitativa. E non finisce qui, le piante costituiscono la nostra unica opportunità di sopravvivenza di fronte alla sfida epocale che ci troviamo dinnanzi:
«Che dalle piante dipende la nostra unica possibilità di sopravvivenza dovrebbe essere insegnato nelle scuole ai ragazzi e agli adulti in ogni altro luogo. I registi dovrebbero farne film, gli scrittori libri. Chiunque è chiamato a mobilitarsi, e se credete che stia esagerando e non vedete alcun vero motivo per alzarvi dal divano per difendere l’ambiente e le foreste, sappiate che questa è l’unica, vera, emergenza mondiale. La maggior parte dei problemi che affliggono l’umanità oggi, anche se apparentemente lontani, sono collegati al pericolo ambientale e rappresentano gli innocui prodromi di ciò che verrà se non l’affronteremo con la dovuta fermezza ed efficienza.
Le piante possono aiutarci. (…) Le nostre città (…) dovrebbero essere completamente ricoperte di piante. Non soltanto negli spazi deputati: parchi, giardini, viali, aiuole, ecc. ma dappertutto, letteralmente: sui tetti, sulle facciate dei palazzi, lungo le strade, su terrazze, balconi, ciminiere, semafori, guardrail ecc. La regola dovrebbe essere una sola e semplice: dovunque sia possibile far vivere una pianta, deve essercene una. La cosa non richiederebbe che costi irrilevanti, migliorerebbe in una miriade di modi la vita delle persone, non esigerebbe nessuna rivoluzione nelle nostre abitudini, come molte altre soluzioni alternative proposte e avrebbe un grande impatto sull’assorbimento di CO2. Difendiamo le foreste e copriamo di piante le nostre città, il resto non tarderà a venire».
Pur avendo immaginato per millenni di essere le creature più perfette dell’universo, abbiamo irresponsabilmente attivato un processo di distruzione dell’ambiente che ci circonda e dona la vita. Il riscaldamento globale rappresenta un processo che noi, esseri umani, abbiamo innescato e non siamo più in grado di arrestare. Anche se riuscissimo a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti in importanti eventi internazionali alla scala globale, il sistema delle azioni e delle reazioni di fatto scatenato con il consumo massiccio di combustibili fossili negli ultimi secoli farebbe sì che questi sforzi non sarebbero comunque sufficienti a garantire l’arresto della sesta estinzione di massa di specie in atto sulla superficie terrestre. Soltanto l’ausilio da parte delle piante, come abbiamo visto, potrebbe contribuire a riparare e restaurare una situazione già in larga parte compromessa.
Perché non riusciamo a prendere atto della scarsa rilevanza dell’umano rispetto all’incidenza positiva del mondo vegetale? Forse ciò dipende dal fatto che non abbiamo del tutto assorbito le tre ferite narcisistiche di cui parlò a suo tempo Sigmund Freud e tanto meno siamo disposti ad accettare che ce ne venga inferta una quarta. Per comprendere fino in fondo la lezione delle piante e configurare l’umano entro lo sfondo della grande storia disegnata dal mondo vegetale nella conquista della Terra, bisogna prima rivivere i tre traumi che secondo Freud hanno caratterizzato la formazione stessa della cultura occidentale moderna:
«… dapprima Copernico, poi Darwin e infine Freud stesso. Tre volte di seguito l’arroganza umana sarebbe stata profondamente ferita da scoperte scientifiche: la prima volta, dalla rivoluzione copernicana che avrebbe scacciato l’uomo dal centro del cosmo; poi, straziata ancora più a fondo dall’evoluzione darwiniana che ha fatto dell’umano una specie di scimmia nuda; infine, per la terza volta, dall’inconscio freudiano che avrebbe espulso la coscienza umana dalla sua posizione centrale.»
Sono riti di passaggio, per così dire, di cui è lastricata la strada che ci porta verso una visione adulta del nostro posto nel mondo.
Lo stesso Bruno Latour, però, integra il processo di promozione di nuove rotture paradigmatiche, quando ci suggerisce come l’ambiente non possa più essere interpretato come qualcosa di inanimato. In chiave geostorica non soltanto viene rimesso in questione il rapporto tra le società umane e il contesto in cui esse vivono. Quest’ultimo non costituisce lo sfondo e la cornice in cui la storia umana e i conflitti sociali prendono forma, ma si anima di una serie d’intenzionalità tali da mettere in forse la distinzione tra soggetti umani e non umani.
Soltanto se assumiamo coscienza della pluralità e singolarità degli agenti in gioco, possiamo comprendere la lezione che proviene dalla Nazione delle piante.
Qui, però, il discorso di Latour si fa più impervio, soprattutto quando, sulla scia di Lovelook e di Pangulis, prova a spiegare la sibillina frase: «There is only one Gaia, but Gaia is not One». Una visione olistica di Gaia ci indurrebbe a sottovalutare la sua più importante proprietà: essa non funziona come un superorganismo che tutto contiene e comprende, quanto piuttosto come la risultante mobile, fluida, complessa e imprevedibile di un pullulare continuo e costante di una molteplicità di agenti, ciascuno dei quali appare mosso da una propria intenzionalità:
«In senso stretto, per James Lovelock e ancora più chiaramente per Lynn Margulis, non esiste più ambiente a cui potersi adattare. Poiché tutti gli agenti viventi seguono costantemente le loro intenzioni, modficando i loro vicini quanto più possibile, è del tutto inconcepibile discernere quale sia l’ambiente a cui l’organismo si adatta e quale sia il punto in cui la sua azione cominci.»
Quando incrociamo Mancuso e Latour, ne deriva una miscela esplosiva: se il primo ci ricorda che, attraverso la sintesi clorofilliana, le piante hanno messo a disposizione degli altri viventi l’ossigeno, presupposto della loro vita, il secondo, affermando che l’ossigeno è pur sempre tossico, mutageno e probabilmente cancerogeno e che per questo fissa un limite alla durata della vita, ricorda però, al tempo stesso che fu proprio la disponibilità di un po’ di ossigeno, alla fine dell’Archeano, a modificare la chimica dell’ambiente e ad innescare la mutazione dei primi ecosistemi di allora.
Le implicazioni di questa miscela non possono sfuggire ai cultori della ricerca storica e delle discipline sociali e umane: ora sì che comprendiamo perché la vecchia storia evenemenziale aveva comunque una presa sull’animo umano: «tutto quel che accade non accade che una volta sola, non accade che a noi, qui». Sta tutto in quel «qui», la dimensione locale dell’esistenza esplode con forza incomprimibile nel divenire globale del mondo. Si fondono così locale e globale, naturale e culturale, e precipitano insieme con la stessa forza rivelata nel mondo fisico dalla scissione dell’atomo. Tutto ciò appare difficile, anzi quasi impossibile da governare entro un quadro teorico ed epistemologico coerente, che potremmo chiamare geostorico, ma dobbiamo comunque provarci. Come accade a tutti i viventi, anche ai ricercatori non è dato sottrarsi alla dittatura della contingenza. Si suole dire d’altronde: hic Rodus, hic salta!